Nell’ambito della selezione del personale nelle grandi aziende si usano spesso formule come competenze verticali e competenze orizzontali per intendere le capacità specifiche di un lavoratore in un determinato ambito di competenza (le prime), e l’insieme di abilità interpersonali e soft skill che permettono di far interagire la propria specializzazione con altri lavoratori (le seconde). Con un leggero abuso di notazione, possiamo trasporre questo gergo anche per descrivere due possibili, e talvolta mutualmente esclusivi, modi di intendere l’esplorazione musicale. Da una parte l’ascolto verticale, più settoriale e tipico di specialisti di scene e/o generi specifici che sono poco attenti (o in determinati casi anche apertamente ostili) a ciò che la musica può offrire all’infuori di quel fazzoletto di sonorità; dall’altra parte, l’ascolto orizzontale, più interessato a spaziare e a conoscere un po’ di tutto utilizzando un qualche arbitrario canone di opere ritenute “classiche” come mappa per costruire una rete concettuale di interconnessioni tra musicisti, generi, epoche diverse e distanti. Per entrambi i profili, si presuppone comunque un desiderio di ricerca attiva e più o meno assidua di nuova musica – parliamo, quindi, di legittimi appassionati in ogni caso, che semplicemente affrontano l’approfondimento musicale in modi quasi agli antipodi.
Pur essendo ovviamente una modellizzazione rozza, per non dire stereotipata, sono certo che gran parte dei nostri lettori si riconosceranno maggiormente nella figura dell’ascoltatore c.d. orizzontale. In un certo senso è inevitabile: la narrazione della musica popolare (e di parte del jazz e della musica colta occidentale) portata avanti dal discorso critico anglofono e americano, quello più influente sul pubblico alternativo qui da noi, è stata fondata interamente su un’idea posticcia e piuttosto artificiale di “storia della musica”, costruita a suon di classici scelti da un pool discretamente vasto di generi e spesso pure riscritta a posteriori seguendo una precisa strategia teleologica volta a giustificare precisamente la musica che ci piace adesso – o, comunque, ad accomodare i paradigmi etici ed estetici largamente condivisi nell’attualità. È il principio per cui Pitchfork recensisce e insignisce del titolo di best new reissue i primi tot dischi dell’Incredible String Band e tra i principali motivi che riesce a trovare per giustificarne la rilevanza nel 2010 non c’è tanto il fatto che siano creativi e divertentissimi e senza tempo (anche perché uno viene persino bocciato) ma il fatto che piacciano a Joanna Newsom e ai Neutral Milk Hotel – cito testualmente:
There remain plenty of reasons to think about the ISB in 2010, not the least of which are the raves garnered by the likes of Joanna Newsom and Grizzly Bear. Messy, schoolyard orchestras like Neutral Milk Hotel and the Decemberists owe a debt as well.
Ancora, è il principio per cui sempre Pitchfork nel 2018 stila una classifica dei 200 migliori dischi anni Ottanta e – contraddicendo vent’anni di militanza nell’indie rock più infrattato – realizza una top 20 dominata da dischi di hip hop e pop black che, casualmente, sono proprio i dischi che più hanno impattato sull’hip hop e sulla black music che domina il mainstream anni Dieci, da Kendrick Lamar fino a Rihanna. Molti di questi sono anche dischi bellissimi, ma che credibilità ha Pitchfork che inserisce Thriller di Michael Jackson come secondo album più grande degli Eighties? A pensar male si fa peccato eccetera eccetera.
Tuttavia, è innegabile che una rappresentazione della storia della musica (pop) di questo tipo eserciti un certo fascino, e abbia anche i suoi indiscutibili vantaggi. Avere una costellazione di “dischi da ascoltare prima di morire” (o di “pietre miliari”, o qualsiasi formula vogliate usare per intendere il concetto) è rassicurante se non consolatorio, offre la possibilità di navigare decenni di uscite discografiche la cui quantità aumenta esponenzialmente anno per anno tendendo la mano all’utente e dicendogli: «ok, parti da qui». Offre una prima utile infarinatura su che rapporti e relazioni ci sono tra i diversi artisti, come si pongono rispetto ai trend della propria epoca, come si influenzano l’uno con l’altro, spesso contribuisce anche a istituire un primo sistema di valori critici “universali” con cui confrontare tutti i propri ascolti. E, in un’epoca in cui il suono di un gruppo rock emergente può essere tranquillamente plasmato da (sparo a caso) progressive rock, new wave, minimalismo e IDM simultaneamente, è certamente più spendibile conoscere dieci o venti capolavori indiscussi e indiscutibili provenienti da ciascuno di questi generi, piuttosto che specializzarsi in uno soltanto: si capisce con più facilità cosa si sta ascoltando, lo si colloca meglio nella tradizione di afferenza, si stabilisce se fa qualcosa meglio o peggio rispetto a chi ha intenti artistici simili. L’ascoltatore orizzontale di cui parlavo all’inizio, di fatto, parte proprio da questa elementare presa di consapevolezza: se ti ascolti i Throbbing Gristle, gli Einstürzende Neubauten, i Coil, gli Skinny Puppy e Nine Inch Nails, tendenzialmente saprai inquadrare un qualsiasi altro disco di industrial rock ti passi per le orecchie. E il tempo risparmiato non ascoltando i 23 Skidoo e i Die Krupps può essere reinvestito scoprendo boh, Pharoah Sanders o i Mission of Burma.

Ascoltare tanta musica diversa è un’esperienza senza dubbio arricchente e formativa, aiuta a uscire dalla propria comfort zone e a scoprire una varietà impensabile di possibili finalità nell’atto musicale. Non solo: essere iniziati a più forme musicali incoraggia un approccio interdisciplinare e multimediale all’analisi critica, invitando a mettere in relazione generi diversi gli uni con gli altri, a cercare parallelismi e corrispondenze. È una skill talmente utile – forse anche necessaria, per raggiungere una certa maturità e consapevolezza come ascoltatore – che viene facile desumere una superiorità implicita del modello orizzontale su quello verticale. Non è per forza così: evitando molte limitazioni anguste di quest’ultimo, l’ascoltatore del primo tipo può però incappare in altri vizi, molto diversi eppure egualmente gravi.
Qualsiasi genere musicale necessita di tempo per essere compreso appieno, per imparare a conoscerne la storia, la sintassi e il lessico specifico, i suoi mezzi (anche tecnologici) e i suoi scopi – più banalmente: per permettere al proprio gusto di abituarsi all’esposizione a una forma musicale nuova. Talvolta, non così raramente a dirla tutta, questo processo di “comprensione” nemmeno si conclude, e si rimane incastrati in un limbo di incomunicabilità che impedisce di godere appieno di molte delle espressioni riconducibili direttamente al genere in esame. E tutto questo non dipende da una vera o presunta “difficoltà” della musica che si sta scoprendo, quanto dalla propria esperienza pregressa come ascoltatore, o meglio, degli strumenti di analisi che la propria esperienza ha portato ad affinare. Per dire, se la vostra formazione come fruitore di musica muove i propri passi dal rock alternativo e più sperimentale, avrete quasi sicuramente notato una maggior predisposizione ad apprezzare jazz altrettanto rumoroso e sperimentale in stile Peter Brötzmann e Sun Ra, rispetto al più “accessibile” Louis Armstrong, semplicemente perché Stooges e Butthole Surfers hanno molte più affinità timbriche ed estetiche con i primi piuttosto che con il secondo. È una dinamica comune, che già nel 1998 il critico Alex Ross osservava sulle pagine del New Yorker:
Practitioners of free jazz, underground rock, and avant-garde classical music are, in fact, closer to one another than they are to their less radical colleagues. Listeners, too, can make unexpected connections in this territory. As I discovered in my college years, it is easy to go from the orchestral hurly-burly of Xenakis and Penderecki to the free-jazz piano of Cecil Taylor and the dissonant rock of Sonic Youth.
Questo bisogno di tempo per familiarizzare con musica estranea ai nostri paradigmi mentali spesso non viene recepito da chi, così impegnato a reperire classici e pietre miliari di ogni luogo ed epoca (o perlomeno così crede di star facendo), si trova più frequentemente ad ascoltare e apprezzare maggiormente le emanazioni più spurie, storte e contaminate di ogni genere e scena, arrivando sovente ad abbracciare una falsa equivalenza tra la percezione della stranezza della musica – che è invece una caratteristica, in sé, completamente neutra – e il suo effettivo valore. Nei casi più disperati questa inadeguatezza degli strumenti critici in nostro possesso può venire addirittura scambiata per una visione multidisciplinare più ampia e profonda che eleva la propria analisi, rendendola preferibile a quella di coloro che invece conoscono e amano sinceramente quelle musiche senza però avere la stessa mole di conoscenze all’infuori di esse. E che magari vengono pure considerati come selvaggi obnubilati dalla silhouette delle ombre che sfilano sulla parete, rei di non aver ancora scoperto l’immensità di ciò che il mondo musicale esterno ha da offrire – non sto pensando per forza ai metallari, ma i metallari sono un ottimo esempio. Così, persone che hanno ascoltato meno di dieci dischi di death metal old school in tutta la loro vita vanno a spiegare come Focus dei Cynic sia un album troppo superiore a tutti i contemporanei perché c’è il basso fretless fusion e la voce filtrata dal vocoder, straparlando di jazz e prog e singhiozzando tra sé e sé di come il pubblico metal sia stato troppo limitato per riconoscerne la grandezza in tempo reale. Ma la comprensione della musica non funziona così: a furia di cercare paralleli e punti di riferimenti altrove, adottando la stessa prospettiva per esaminare qualsiasi cosa con cui si viene a contatto, si rischia di non cogliere le specificità di determinati linguaggi musicali che sono esattamente ciò che li rendono tanto peculiari e degni di essere investigati. Un intellettuale come Mike Ratledge già lo sottolineava in una bellissima intervista del 1969 – un’intervista illuminante ma al contempo deprimente, perché le mancanze del giornalismo musicale pop che metteva a nudo ai tempi sono le stesse spiccicate del giornalismo musicale pop del 2022.
It reminds me of the beginning of jazz where they tried to make jazz respectable by comparing jazz musicians to Stravinsky & Schoenberg & Bartok. But this is confusing the form because each medium has its own syntax. To make cross-judgements is confusing. It doesn’t respect the identity of the medium, like all people writing film criticism in terms of theatre. Thereby you miss the basic point of what cinema is. So Tony Palmer and the rest of them — when they talk about the Beatles being better or as good as Schubert or Schoenberg or whatever are missing the point about what makes Pop special and different from these people. Cross-judgements simply confuse rather than illuminate. Apart from not being really desirable.

Sinceramente non ho idea di chi sia colui che per primo ha formulato il principio deleterio che si possa, e anzi sia auspicabile, valutare ogni forma musicale con lo stesso metro di giudizio (che è, sistematicamente, quello tarato in modo da considerare la musica colta occidentale di estrazione europea come “la più alta possibile”); ma a ripercorrere la storia del pensiero estetico musicale si incapperebbe almeno in Theodor W. Adorno, il più nobile (tra molte virgolette) precedente di questa fallacia. I suoi scritti di critica musicale sul jazz, che giustamente sono considerati imbarazzanti anche dai suoi più accesi sostenitori e che nessuno dovrebbe più prendere sul serio nel 2022, sono tra le peggiori pagine mai scritte, se non pensate, sull’argomento: si mette in discussione la provenienza afro-americana del jazz, si liquidano superficialmente le innovazioni sul piano tecnico e concettuale della musica di un gigante del Novecento come Louis Armstrong, si bolla tutto il genere come musica commerciale per le masse. Il tutto perché un filosofo tedesco completamente incapace di intendere una concezione musicale più fisica e ritmica di quella della musica colta europea, e in particolare di quella del serialismo della Seconda Scuola Viennese (per la cronaca: altrettanto disgustose sono le sue pagine di comparazione tra la musica di Schoenberg e quella di Stravinskij) non capiva niente della missione e dell’importanza di ciò che la comunità nera stava costruendo in America tra gli anni Venti e Trenta. Esempi ulteriormente meno illustri di questo modus operandi li conoscete sicuramente, tra amici o critici di riferimento, e non c’è certamente bisogno che ne citi il nome in un articolo come questo.
Ed è qui che entra in gioco non solo l’utilità, ma anche la bellezza e la ricchezza di un approccio verticale alla scoperta di nuova musica – soffermarsi in un luogo ed esplorarne gli anfratti, sollevando e capovolgendo quelle ingombranti pietre miliari poste dal canone della musica popolare occidentale per scoprire un brulicante fermento di artisti, compositori, opere, dischi, EP, singoli, dimenticati dalla storia ma che offrono un aiuto inestimabile per comprenderla in ogni dettaglio (e che magari, di quella stessa storia, hanno contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo di un filone di cui semplicemente non si parla ancora abbastanza o nei giusti termini). Si può scoprire che Coleman Hawkins, il virtuoso che rese il sax tenore uno strumento jazz tra anni Trenta e Quaranta, si esibiva in performance solo una ventina d’anni prima che Anthony Braxton incidesse For Alto. Che il free jazz non solo non fu una rivoluzione ex abrupto del solo Ornette Coleman, ma che fu avvicinato progressivamente da esperimenti come quelli di Lennie Tristano (1949), e che ascoltando con attenzione le prime formazioni e orchestre del jazz si può già percepire in nuce la coralità e la vocalità blues che dischi come The Shape of Jazz to Come e Free Jazz non hanno mai tentato di celare o cancellare. Che In the Court of the Crimson King non è un capolavoro in quanto primo disco progressive rock di sempre (non lo è), ma per come i King Crimson hanno approcciato gli obiettivi che saranno poi propri della stagione maggiore del progressive rock. Che in generale la storia della musica non è un percorso discretizzato e scandito da grosse rivoluzioni, ma è più vicino a un flusso a getto pressoché continuo di eventi che ne segnano l’evoluzione, in cui i “geni” e i “capolavori” non sono per forza solo quelli che indicano sentieri impervi mai presi in considerazione prima di loro, ma anche semplicemente quelli che con il loro lavoro ultimano una strada che altri già avevano cominciato a lastricare. E che, perciò, ha poco senso parlare dei 13th Floor Elevators come inventori della psichedelia, o interrogarsi se il primo disco death metal sia Seven Churches o Scream Bloody Gore, e così via.
Liberati dal fardello di voler ripercorrere a tutti i costi le tappe che legittimano la storia della musica popolare per come adesso è intesa, si può anche scoprire che la critica rock è scritta da gente con una conoscenza appiccicaticcia dei suoi trend più popolari – rigorosamente provenienti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, e da un pugno di altre nazioni scelte come Giappone, Germania e Australia -, spesso anche con un’intelligenza piuttosto misera, che va avanti per luoghi comuni rimasticati e risputati in maniera sempre più dozzinale (l’intervista di Ratledge linkata sopra menzionava anche questo). Calarsi nella musica di culture lontane dalla propria facendo deep dive in scene regionali ai confini dell’Impero può far scoprire best seller che hanno avuto il loro successo commerciale presso pubblici diversi dall’Italia e dall’Europa, e che non sono considerati come “classici” delle loro epoche solo per una prospettiva anglocentrica della critica popolare, oppure scene underground estremamente creative e dalla cifra estetica riconoscibilissima: i nostri articoli della serie Scene che esistono al di là del primo mondo non sono altro che un tentativo di restituire l’ondata di entusiasmo che proviamo noi per primi nel venire a contatto con questi artisti. Ma anche solo scavare nelle profondità di generi ben noti e pubblicizzati può riservare grosse sorprese: se per esempio andate ad ascoltare il rock tedesco anni Settanta proseguendo oltre i soliti Can, Faust, NEU! e compagnia potrete scoprire che, sorpresa, quella fantomatica scena iper sperimentale di cui ciarlano tutti quando si parla di krautrock non esiste, che dietro questi giganti sopravvissuti alla crudele mareggiata della storia c’è un folto sottobosco di musicisti di rock psichedelico e progressivo molto più vicino per sonorità e intenti agli omologhi inglesi dimenticati dalle cronache, e che è proprio questo a rendere ancora più incredibile e visionario il lavoro compiuto da dischi come Tago Mago e Faust. Ogni singolo ascolto diviene un importantissimo tassello per ricostruire un mosaico che seguendo un approccio orizzontale verrebbe invece banalizzato e, talvolta, distorto. La qualità della musica che si ascolta può anche crollare irrimediabilmente (d’altronde, a un certo punto, continuando a scavare trovi solo insetti e terriccio), ma il piacere che l’esplorazione verticale fornisce esula dal mero apprezzamento estetico e ha più a che vedere con l’eccitazione di un paleontologo che dopo anni di fatiche e studio rinviene infine un raro fossile nella propria area di scavo.
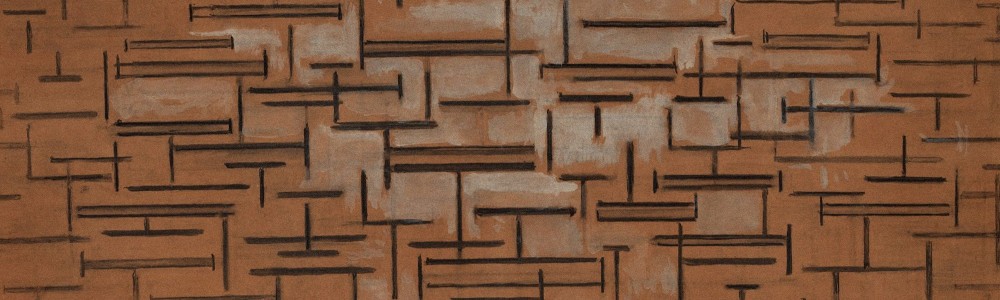
Questo pezzo non vuole essere un’accusa verso chi non ha tempo, voglia o piacere nell’approfondire musica in termini tanto maniacali, e di certo non è nemmeno completamente intellettualmente onesto – scandagliando più in profondità un solo genere si perde, per ovvie ragioni, la visione di insieme che porta un ascolto di tipo orizzontale, e quindi un approccio davvero corretto sarebbe quello T-shaped o ancora meglio comb-shaped, se vogliamo proseguire la metafora con il gergo del job recruitment. È piuttosto da interpretare come una celebrazione della ricchezza, critica e gnoseologica, che l’ascolto verticale può portare con sé, che è quella che personalmente mi fa guardare con fascino e simpatia anche sagome considerate – nei nostri circoli – l’apogeo della sfiga. Possono essere i jazzofili che hanno un’aperta avversione verso il free jazz e le derive sperimentali post-moderne degli anni Sessanta in poi, ma che al contempo hanno una conoscenza capillare di tutto ciò che va dalla Original Dixieland Jazz Band a Sonny Rollins, e la cui conoscenza offre una preziosa guida per districarsi nella storia del genere tra anni Venti e Quaranta, quando gli LP e quindi gli album ancora non esistevano; o possono essere gli studenti di conservatorio più snob, da cui comunque ho imparato quanto Schoenberg e Webern avessero studiato le tecniche dei compositori fiamminghi del XV secolo per realizzare le proprie opere. O ancora possono essere gli incalliti appassionati di metal estremo, di cui conoscono a menadito storia, sviluppi e rapporti di stima e influenza tra i vari artisti molto meglio di quanto le superficiali storiografie rock non facciano (la sapete quella che il Quorthon del periodo viking non era propriamente influenzato dai Manowar?); e anche chissene frega se magari non sanno chi sono questi Irakere che Dave Lombardo cita tra le band chiave per la sua formazione.
È un discorso trasversale che vale virtualmente per ogni genere, anche l’hardcore punk, la techno, la new wave, il garage rock, il progressive rock, la musica popolare brasiliana, la canzone d’autore italiana: non posso che provare un istintivo sentimento di ammirazione di fronte a persone che dedicano in maniera tanto monomaniacale il proprio tempo – la propria vita – a sondare in maniera tanto minuziosa la propria singola passione. Questo articolo è da intendere come celebrazione di queste figure: se volete intenderlo anche come un invito per tornare sui vostri passi, evadere momentaneamente dal flusso ininterrotto di dischi di ogni stile e forma che escono a cadenza giornaliera, e prendervi del tempo per trivellare sotto la superficie, siete i benvenuti.





