Introduzione
Una persona che oggi decide di voler scoprire nuova musica può cercare su un qualsiasi sito di critica e recensioni, database, social network e venire immediatamente a contatto con virtualmente qualsiasi genere, e la maggior parte delle volte lo approccerà – giustamente – con un atteggiamento piuttosto diretto: leggerà qualche nome, se necessario darà qualche lettura corollaria sul contesto e sulle caratteristiche principali, e quindi passerà all’ascolto, senza porsi particolari dubbi metodologici. E nell’ultima decina d’anni, da quando certi ambienti che erano nati come siti dedicati quasi esclusivamente alla musica pop e rock occidentale hanno varcato i confini autoimposti cominciando a trattare sempre più sistematicamente anche musica elettronica di ogni specie e provenienza, musica folk antica e moderna, pure jazz dopo l’esplosione della scena londinese contemporanea, l’offerta di generi e stili è diventata praticamente illimitata. (In altra sede si parlerà, e un pochino si è già accennato, del livello di dettaglio e di qualità che l’informazione di derivazione popular propone al pubblico già quando parla di musica popolare – figuriamoci quando esce da questi paletti.)
Alla musica classica occidentale, tuttavia, è riservato un trattamento peculiare, tanto dagli ascoltatori quanto dalla stampa stessa. Al contrario di praticamente tutto il resto, la classica occidentale sembra un elefante nella stanza che tutti conoscono ma che pochi osano approcciare: i nomi di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner e di pochissimi altri che ogni tanto vengono menzionati suonano più come buzzword da calare per paragoni enfatici (del tipo “pare la Nona di Beethoven!” – è sempre la Nona – se si vuole sottolineare la bellezza di qualcosa) piuttosto che come compositori con una loro poetica da ascoltare e apprezzare. E a parte loro, se si toglie il minimalismo (più quello americano di Steve Reich, ma talvolta anche quello “sacro” europeo di Pärt e Górecki), la musica classica occidentale sia europea che americana è praticamente ignota a un pubblico che, comunque, si ascolta senza farsi troppi problemi i Beatles, Ravi Shankar e Ornette Coleman in rapida successione.
Un ruolo chiave per questa disparità di trattamento è sicuramente giocato dalla percezione che, al contrario di pop, rock, jazz, hip hop, elettronica, folk, e pure la classica di altri luoghi, quella europea e americana necessiti di approfondite conoscenze storiche, teoriche e armoniche che è difficile elaborare in autonomia. È una percezione, oltre che vagamente classista e colonialista, anche distorta in entrambe le direzioni: così come la musica accademica può essere approcciata in maniera più naif ricercando lo stimolo estetico/intellettuale senza possedere un bagaglio tecnico troppo specializzato, anche gli altri generi possono beneficiare di una lettura più critica e informata che, nei pochi casi in cui viene tentata, è invece interpretata come pretenziosa o eccessiva. (Questa totale assenza di analisi “tecnica” ha dato luogo anche a a mostruosità storiche e filologiche che vengono rimasticate e risputate fideisticamente dalla critica popolare come luoghi comuni sempre più superficiali di generazione in generazione – di nuovo, se ne parlerà più accuratamente in altra sede.)
Nel caso specifico dell’opera, poi, si aggiungono anche obiettivi ostacoli formali che ne impediscono la facile fruizione: da orpelli tecnici come il bel canto che non sono sopravvissuti nella musica moderna, al minutaggio importante, passando anche per la necessità di seguire contemporaneamente anche un libretto e una rappresentazione teatrale durante l’ascolto. E nonostante fenomeni come Einstein on the Beach (un’opera fortemente innovativa e di rottura, dal punto di vista formale, con la tradizione operistica europea) sono sicuro che spesso l’approccio a questo genere sia viziato da una conoscenza molto parziale di poche arie da lavori di Mozart, Verdi, Rossini o Puccini, che può portare al pregiudizio che si tratti di musica “obsoleta” e, anche nelle sue manifestazioni più moderne, essenzialmente conservatrice: ne sono sicuro perché, nei miei anni di formazione come ascoltatore con un background essenzialmente rock, la pensavo più o meno così anche io. È un pregiudizio che in certi ambienti colpisce ogni manifestazione sufficientemente lontana dalla modernità e dal concetto di “album”, trasversalmente senza riguardo per il genere: accade la stessa cosa con il rhythm & blues e il rock & roll anni Cinquanta, o con le registrazioni Dixieland e swing degli anni Venti e Trenta, e così via.
Per sfatare queste false convinzioni c’è di fatto bisogno solo della voglia di mettersi ad ascoltare con pazienza, imparando e affinando gli strumenti per decodificare i segni musicali e concettuali che ci sono alieni. Tuttavia un ulteriore aiuto può arrivare dallo scoprire quanto l’opera, nel Terzo Millennio, sia così drammaticamente cambiata dal paradigma mentale che gli ascoltatori di musica popolare possono avere in testa – sia timbricamente, che strutturalmente, che concettualmente –, raccogliendo stimoli e suggestioni non solo dalla musica jazz ed elettronica ma anche dal pop e dal rock, talvolta ricevendo pure una calorosa e unanime accoglienza da parte della critica specializzata.
Per questo, abbiamo scelto per voi tre opere – tutte realizzate dopo il 2010, come data simbolica – che esplorano tre modi completamente differenti di intendere il genere, in certi casi a tal punto da rendere difficile riconoscerle come “opere”. E in risposta al profondo maschilismo che imperversa nell’accademia e nel mondo della musica colta, nel frattempo rimarcando l’attualità di questi lavori, abbiamo deliberatamente scelto composizioni alle prese con tematiche estremamente contemporanee (dal rapporto astratto tra linguaggio e significato, alla violenza sessuale, fino al colonialismo culturale) di autrici donne. Per di più, in tutti e tre i casi, si tratta di figure artistiche che (anche se non per forza con questi lavori) hanno raggiunto almeno le fasi finali per l’assegnazione del premio Pulitzer per la musica – a dimostrazione ulteriore che lo stesso establishment accademico, dopo decenni di scelte piuttosto conservatrici quando non direttamente reazionarie, è consapevole e pare finalmente sostenere questa evoluzione.

Kate Soper – Ipsa Dixit (2010–2016; New World, 2018)
La soprano americana Kate Soper (n. 1981) è una delle voci nel senso letterale del termine) più innovative e originali del panorama d’avanguardia contemporaneo. La sua carriera come interprete e autrice musicale nasce con il suo ingresso, nel ruolo di cantante e co-direttrice, nell’ensemble Wet Ink – un collettivo di compositori, improvvisatori e performer a 360 gradi che negli anni è diventato un punto di riferimento per la scena sperimentale di New York intorno al quale sono orbitati anche nomi del calibro di Zs, Anthony Braxton, Christian Wolff e Peter Evans. Da allora – era il 2006 – Soper si è imposta come una figura di primo piano grazie a celebrate composizioni vocali come Voices from the Killing Jar (2010-2011), in cui ha coniugato i suoi interessi per complessa musica da camera di derivazione modernista (Xenakis e Ferneyhough sono tra le sue influenze dichiarate) e la ricerca testuale “multimediale”, che attinge a fonti letterarie che vanno dalla poesia alla filosofia esplorando i legami tra parola e suono.

Di tutte queste composizioni, Ipsa Dixit è ampiamente la più rinomata (è stata pure finalista per il premio Pulitzer nel 2017), nonché quella più cerebrale, intellettuale e – in definitiva – la più complessa da decifrare. Non si tratta davvero di un’opera – è, più propriamente, quella che si dice un’opera da camera, ovvero un lavoro dalla durata moderata (in questo caso, circa 90 minuti) pensata per un organico ridotto, pur avvalendosi comunque di un libretto e di una rappresentazione scenica che, per forza di corse, appare molto più asciutta e semplice rispetto allo standard delle opere orchestrali. E anche la sua genesi è piuttosto atipica, visto che non è nata fin da subito come composizione unitaria: a cavallo tra il 2010 e il 2012, Soper ha scritto tre pezzi in duo (Only the Words Themselves Mean What They Say, per voce e flauto; The Crito, per voce e violino; Cipher, per voce e percussioni), adattando quando non citando pedissequamente testi di Platone, Guido D’Arezzo, Freud, Wittgenstein e Lydia Davis (tra gli altri). Ognuno di questi tre brani riflette sul rapporto tra linguaggio, significato, segni intertestuali, espressività, interpretazione, traducendo il monologo filosofico in musica e atto recitativo. Nel terzo movimento di Only the Words Themselves Mean What They Say, per esempio, Soper afferma «If your eyeballs move, this means that you’re thinking, or about to start thinking / If you don’t want to be thinking at this particular moment, try to keep your eyeballs still»: il suo sguardo e quello della flautista che l’accompagna sono fissi nel vuoto, i loro movimenti convulsi, poco fluidi e completamente speculari, analogia del moto incontrollato dell’occhio che segue e testimonia l’attività frenetica del cervello. E per cementare questa analogia, il flauto e la voce percorrono traiettorie simmetriche, accoppiando i gorgheggi, i bisbiglii, gli acuti di Soper con i soffi strozzati, gli stridii, le sinuose linee del flauto – e perché no, pure qualche sillaba pronunciata direttamente attraverso l’imboccatura.
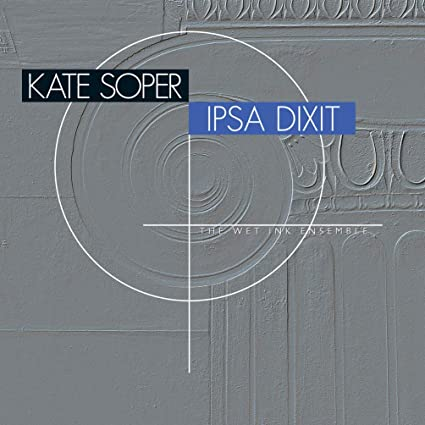
Realizzando i punti di contatto concettuali tra questi tre brani, Soper li ha quindi resi il secondo, quarto e sesto movimento di Ipsa Dixit, cucendo loro attorno altri tre pezzi di durata paragonabile per il quartetto di voce, flauto, violino e percussioni al completo, intitolati rispettivamente Poetics, Rhetoric e Metaphysics. (Tuttora, Ipsa Dixit viene eseguita sia come un’opera unica, sia nelle sue singole parti indipendentemente.) I testi, riadattati da vari scritti tratti (per l’appunto) dalla Poetica, la Retorica e la Metafisica di Aristotele, vedono Soper recitare in un tono perlopiù limpido e cristallino intere pagine di elucubrazione del filosofo intorno alla rappresentazione della tragedia, alle capacità e alle tecniche persuasive della retorica, e alla metafisica, interrogandosi sugli scopi dell’arte, sul legame tra parole e messaggio veicolato, sulla natura stessa della conoscenza. Tuttavia, Ipsa Dixit procede in maniera meno lineare del previsto: la dizione aristocratica di Soper viene disturbata spesso e volentieri da vocalizzi assurdi, pirotecnici e deliranti, che si collocano nel solco di un’intera schiatta di cantanti femminili di estrazione accademica che hanno portato verso mondi ultraterreni le possibilità della voce (Cathy Berberian e Meredith Monk in primis, ma anche Laurie Anderson è un riferimento azzeccato). Nel frattempo, i tre strumenti dietro di lei si inseguono in assortite bizzarrie armoniche, melodiche e ritmiche, contrappuntando o ostacolando il naturale fluire del suo discorso, enfatizzando – o qualche volta, contraddicendo – le parole di Aristotele lette da Soper. In Poetics la voce declama, con tono traballante tra l’imbarazzato e l’insicuro, che «the meaning of music-making is obvious to everyone»: la musica dapprima diviene più incerta, riacquista un po’ di colore con un unisono di xilofono, flauto e violino approfittando di una pausa un po’ più lunga di Soper, e poi si spegne sull’everyone. Forse il suo significato non è poi così evidente.
Ipsa Dixit è un brillante saggio di compenetrazione tra suono e idee, che evade il rischio di crollare sulle proprie pretese intellettuali tramite un approccio paradossale ma – a suo modo – leggero, giocando con un umorismo surreale che è quello del teatro di Beckett. Dal suo debutto, avvenuto all’EMPAC di New York nel 2016, Ipsa Dixit è stata portata sui palcoscenici diverse volte, e su YouTube è facile trovare video dei singoli movimenti. In ogni caso, la New World nel 2018 ha pubblicato un doppio cd che raccoglie l’opera completa, eseguita dal solito Wet Ink Ensemble: è una delle uscite di musica classica imperdibili degli ultimi anni.

Ellen Reid – p r i s m (2015–2018; Decca Gold, 2019)
Pur essendosi imposta come una delle figure più importanti dell’ambiente colto, la compositrice Ellen Reid (n. 1983) ha incontrato relativamente tardi la musica sperimentale, il jazz e la classica, quando era già al college. Un ruolo primario per la sua formazione artistica è stato infatti giocato dai girl group, dal pop e dal soul della Motown e di Memphis, e dal musical: forse anche per questo, la sua musica non perde mai un carattere intrinsecamente melodico, cantabile e leggero nella sua connotazione più positiva. La musica per teatro rimane comunque la sua principale vocazione – e proprio per questo, è particolarmente dedita alla scrittura di opere. Tuttavia, ancor più che con la tradizione occidentale, il suo riferimento primario è quello dell’opera asiatica (e in particolar modo thailandese), che secondo le sue stesse parole ha un rapporto più stretto con la rappresentazione teatrale.

Con p r i s m (d’ora in poi, per semplicità, prism) Reid ha conquistato definitivamente il rispetto e il riconoscimento da parte di critica e addetti ai lavori: nel 2019 è stata anche insignita del premio Pulitzer. È un’opera dalla struttura più tradizionale, con un libretto (a opera di Roxie Perkins) e una suddivisione dell’arco narrativo in tre atti, anche se fortemente asimmetrici (il primo occupa quaranta dei settanta minuti dell’intera composizione; il terzo non arriva a durarne dieci). La storia, seppur dallo sviluppo piuttosto semplice, è narrata in maniera estremamente originale, prima ancora che dalle parole di Perkins (a loro modo, astratte e di difficile lettura), dall’elaborata partitura di Reid e dalla scenografia, che offrono di fatto ulteriori chiavi di lettura per decifrare la sinossi dell’opera.
Nel primo atto (intitolato Sanctuary as it should be), vengono introdotte le due protagoniste, Bibi (soprano) e la madre Lumee (mezzosoprano) nel loro principale luogo d’azione: un cubo luminoso dalle pareti trasparenti, il cui candore si staglia prepotentemente sulla cupa luce blu esterna in cui è immerso, arredato internamente come una sfarzosa casa delle bambole – il Santuario, appunto. A causa di una non meglio specificata malattia che la affligge, Bibi non riesce più a camminare e viene accudita a tempo pieno dalla madre: per tutto il primo atto, quest’ultima si prende cura della figlia, contendendo le sue attenzioni con le voci del coro posto fuori dal Santuario (menzionate come Chroma nel libretto, quasi rivestissero il ruolo di un personaggio principale) che cercano di richiamare l’attenzione di Bibi con le parole «blue» e «you remember». Lumee affronta queste distrazioni dall’esterno con piccoli rituali, mantra ripetuti in continuazione, e costanti tentativi di somministrarle una qualche medicina, che Bibi però rifiuta sistematicamente. È un atto immerso in un’atmosfera sognante ma artefatta, strabordante di duetti lirici e di un’orchestrazione leggera e volatile: l’implementazione di un vasto assortimento di legni, archi, arpe, ottoni dona uno spettro timbrico di ampia portata che suggerisce paragoni con la musica di Debussy (Pelléas et Mélisande), Messiaen (St. François d’Assise), anche la più recente Saariaho (L’amour de loin).

Il secondo atto (Sanctuary as it was) prende piede dopo che il primo si è progressivamente sgretolato in sezioni sempre più dissonanti e sconnesse, e dopo che alcuni ballerini dall’esterno hanno portato Bibi fuori dal Santuario. L’azione si sposta completamente all’esterno del cubo, con un martellante battito techno che emerge tra stridii atonali degli archi, intrecci vocali più vicini all’art pop urbano piuttosto che alla tradizione operistica, e interferenze elettroniche. La prima battuta di Lumee è una minaccia a Bibi, colpevole di averla chiamata “mamma” («Stop calling me that, this is exactly what we made up those stupid-ass code names for. Here, I’m Lumee. You’re Bibi. You know it’s 100% your fault we didn’t get into Sanctuary right. […] You called me ‘mommy’ right in front of the gate for VIP, bitch, I’ll eat you»). Il trauma di Bibi viene svelato in questo atto: dopo essere stata abbandonata dalla madre in mezzo a una discoteca, è stata assalita e violentata. In un disturbante e magistrale colpo di scena, i mantra del primo atto si rivelano nient’altro che gli oggetti su cui Bibi cerca di concentrare la propria attenzione mentre, sola nel dancefloor dopo l’abuso, aspetta e spera che la madre torni a recuperarla, ripetendone i nomi ossessivamente mentre respira in affanno. Quando l’azione torna al terzo atto («Sanctuary as is»), il Santuario è distrutto: il rifugio dai contorni fiabeschi è ora pieno di sacchi della spazzatura, vestiti lasciati alla rinfusa, muri rovinati. E con esso, anche la musica sembra cadere a brandelli, con gocciolanti pizzicati degli archi ed esplosioni orchestrali dissonanti all’unisono. A questo punto a Bibi non rimane altra scelta che fuggire dalla farsa del Santuario, sotto il comando perentorio e drammatico del coro che le intima di affrontare la realtà: «RUN».
Sarebbe troppo facile fare un’associazione tra il libretto di prism e la sensibilità femminista portata alla ribalta dal movimento #MeToo – e infatti, come tutte le cose troppo facili, è un collegamento molto impreciso. La fase di scrittura dell’opera è cominciata diversi anni prima: tragicamente, il tema di prism ha una fonte prettamente autobiografica, visto che sia Reid che Perkins sono state vittima di violenza sessuale. Proprio per questo, la profondità psicologica di prism è inaudita: l’attenzione è completamente rivolta alle ripercussioni sulla mente della vittima di violenza e di chi sta intorno a essa, scandagliando i sensi di colpa, il senso di impurità, il tentativo di cancellare le memorie dolorose e sovrascriverle con un ambiente rassicurante e anemico. Si potrebbe dire che in prism il ruolo di protagonista torna a essere rivestito dalla donna, che in queste tragedie viene spesso (pur involontariamente) spersonalizzata e resa semplicemente l’oggetto dell’atto carnale in sé – nell’opera, il violentatore non ha un volto, e la violenza è soltanto suggerita metaforicamente dalla coreografia nel secondo atto. In questo flusso di coscienza, la potenza drammatica della musica non solo esalta la portata commovente del percorso di elaborazione del trauma di Bibi, ma offre anche una chiave di lettura essenziale per districarsi nel dedalo di ricordi, mistificazioni auto-consolatorie (quando non auto-assolutorie, nel caso di Lumee), coping e deprimente realtà.
Sfortunatamente, un video di una rappresentazione integrale di prism non è ancora disponibile; di conseguenza, le implicazioni psicologiche più sottili convogliate tramite la recitazione, la danza e la scenografia si possono cogliere solo tramite i pochi frammenti online e la testimonianza diretta di chi ha avuto la fortuna di vederne una performance dal vivo, e per giunta soltanto parzialmente. Tuttavia, il cd edito dalla Decca Gold nel 2019 riesce a preservare pienamente l’impatto espressivo della musica, la cui portata emotiva e la potenza creativa sono già ampiamente sufficienti per rendere prism uno dei fenomeni imperdibili dello scorso decennio.

Raven Chacon / Du Yun – Sweet Land (2018–2020; The Industry, 2021)
Qua stiamo barando un po’ – i due artisti a cui è intitolata l’opera non sono entrambi donne. A parziale discolpa, però, dei due nomi il più noto è proprio quello di Du Yun (n. 1977), compositrice e performer cinese di stanza negli Stati Uniti dalla statura celebratissima e dalla formazione onnivora. Oltre alla musica classica – che le è valsa, nel 2017, il Pulitzer per l’opera Angel’s Bone, parabola della schiavitù e del traffico di esseri umani –, Yun ha infatti gusti variegatissimi che spaziano dalla musica pop cinese, al rock psichedelico, al dream pop, fino al trip hop e alla musica per cabaret; tutte queste influenze sono ben riscontrabili nel suo lavoro, a partire da Angel’s Bone stessa. D’altro canto, Raven Chacon (n. 1977) è un artista di discendenza Navajo che ha studiato sotto la guida di Morton Subotnick, Michael Pisaro e Wadada Leo Smith, e parallelamente all’occupazione come compositore per musica da camera ha anche una carriera come musicista noise.

Giusto poche settimane prima che le misure di restrizione anti-covid congelassero il mondo occidentale, tra febbraio e marzo 2020, la compagnia teatrale indipendente The Industry aveva presentato una nuova opera co-composta da Chacon e Yun su un libretto (completamente disponibile qui) scritto a quattro mani dalla scrittrice di discendenze Ojibwe Aja Couchois Duncan e dall’autore di colore Douglas Kearney. Tragico e sanguinoso, Sweet Land è un lavoro che rappresenta l’incontro di due diverse civiltà (gli Arrival, che giungono dal mare in una nuova terra, e gli Host, che quella terra la vivono, la conoscono e la rispettano da sempre), e la prevaricazione attuata dall’una sull’altra, portandola quindi alla distruzione e all’imposizione di un nuovo paradigma culturale. Nonostante ovvi richiami al trattamento riservato dai coloni europei alle popolazioni native americane, Sweet Land è dichiaratamente un pretesto per riflettere su ogni sopruso di questo tipo, senza dare alcun facile appiglio per gli alibi autoassolutori che la distanza temporale o geografica solitamente fornisce.
L’intreccio dell’opera non è particolarmente convoluto, ma la struttura fortemente innovativa dell’impianto narrativo rende piuttosto tortuosa l’esposizione degli eventi: in questo senso, Sweet Land è davvero un’opera che, nelle stesse parole della Industry, cancella se stessa. Subito dopo lo sbarco degli Arrival, accolti con più di qualche diffidente sospetto dagli Host nell’ouverture Contact, il cast dei personaggi si divide infatti in due gruppi, ognuno diretto verso un set diverso. A seconda di chi sceglie di seguire, uno spettatore si troverà ad assistere a una sola tra due scene – Feast o Train –, entrambe dedicate a un diverso incontro/scontro tra le due civiltà.
In Feast, gli Host organizzano dei festeggiamenti in segno di benvenuto per gli Arrival, offrendo loro cibo e ospitalità (Feast 1). L’atmosfera accogliente si spezza quando un Arrival, Johnny Gin, rifiuta sdegnosamente i doni ricevuti («your generosity is poison to the freedom of a man / we must ask for nothing, accept nothing from another’s hand […] God gave us dominion over everything») e reclama con prepotenza una Host, Makwa, come moglie: il disgustato rifiuto di lei fa degenerare la situazione in un conflitto armato. Su questo attimo di violenza, la scena si congela, e quando comincia la seconda parte (Feast 2) la scenografia è completamente stravolta. Al posto dei festeggiamenti degli Host c’è ora una festa degli Arrival (now looks a bit like Golden Corral, descrive il libretto) per il matrimonio tra Johnny Gin e Makwa; solo quest’ultima, ancora fortemente riluttante alle nozze, sembra ricordare cos’era in origine quella cerimonia.
Train, invece, è più corale e stratificata. Nella prima parte, Train 1, la costruzione di un treno fa da sfondo a un mosaico di situazioni che esplorano da varie prospettive lo scambio tra le due culture (le differenti espressioni linguistiche, le diverse tecnologie, anche le diverse conoscenze per cacciare e sopravvivere in quelle terre). Tutta la narrazione è scandita dai fanatici sermoni di un predicatore, che sottolinea l’ispirazione divina della missione degli Arrival spingendo al parossismo il concetto di Manifest Destiny, e dall’incessante battito metallico che testimonia il processo di lavoro dei binari, portato avanti da schiavi impersonati da attori africani e asiatici. Quando gli Host non sono più reputati utili alla causa vengono brutalmente eliminati. Tuttavia, in Train 2, lo spargimento di sangue è completamente dimenticato; rimane soltanto la società Arrival, ormai votata al consumismo e all’avida accumulazione di ricchezze.
La narrazione di queste due scene è pensata appositamente per far vestire allo spettatore simultaneamente il ruolo di vittima e di superstite dell’atto di rimozione delle memorie storiche degli Host. Coloro che assistono agli avvenimenti di Feast 1 procedono a seguire lo svolgimento di Train 2, senza avere alcun contesto o consapevolezza di ciò che è stato in Train 1; viceversa, la loro esperienza di Feast 1 viene completamente cancellata, ed è inaccessibile all’audience che ascolta Feast 2. Le uniche conoscenze comuni ai due gruppi, a parte l’atto introduttivo, sono The Crossroads – il breve intermezzo che accompagna lo scambio delle due audience da una scena all’altra – ed Echoes & Expulsion, che chiude l’opera. È soltanto qui che la Sweet Land del titolo viene esplicitamente identificata negli Stati Uniti d’America: sul desolante spettacolo di un adolescente che lavora, in solitudine, nel mezzo di una spettrale distesa post-industriale, si alza una funerea elegia composta di strazianti testimonianze in prima persona di abusi sistemici su minoranze in quel di Los Angeles – una bambina venduta come merce, una donna latino-americana a cui viene praticata l’infibulazione, fino ai morti nel massacro nel quartiere cinese del 1871.
Il libretto può probabilmente apparire in diversi momenti eccessivamente verboso, e la caratterizzazione dei personaggi per ovvie esigenze di intenti scivola talvolta in un po’ troppo monodimensionale dualismo tra l’ancestrale saggezza primitiva degli Host e l’arrogante ma sciocca cupidigia degli Arrival, non rivelandosi esattamente all’altezza della struttura ambiziosa dell’opera. (Non che manchino i momenti brillanti, come quando in Contact il capitano degli Arrival, non conoscendo la struttura matriarcale della società degli Host, si presenta all’esponente di sesso maschile più in vista della loro comunità – con tanto di esplicita derisione da parte di altri attori.) Tuttavia, le composizioni di Chacon e Yun (che collaborano solo per Contact ed Echoes & Expulsions, lavorando in autonomia per il resto dell’opera), insieme alla splendida interpretazione vocale degli attori, trasfigura anche i versi più didascalici conferendo loro un’intensità che ha pochi eguali nella musica del 2020.

Dei due, Yun è sicuramente la più poliglotta ed eclettica. In Feast 1, Yun rappresenta lo scontro culturale tra Arrival e Host contrappuntando le sinistre minacce di Johnny Gin con una post-moderna rivisitazione della musica barocca per clavicembalo, riletta tramite la lente degli studi per pianoforte meccanico di Conlon Nancarrow, e alterando le furiose risposte di Makwa con manipolazioni elettroniche e il suono di una chitarra distorta fino a sembrare uno shamisen. In Train 2, invece, si avvale di elettronica, percussioni industriali, grotteschi e spettrali interventi di ottoni che sembrano provenire dall’avant-prog o dal krautrock, in un melting pot stilistico che ha davvero pochissimi precedenti nella tradizione operistica. Le sue partiture, stravolte in continuazione da cambi improvvisi di dinamiche, ritmi e timbri, hanno un sapore più frammentato e incoerente rispetto a quelle, invece più organiche e strutturate, di Chacon. Pur attingendo anch’egli dalle fonti più disparate, come l’elettronica e gli spiritual in Train 1, il suo linguaggio musicale è in effetti più radicato nella musica colta europea e americana. Può anzi risultare controintuitiva la scarsezza di elementi della tradizione nativo americana nelle sue composizioni, specie considerando il tema dell’opera; ma, nelle stesse parole di Chacon, questo è una decisione deliberata che sottintende anche una presa di posizione politica.
This is not Indigenous futurism. […] There is no obligation for the sonorities inside this opera to replicate the music of Native peoples. Can we ever catch up or are we always doomed to be coming in last, behind even our own assumptions of who we are?
Per ovviare alle perdite che hanno messo in ginocchio tante compagnie indipendenti come la loro, la Industry ha reso acquistabile un video in streaming di una rappresentazione integrale di Sweet Land (disponibile qui) e nel 2021 ha anche pubblicato un album, edito in formato fisico e in una versione deluxe solo digitale. Delle due edizioni, è nettamente meglio la seconda: per occupare un solo cd e abbattere i costi di produzione, la Industry ha omesso Contact, Feast 1 e Train 1, il che pur essendo a suo modo coerente con il tema di fondo dell’opera (l’ascoltatore, così facendo, viene a contatto solo con la storia “riscritta” dagli Arrival, con gli Host completamente rimossi dalla scena) priva Sweet Land di alcuni dei suoi vertici espressivi e drammatici. Il nostro consiglio è, se possibile, di recuperare la versione in video, che arricchisce notevolmente la già splendida musica: la scenografia e i costumi, pur con il loro gusto spiccatamente artigianale, sono estremamente suggestivi, e l’interpretazione degli attori è eccellente fin nelle più impercettibili microespressioni. Ma anche solo come mera esperienza d’ascolto, è difficile non riconoscere l’estrema originalità e rilevanza che un’opera come Sweet Land può avere oggi.





