Anche il secondo decennio di questo nuovo millennio è ormai terminato, il che significa che è tempo di tirare le somme. Noi ci siamo spesso e volentieri lamentati dei nuovi trend musicali e soprattutto critici sorti a causa dell’influenza di internet e dei servizi di streaming; ma a guardare indietro adesso, dopo pochi giorni dall’inizio del 2020, ci accorgiamo che questi anni Dieci hanno anche prodotto una quantità di grande musica in tantissimi generi differenti. È ovviamente impossibile riuscire a riassumere dieci anni così densi di stravolgimenti in un long-form, non importa la lunghezza: per questo, abbiamo optato per una selezione dei nostri cento dischi preferiti del decennio, ordinati rigorosamente per anno di uscita e con l’unica limitazione di inserire un solo album per ogni artista.
Alcuni dei lavori che abbiamo scelto sono classici già affermati nel loro ambito, mentre altri sono stati lavori che hanno influenzato in maniera più sotterranea gli sviluppi di certe correnti; altri ancora, semplicemente, sono piaciuti soltanto a noi e probabilmente la storia li archivierà come una nota a pie’ di pagina della musica di questi anni. Sempre meglio così che infarcire la nostra lista di album di Kanye West, Lana Del Rey e Beyoncé, in ogni caso.
Ecco quindi la selezione 2010-2019 di LIVORE.

Deathspell Omega – Paracletus (Norma Evangelium Diaboli, 2010)
Il black metal ha da sempre avuto un rapporto problematico con se stesso e con il mondo: genere oltre i limiti per eccellenza, in cui la territorialità e la purezza dell’artista la fanno da padroni. In un modo o nell’altro, i francesi Deathspell Omega capitanati da Mikko Aspa sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio: pochissime, controverse interviste, nessun tour, solo i dischi a far parlare la band, che con questo Paracletus mette fine alla “trilogia contro Dio” iniziata con Si monvmentvm requires… nel 2005 e continuata nel 2007 con Fas – Ite, maledicti… Parliamoci chiaro: la musica dei Deathspell Omega è cattiva fino al midollo. Subito dopo la breve introduzione di Epiklesis la band si scatena su Wings of Predation, che condensa in poco meno di quattro minuti vertigini batteristiche, linee di chitarra ingestibili e un’atmosfera pestilenziale. Scordatevi quello che pensavate di sapere sul black metal: il sound dei Deathspell Omega è cristallino, chirurgico e assolutamente ipnotizzante. Così, tra le bordate nere di pezzi come Dearth (forse il brano più “standard” di tutto il disco) prende forma una suite serpentina di quaranta minuti inframezzata da piccoli, minacciosi riposi come la divagazione post-metal in coda alla furia apocalittica di Phosphene. Una dicotomia black che continua a interferire con gli arpeggi desolanti di Epiklesis II e che riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo, scatenandosi in un disastro infernale nell’ultimo filotto di brani da Malconfort fino ad Apokatastasis pantôn tra rallentamenti, accelerate e geometrie impossibili: insomma, i Deathspell Omega sono senza troppi giri di parole il suono del miglior black metal degli anni Dieci. (Jacopo Norcini Pala)

Anaïs Mitchell – Hadestown (Righteous Babe, 2010)
Se sulla carta è affascinante l’idea di un disco che unisca pilastri del patrimonio espressivo umano come il racconto mitologico, il teatro e la musica folk, Hadestown è una magnifica concretizzazione di quell’idea. Anaïs Mitchell (insieme ai suoi numerosi collaboratori) realizza un lavoro ricchissimo di intuizioni, colpi di scena ed espedienti comunicativi per meglio rendere i risvolti emozionali della storia, e non sorprende infatti che ne sia stato tratto un musical curato da lei stessa. Ma non si limita a mettere in scena una storia: la attualizza e la rivitalizza, ambientandola in un momento di grande crisi economica che parla direttamente al pubblico attuale. Ascoltare oggi Why We Build the Wall è un momento di sinistra ironia. (Roberto Perissinotto)

Janelle Monáe – The ArchAndroid (Bad Boy, 2010)
Gli anni Dieci hanno visto, nel loro incedere lento e minatorio, una hall of fame di divas del bene e del male – ne parliamo anche in molti altri paragrafi – e mi piace pensare che la Janelle Monáe di The ArchAndroid sia la donna da cui tutto quanto è cominciato: si presta bene. Cibernetico-analogica, brillante-golden, bianco-nera, con gli occhi piantati sulla qualità della composizione e il sangue che scorre al ritmo di un passafuoco. Con un setaccio e un po’ di cattivo gusto uno storico potrebbe ritrovarci tutta la posterità art pop/R&B che ha poi venato la decade, e negli avanzi ci uscirebbero un paio di aoty. Il disco in sé, secondo atto di un’opera triadica (con l’EP The Chase e The Electric Lady), è una cascata continua e implacabile di take guerrigliere che ridefiniscono per schiocco e complessità cosa può effettivamente succedere in un disco pop contemporaneo, armate di un piglio funk asfissiante (Dance or Die, Faster, Tightrope, Make the Bus), di un lirismo che sfocia più volte nel transumano (Sir Greendown, Wondaland, Oh, Maker…) e di ambizioni che giocano sulla stessa plancia delle grandi opere rock, spesso vincendo la partita a distanza (Cold War, Come Alive, Mushrooms & Roses…). Il tiro che risulta dall’elenco di brani è chilometrico – cosa che ai tempi la maggior parte delle zine di settore ha riconosciuto, dando alla release lo status di instant classic.
Lo è: negli anni Dieci non esistono dischi pop/R&B che non si siano confrontati – perdendo, imparando – con Janelle, una donna che all’epoca aveva venticinque anni e che ancora non poteva sapere che entrare in un pantheon mascherata da androide le avrebbe assicurato il trono di Dio. (Alessandro Corona)

Joanna Newsom – Have One on Me (Drag City, 2010)
La mole sconsiderata (un triplo disco con diciotto pezzi per una durata complessiva di oltre due ore) di Have One on Me farebbe vacillare la fede di molti ascoltatori: ma Joanna Newsom, qui al suo terzo disco, può contare sulla maestria incomparabile della propria arte per conquistarci. Concepito a quattro anni di distanza dall’impareggiabile capolavoro Ys, Have One on Me vanta però una schiera di collaboratori (e strumenti) molto più nutrita, assieme a Jim O’Rourke e Noah Georgeson, che avevano rispettivamente mixato Ys e The Milk-Eyed Mender, a spartirsi la cabina di regia. Il risultato tuttavia è sostanzialmente differente da quello a cui la Newsom ci aveva abituato in precedenza: l’opener Easy, ad esempio, si muove su un giro di piano impreziosito dai trilli dei flauti, lasciando in cantina l’arpa che fino ad ora era stata strumento principe della cantautrice. Have One on Me è infatti soprattutto un lavoro che si muove tra le possibilità di mutazione del suono di un genere ristretto come il bizzarro folk della Newsom: ecco quindi apparire spiragli di piano quasi ragtime, ottoni soffusi e una batteria dal sapore inequivocabilmente jazzy su Good Intentions Paving Co., la chitarra elettrica scarnificata di Baby Birch, il crescendo orchestrale di In California, gli arabeschi di mandolino su Go Long e così via. Questo non vuole ovviamente dire che la creatività compositiva della Newsom sia stata sacrificata in nome di una palette sonica più ampia: ne è un esempio la delicatissima ballata per arpa e voce Esme, che riporta alla mente i momenti più intimisti dell’inevitabile Ys. Have One on Me quindi non avrà la stessa capacità di colpire immediatamente al cuore come faceva il suo predecessore, ma rimane una miniera di geniali intuizioni e nuovi spunti di quella che ad oggi è la più importante cantautrice americana sulla scena. (Jacopo Norcini Pala)

Shining – Blackjazz (Indie, 2010)
Blackjazz si apre con delle urla. Cinque secondi di sofferente umanità prima che The Madness and the Damage Done dia il via alle danze: un’accelerata improvvisa e poi il primo vero riff del pezzo, un esercizio di grandeur pacchiana figlio dei Fear Factory o dei Ministry novantiani, storto da coordinate prog indecifrabili. Il gioco kitsch degli Shining, band norvegese il più lontana possibile dalle coordinate dell’omonima formazione svedese, è un martello pneumatico che nel giro di tre minuti si è trasformato in un micidiale assalto di incomprensibili ghirigori di sassofono ed muri di chitarre talmente poderosi da far impallidire Devin Townsend. I synth malaticci di Fisheye riportano invece alla mente certi Nine Inch Nails prima di esplodere in un breakdown alla Deftones e in un breve botta e risposta tra chitarra e sax tenore, che col passare dei minuti assume un ruolo sempre più di rilievo in mezzo alle scariche al tritolo del comparto ritmico. Exit Sun si abbandona a sporchissimi echi di feedback e mitragliate di mid-tempo; Blackjazz Deathtrance si propone di fare quel che il suo titolo indica, scaraventando nel frullatore grugniti vocali e synth ipnotici assieme alla solita combo di follia matematica tra chitarra, batteria, basso e sax. Il finale quasi sludge di 21st Century Schizoid Man, qui resa ancora più maniacale e delirante dell’originale crimsoniana, lascia intendere che la band norvegese credesse di avere i mezzi per mirare ancora più in alto. Ovviamente così non è stato, e gli Shining hanno tirato fuori soltanto album sgonfissimi e inutilmente pomposi nel resto del decennio che si è appena concluso: ma Blackjazz rimane un testamento di quel folle istante in cui gli scandinavi avrebbero potuto conquistare il mondo da un momento all’altro. (Jacopo Norcini Pala)

These New Puritans – Hidden (Domino, 2010)
I These New Puritans sono stati uno dei gruppi più importanti in ambito rock alternativo degli ultimi dieci anni, e hanno marchiato quest’epoca con almeno due grandissimi dischi. Abbiamo deciso di preferire questo Hidden a quello che è probabilmente considerato generalmente il loro classico (il successivo Field of Reeds) perché non solo è probabilmente il lavoro più originale che si possa ricollocare al revival di forme post-punk (inteso in senso molto lato), ma perché a ben vedere in questo album sono già presenti molte tracce, per quanto subliminali, di quel rock sontuoso ed etereo che farà la fortuna del suo successore. Hidden è un album cerebrale e sofisticato, che sposa quasi trent’anni di innovazioni del rock inglese (dal post-punk dei This Heat e dei Wire, all’industrial gotico dei Coil, passando per il post-rock dei tardi Talk Talk e dei Bark Psychosis e giungere infine all’art rock intellettuale dei Radiohead) con i beat e i timbri dell’elettronica e dell’hip hop, mentre qua e là fanno capolino interventi sinfonici, ostinati ritmici di estrazione minimalista, arrangiamenti cameristici. È forse uno degli ultimissimi casi in cui la musica rock ha tentato di essere sinceramente all’avanguardia in questo decennio, con scopi estremamente ambiziosi ma una esecuzione lucida ed efficace, e rappresenta pertanto uno degli indiscutibili capolavori di questi anni. (Emanuele Pavia)

Tu Fawning – Hearts on Hold (City Slang, 2010)
I Tu Fawning sono stati uno dei progetti più indecifrabili del decennio. La loro musica è legata a doppio filo ai più esuberanti interpreti dell’indie folk del nuovo millennio, ma allo stesso tempo ha un carattere oscuro e spettrale che proviene direttamente dal dark cabaret dei Dresden Dolls (di cui, con qualche semplificazione di troppo, potrebbero essere visti come un’emanazione più sperimentale ed eclettica). Il loro primo album Hearts on Hold è una collezione di brani dalla scrittura erratica e dagli arrangiamenti eccentrici, che strizzano l’occhio ora alla psichedelia, ora al trip hop, ora perfino al Tom Waits anni Ottanta e agli Xiu Xiu; eppure, le bellissime parti vocali di Corrina Repp (che possono richiamare con naturalezza tanto Beth Gibbons quanto Billie Holiday) danno al ribollente tessuto strumentale dei contorni ben definiti grazie a degli hook melodici che, pur nei momenti in cui la musica si fa più densa e cupa, conferiscono ad Hearts on Hold un carattere essenzialmente pop. Dopo questo disco, i Tu Fawning hanno pubblicato solo un altro (ottimo) lavoro prima di sparire nell’anonimato ed essere dimenticati da più o meno chiunque. Dopo dieci anni da uno dei dischi più particolari del panorama pop e folk del nuovo millennio, è giunto il momento di provare a riportarli alla luce. (Emanuele Pavia)
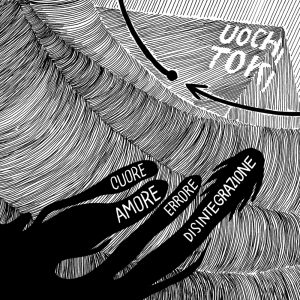
Uochi Toki – Cuore amore errore disintegrazione (La Tempesta, 2010)
Gli Uochi Toki hanno rappresentato l’esperienza musicale più sorprendente della scena musicale italiana in questo decennio, costellato da ben dodici pubblicazioni a loro nome tra album, EP e split. A fronte di molti ottimi episodi è il percorso complessivo a suscitare la maggiore ammirazione, per la curiosità mai doma di sperimentare diversi generi musicali insieme a nuovi linguaggi e mezzi comunicativi. Cuore Amore Errore Disintegrazione è il punto di rottura dell’equilibrio perfetto che si era creato su Libro Audio: le basi brillanti ed eclettiche non si fanno problemi ad abbracciare il rumore e a trasformarsi in frantumi musicali che si riconfigurano incessantemente sulle esigenze espressive; il flusso hip-hop torrenziale e ricco di metafore esplode nel mentre in cambi di prospettiva continui tra reale ed onirico, introspezione ed ispezione del reale. Una forma rotonda e ben definita non basta più a contenere una sempre maggiore complessità, per cui viene ingaggiata una battaglia contro la forma stessa e la sua fastidiosa tendenza ad aggregarsi in schemi riconoscibili. Questo principio sarà la guida di tutti i passaggi successivi degli Uochi Toki, ma è soprattutto qui che lo sforzo creatore del conflitto nutre una narrativa tanto sferzante quanto coinvolgente. CAED caedit. (Roberto Perissinotto)
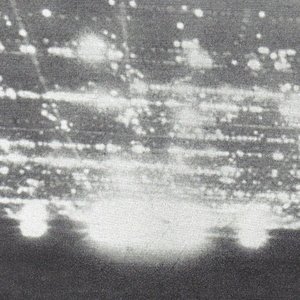
Yellow Swans – Going Places (Type, 2010)
Rappresentanti dell’onda nera di rumoristi fai-da-te rigurgitata dall’underground statunitense ad inizio millennio, gli Yellow Swans hanno via via scavato sempre più profondamente sotto la matassa di dissonanze taglienti. In Going Places raggiungono una zona viscerale in cui arrivano gli echi degli assalti sonici in superficie mescolandosi con il crepitio della vita che marcisce. Per quanto questi brani siano continuamente a contatto con il rumore, quasi come se ci bollissero sopra a fuoco lento, non ne vengono mai sopraffatti; le scariche vengono dilatate e private di materia, lasciando dei droni minacciosi a governare su una landa desolata di suoni orfani che vagano in uno spazio vastissimo. Gli interventi di chitarra elettrica filtrata fungono da luce che per contrasto evidenzia il buio imperante. Rinunciando agli assalti all’arma bianca e lavorando sui vuoti, gli Yellow Swans hanno concluso la propria carriera con l’incarnazione rumoristica più disperante e colma di solitudine. (Roberto Perissinotto)

Zs – New Slaves (The Social Registry, 2010)
Non ricordo dove l’avessi originariamente letto, ma mi pare fosse stato uno tra Klaus Dinger e Micheal Rother ad aver detto che la ripetizione in musica fosse la chiave per determinare la genialità di un artista: anche la più microscopica variazione dovrebbe essere in grado di suscitare un totale cambiamento nello spirito dell’ascoltatore. Se bisogna stare a scomodare i Neu! per introdurre il lavoro degli Zs, entità americana comprendente tra gli altri membri di Extra Life e Liturgy, si capisce che la proposta del gruppo non giocherà di certo sul sicuro. Infatti, i primi brani di New Slaves si muovono tra clangori industriali, loop di nastri mangiucchiati e suoni inintelligibili che non fanno prigionieri fino al sinistro interludio di Masonry e delle sue marimbe echeggianti nel vuoto. Quando si arriva alla title-track, un tour de force di poco più di venti minuti, si rimane inevitabilmente spiazzati di fronte a come le stesse coordinate dei pezzi precedenti possano essere rimaneggiate in un disturbante viaggio che parte dalle orme degli Swans più industriali per approdare su lidi sconosciuti: la batteria martella un 3/4 che inciampa su stesso, in cui il sax e le chitarre dettano delle geometrie che si fanno via via più confuse e allucinanti, fino a sprofondare in un mare di cacofonie e rimbalzi digitali nello spazio acustico. Il pacifico drone delle due Black Crown Ceremony prova a indorare la pillola, ma non c’è alcun dubbio che New Slaves sia ad oggi una delle esperienze più squassanti che il rock contemporaneo possa offrire. (Jacopo Norcini Pala)

James Blake – James Blake (Atlas, 2011)
Il debutto eponimo di James Blake, producer che nel 2011 aveva solamente ventitré anni e qualche EP intrigante ma fondamentale dimenticabile alle spalle, è un disco che è facile definire come polarizzante. Se si ascolta uno qualsiasi dei brani dell’album, si rintraccia quasi sempre lo stesso set di coordinate: un impianto di sole tastiere a sostenere la voce di Blake, divisa tra un crooning basso di ascendenza soul e un falsetto che proviene più o meno dalle parti di Bon Iver, che vengono progressivamente sabotate da vocoder, drum machines scheletriche e echi elettronici rubati alla garage londinese di Burial e compagnia. Una formula che rimane sempre coerente con se stessa, forse anche al rischio di risultare ripetitiva: ma gli undici brani organizzati in poco meno di quaranta minuti (tra cui spicca anche la strabiliante cover di Limit to Your Love, che Blake rende propria più di quanto l’autrice Feist abbia mai fatto) lasciano intravedere una competenza sopraffina e una creatività capace di immaginare un album che anche alla fine di questi anni Dieci suona ancora freschissimo e estremamente influente per il pop da classifica: il fatto che Blake sia oramai una presenza fissa nei dischi di celebrità come Beyoncé o Kanye West ne è la prova conclamata; eppure nulla del suo lavoro successivo riesce a competere con lo sconvolgente lirismo di questo self-titled. (Jacopo Norcini Pala)
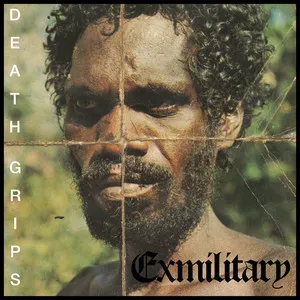
Death Grips – Exmilitary (Third Worlds, 2011)
Quando si parla di hip hop estremo è impossibile non citare i Death Grips. Nel punto più caldo della loro carriera (dopo la release di The Money Store) la fama del gruppo aveva raggiunto dimensioni mai viste prima negli ambienti alternativi – tanto da far venire a chi scrive la tentazione di conferire loro il titolo di spartiacque nella scena hardcore hip hop, almeno a livello di estetica musicale e attitudine. Burnett, Hill e Morin sono stati infatti capaci di coniare un vocabolario artistico che spazia tra deliri d’onnipotenza, assalti cibernetici e febbrili profezie di violenza, il tutto veicolato con un potere espressivo sorprendente anche per chi era abituato a quei tipi di delivery. Eventuali detrattori potrebbero far notare – in parte a ragione – che molti dei cardini stilistici della band californiana erano già stati introdotti nel genere da gruppi come i dälek o i Techno Animal, ma ciò significherebbe glissare ingiustamente sul modo visionario e completamente innovativo in cui i Death Grips sono riusciti rimaneggiare tali cifre stilistiche, creando un vocabolario da cui innumerevoli artisti avrebbero poi attinto negli anni a seguire (clipping., B L A C K I E e JPEGMAFIA in maniera personale, il Kanye West di Yeezus in maniera sterile e disgustosamente spudorata). Tra tutti i dischi rilasciati dai Death Grips, che come gli Swans si dovevano sciogliere mille anni fa ma in realtà continuano a sputar fuori roba che ormai nessuno ha davvero voglia di ascoltare, il mixtape Exmilitary resta il lavoro che meglio riassume il significato della band. Tracce come Guillotine, Spread Eagle Cross the Block o Takyon hanno ormai valore di icona, e nonostante la produzione sia lontana dall’essere perfetta tutto il loro intento artistico è già perfettamente percepibile – anzi, la sporcizia e la semplicità d’approccio a campionamenti e parti strumentali rende la violenza senza compromessi del gruppo ancora più efficace. C’è inoltre un approccio creativo che ritengo la band abbia perso dopo questo disco: anche nei suoi punti più alti, il progetto Death Grips post-Exmilitary ha finito per chiudersi in una nicchia (formata da loro, bisogna dargliene atto) senza mai fare grandi sforzi per uscirne, perdendo così buona parte dell’ecletticità che caratterizza la release di debutto. (David Cappuccini)

Demdike Stare – Tryptych (Modern Love, 2011)
In retrospettiva è incredibile pensare alla rapidità con cui i Demdike Stare si sono affermati come uno dei nomi più eccitanti della scena elettronica. Merito dei primi tre album, apparsi nel 2010 uno dopo l’altro con una meravigliosa blitzkrieg che ha dato un’altra spallata alle già traballanti staccionate poste tra i generi musicali. La conoscenza enciclopedica che Whittaker e Canty possiedono rispetto alla loro vastissima collezione di dischi è testimoniata da miriadi di mix realizzati nel corso degli anni, ma mai come in questi lavori l’esoterismo delle fonti audio da cui sono ricavati i sample si carica di una magia intensa, sapientemente amplificata dall’uso della tecnica dub. Tra gli strati sonori dalla densità magnetica emergono richiami al lato più industriale della musica da club (che poi verrà esplorato nella favolosa serie dei Testpressings), ampi orizzonti dai confini sfumati si legano a strutture ripetute con un’ossessione che si trasforma in ipnosi. I tre album mostrano una vasta gamma di soluzioni, da pezzi diretti dai temi immediatamente riconoscibili a lunghe tracce sospese tra drone e sound collage; ma tutti sono legati da una indefinibilità di fondo, con una costante sensazione che il flusso sonoro avvenga al di là della percezione. Per questo la raccolta è decisamente calzante: raramente si ha una definizione così precoce, così netta di un suono in fondo inafferrabile. (Roberto Perissinotto)

Peter Evans Quintet – Ghosts (More Is More, 2011)
Il trombettista Peter Evans è una delle personalità più richieste nella scena jazz di New York del nuovo millennio, e – come leader o come sideman – ha inciso una quantità impressionante di lavori. Ghosts è stato il primo attribuito al suo quintetto che, oltre la tromba di Peter Evans, vede un pianoforte, un contrabbasso, una batteria e un laptop, e che ha proposto una delle forme più creative e divertenti di jazz d’avanguardia che si siano potute ascoltare negli anni Dieci. Di base, la musica di Ghosts si muoverebbe nei reami di un post-bop carico di citazioni e riferimenti post-moderni a classici della canzone anni Cinquanta e del jazz più swingante – non a caso, Ghosts si apre con una rivisitazione della Christmas Song di Mel Torme. Ma il contributo fondamentale dell’elettronica spedisce questa musica verso orbite inesplorate, processando in tempo reale il suono degli altri quattro strumenti: a volte può solo suggerirne l’eco, emulandone le parti e ritardandole di qualche frazione di secondo; altre volte ne distorce e ne sabota le improvvisazioni, aggiungendo riverbero e spazzando folate elettroniche sulla musica del quartetto. Altre volte ancora, fornisce un mostruoso specchio con cui il gruppo dialoga e si confronta: è ciò che accade alla tromba di Evans nell’assurda rivisitazione di Stardust di Hoagy Carmichael, posta a fine del lavoro. Il modo assolutamente innovativo con cui il quintetto di Peter Evans è riuscito a sfruttare le potenzialità della manipolazione elettroacustica nel contesto dell’improvvisazione jazz è una delle più grandi conquiste del genere. (Emanuele Pavia)

John Escreet – Exception to the Rule (Criss Cross, 2011)
Quanto è esplicativo sia del buono stato di salute del jazz contemporaneo sia della disconnessione della critica mainstream il fatto che un disco magnifico come questo sia passato sotto silenzio? Stiamo parlando di un album tanto capace di prodigarsi in impeccabili numeri post-bop quanto di tuffarsi a capofitto in composizioni avant-jazz ora incontenibili ora meditative mantenendosi sempre godibilissimo e che nel mezzo riesce pure ad infilare un pezzo elettroacustico che si evolve in progressive electronic dagli echi balearic. Fate giustizia e recuperate questo gioiello. (Roberto Perissinotto)

Fleet Foxes – Helplessness Blues (Sub Pop, 2011)
Il disco dove la formula dei Fleet Foxes sboccia nella sua rappresentazione più compiuta, rinunciando alla compostezza agreste delle melodie tenui per esplorare tutte le sfumature della propria tavolozza musicale. Le celestiali armonie vocali si intrecciano dolcemente a fughe psichedeliche per dipingere un’Arcadia elettrica ed elettrizzante. Una produzione magistrale per densità e dettaglio rende il suono di Helplessness Blues incredibilmente fragrante e materico, un manufatto di lucente bellezza che resiste allo scorrere del tempo. (Roberto Perissinotto)

Flourishing – The Sum of All Fossils (The Path Less Traveled, 2011)
In circa tre anni effettivi di attività, i Flourishing hanno fatto in tempo a pubblicare due EP e un full-length, prima di sciogliersi nel più totale anonimato e sparire dai radar; solo l’anno scorso sono tornati, con essenzialmente la stessa formazione, con un 7″ a nome Aeviterne, anche quello ovviamente passato completamente inosservato. Eppure, il loro unico album The Sum of All Fossils va considerato a pieno titolo come uno dei dischi più unici e innovativi dell’intero panorama metal del decennio. Superficialmente, è un album che si potrebbe collocare in quel trend di death metal vorticoso e atmosferico del nuovo millennio che riparte dagli Immolation e dai Gorguts, passa per i Neurosis e giunge infine fino agli Ulcerate (tutte influenze effettive, in ogni caso); e anche i testi, che guardano con taglio tragico ed esistenzialista la transitorietà della condizione umana, rendono ulteriormente evidente questo rapporto di filiazione. Ma ascoltando con maggior attenzione, facendosi strada tra gli assoli dalla disperata emotività schuldineriana, i dissonanti interplay di chitarra e basso, i riff dal particolare e deviato senso melodico, i suoni distorti da una produzione magmatica e fangosa, e rumori alieni di fondo di ogni tipo, diviene impossibile non ascrivere i Flourishing a una tradizione di rock new yorkese che, ancora prima che dai Brutal Truth e dagli Human Remains, prende piede addirittura dagli Swans, dai Sonic Youth, da Glenn Branca e dagli Unsane. Macinando grindcore, death metal, post-hardcore, noise rock e musica industriale in una sintesi musicale a dir poco miracolosa, i Flourishing di The Sum of All Fossils sono giunti a un suono praticamente senza precedenti – e, sfortunatamente, ancora senza eredi. (Emanuele Pavia)
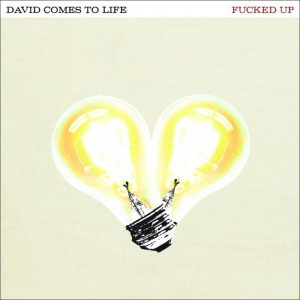
Fucked Up – David Comes to Life (Matador, 2011)
A un certo punto, nel 2011, i Fucked Up (un gruppetto post-hardcore/art-pop punk, già famoso per Hidden World e The Chemistry of Common Life nei circoli giusti) hanno completamente trasceso qualsiasi legame con il mondo terreno partorendo-cagando un album che definire accecante è un eufemismo. David Comes to Life.
Comincia teneramente con un crescendo di matrice quasi post-rock con un’aspirazione chiara e una smania ancora più evidente: Let Her Rest è una forma di messianesimo in cui il disco stesso è il messia, finalmente, paradossalmente, visibile. Da Queen of Hearts fino a Lights Go Up i Fucked Up scivolano in settantacinque minuti di un’emotività così forte e iperbolica da rendere impossibile all’ascoltatore distogliere lo sguardo, l’orecchio. David rende avidi, la crispness del compartimento strumentale – tre chitarre che sono trecento chitarre – lascia sgranati e affamati all’inseguimento di un album dal pacing velocissimo e da pianto nervoso. L’atteggiamento opera del complesso crea uno smarrimento totale in un delta erratico ed ebbro, quanto dura? Quanto ce n’è? Vogliono fare Zen Arcade, The Shape of Punk to Come, The Ascension? Ma saranno scemi? E perché ci stanno riuscendo?
All’ultima domanda lo smarrimento intellettuale provocato dall’opera punk uscita dal cappello nel 2011 esonda in un’accettazione romantica e indiscutibile della regola dettata dai Fucked Up, che negli anni successivi non avrebbero più ripetuto il trick, parzialmente svuotati del loro serbatoio di creatività. Un picco mistico per un genere che in questi anni sta giocando schermaglie più palustri, eppure il cappello è ancora lì, e qualcosa ne può uscire ogni tanto, basta il giusto mago e il giusto pubblico: forse è davvero sul podio dei dischi della decade, o forse io e i Fucked Up siamo solo i ballerini giusti. Tutto quello che so è che quando metto su David Comes to Life non vorrei ascoltare nient’altro. (Alessandro Corona)

Tim Hecker – Ravedeath, 1972 (Kranky, 2011)
Tim Hecker è, senza nessun dubbio, il più importante produttore di musica ambient in circolazione. Oramai totalmente abbandonato il minimalismo geografico di scuola Eno utilizzato su An Imaginary Country, lo stile di composizione di Hecker sembra essersi cristallizzato in una contrapposizione perpetua: da una parte un caleidoscopio sonoro in continua mutazione ed espansione, dall’altra l’invidiabile maestria con cui i brani di Ravedeath, 1972 facciano “fatica” ad evolversi. Le virgolette sono necessarie: basti ascoltare la suite in tre parti di In the Fog per rendersi conto di come il tempo sia per il musicista un ulteriore elemento con cui cimentarsi. Le ripetizioni, le aggiunte e le sottrazioni che si avvicendano nel complesso arazzo sonoro della musica sono lentissime ed estremamente cinematiche: i bordoni dei sintetizzatori e dell’organo a canne si impastano lentamente con un non meglio identificato rumore distorto in lontananza, fino a che non emergono da questa nebbia delle minuscole figure di pianoforte cristallino manovrato dal collega Ben Frost. Se In the Fog non bastasse a convincervi, il resto del disco non è da meno: dall’intermezzo celestiale di No Drums alle onde riverberate di Studio Suicide, 1980, Tim Hecker dipinge un acquerello dai toni artici che trova la propria liberazione nell’altra suite tripartita del disco, In the Air, con il pianoforte a fronteggiare un oceano di disturbi elettronici per l’ultima volta, prima di essere inevitabilmente fagocitato per un’ultima volta dal rumore. Ravedeath è un buco nero, e non ne uscirete facilmente. (Jacopo Norcini Pala)

I Am a Lake of Burning Orchids – Summer in My Veins (Loveswirls, 2011)
Non siamo quello che eravamo – siamo anche quello che eravamo.
Summer in My Veins è una menzione onorevole, è bello, non è importante, per me è tremendamente importante. Il primo disco harsh noise che abbiamo ascoltato è stato un idillio melodico, al limite del flirt con il “wall noise” tanto quanto con il dream pop, in un triangolo che all’epoca sembrava strano ma che ora è solo un po’ malinconico, come tutto. I Am a Lake of Burning Orchids ha più o meno la nostra età, è un ragazzo, un ex soundpainter impressionista, che mentre vivevamo l’adolescenza ha avuto la cura di mettere colori su bianco tutto quello che non ci è passato per la testa: altre cerchie e altre vite ci hanno portato a scoprire un piccolo disco-mina per amare, vivere e sbagliare. Quello che rimane all’alba del 2020 a riascoltare Summer in My Veins è strano, un po’ posticcio e dolciastro, ci ricorda dei tempi di bandcamp in cui avevamo la forza e il tempo di recensire un disco (spesso mediocre) ogni giorno, per il puro gusto della diffusione, per stakanovismo e passione. Ricordo l’impatto con la title track con una vividezza impressionante, l’overdose sintetica al termine di I Hereby Promise…, la citazione melliflua che dà il nome a No One Will Ever Love You as Much as I Do e soprattutto il crescendo power noise di A House of Golden Light, da cui ho imparato quanto può cambiare un giudizio con la giusta chiave di lettura, e da lì cominciai davvero a scrivere. Ma il confronto con il passato, per quanto peso, è sempre un richiamo alla realtà. Riascoltare tutto Summer in My Veins oggi ne tradisce sicuramente la primitività e la mancanza di visione d’insieme, eppure c’è ancora qualcosa che eleva I Am a Lake of Burning Orchids dai più famosi esponenti dell’harsh – Prurient, Swanson…
Credo che sia perché il suo mezzo di espressione è sostanzialmente un povero pop giovanile in una caverna di rumore, e non un noise da club decostruito e incancrenito, cosa che lo rende un disco sincero, stupido e antipatico. Ciononostante, è ancora bello – per quel motivo, era proprio perfetto. (Alessandro Corona)

Matana Roberts – Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libres (Constellation, 2011)
Nel romanzo più famoso di Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, il protagonista Billy Pilgrim si ritrova inspiegabilmente “spastico nel tempo”, condannato a saltare senza controllo da un istante all’altro della propria vita rivivendo di continuo gli orrori della guerra e delle proprie tragedie personali. Il progetto Coin Coin di Matana Roberts, sassofonista di scuola AACM, si muove nella stessa direzione del libro di Vonnegut, ma allargando il campo e cercando di ricostruire una storia intrinsecamente fratturata come quella dell’America nera, una narrazione che viene ancora ingiustamente sottovalutata nella cronaca ufficiale: Gens de couleur libres, primo capitolo di un work in progress che dovrebbe estendersi per dodici episodi, mostra una creatività encomiabile legata a una maturità politica senza paragoni nel decennio appena terminato. Registrato live in uno studio per pochi fortunati spettatori, l’ensemble di quindici elementi comandato dalla Roberts si muove quindi tra sbandate free (l’opener Rise con le sue linee angolari di sax) e swing allucinati (l’attacco di Song for Eulalie) per esplodere in esplorazioni timbriche al confine con la free improvisation di certi lavori dell’Art Ensemble of Chicago. Il field holler di Libation for Mr. Brown, con il suo testo che istrionicamente attacca il disastro schiavista statunitense, lascia spazio prima allo spettrale tappeto avant-jazz di Lulla/Bye e poi ad I Am, il brano più lungo del disco, che nei suoi dieci minuti lascia sfogare la voce della Roberts in delle urla disperate sopra al frastuono degli ottoni, in cui la narrazione si sdoppia ancora una volta tra il francese e l’inglese su un riff ossessivo accentuato dal puntinismo rumoroso della chitarra. La ninnananna creola di How Much Would You Cost rompe finalmente l’incantesimo, e appena la storia finisce Matana Roberts è al centro del palco, vittoriosa. (Jacopo Norcini Pala)

Ulcerate – The Destroyers of All (Willowtip, 2011)
Gli Ulcerate sono probabilmente il gruppo death metal più importante di questo decennio, sia a livello di riconoscimenti conseguiti tra gli addetti ai lavori, sia a livello di influenza esercitata, sia per mera creatività e modernità della proposta. Ciò che gli Ulcerate hanno fatto in ambito death metal è del tutto analogo a quanto fatto dai Deathspell Omega in ambito black: hanno preso il genere e l’hanno reso contemporaneamente più elaborato, più violento, più dissonante e più maestoso.
Se è vero che già Everything Is Fire aveva introdotto il loro suono “classico”, conteso tra una forma particolarmente brutale e vorticosa di death metal e momenti più dilatati mutuati dal post-metal, è però questo terzo album che riesce a conciliare al meglio le due anime della musica degli Ulcerate. Le aperture atmosferiche appaiono ora maggiormente integrate (sia dal punto di vista musicale che da quello umorale) nella base death metal, contribuendo a sovraccaricare i brani di una tensione drammatica e asfissiante che si risolve, inevitabilmente, in esplosioni apocalittiche dominate dalle ardite disarmonie della chitarra e dal drumming straripante di Jaimie Saint Merat – probabilmente, il più grande batterista metal di questa generazione. The Destroyers of All non è soltanto uno dei dischi che hanno definito il suono metal degli anni Dieci, ma è anche uno dei lavori più tragici ed emotivamente intensi della storia del genere. E il suo concept misantropo/ambientalista, incentrato sull’arroganza dell’umanità e sul suo rapporto distruttivo con la natura, lo rende per di più estremamente attuale. (Emanuele Pavia)
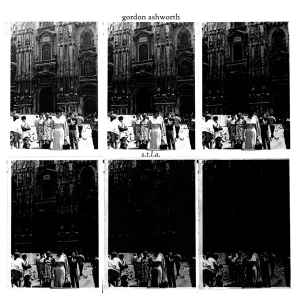
Gordon Wilson Ashworth – S.T.L.A. (latrogenesis, 2011)
Gordon Ashworth è il fratello meno conosciuto di Owen Ashworth, che ha trovato successo nei Noughties col progetto Casiotone for the Painfully Alone. Progetto di cui io non ho mai sentito neanche una nota, se vogliamo essere onesti, ma dirò lo stesso che Gordon è il più talentuoso dei due – poi se in realtà mi sono perso un imprescindibile capolavoro dell’indie pop triste con venature elettroniche fatemi un fischio. Battutine a parte, S.T.L.A. è un disco profondamente evocativo che si trova al centro di un triangolo fatto di free folk, ambient e field recordings; le tracce sono di ampissimo respiro, dominate da droni e campionamenti (Norma) o da parti di piano che rimbombano ed echeggiano per poi confondersi tra voci masticate e fruscii (Suite for Broken Sex, To Be the Man I Want to Be), o ancora da arpeggi di chitarra che portano alla mente una sorta di primitivismo americano distorto e disordinato (Desperate & Indebted). Ora, parlare di un disco che ha il punto di forza nelle atmosfere in cui ti immerge, quando non ha una programmaticità interessantissima dietro come Everywhere at the End of Time o i Disintegration Loops, è per me assai difficile poiché mi pare di descrivere cose che sono tutte uguali. Droni tappeti sonori eccetera, va bene ecco ogni disco ambient mai registrato. Dirò quindi che S.T.L.A. è un album i cui suoni fanno pensare a grandi stanze vuote piene di vecchie cose strane o sconosciute – stanze in cui sei libero di curiosare con uno spirito che passa dalla nostalgia al disagio, dalla dolcezza nel vedere una vecchia foto di famiglia alla tristezza nell’accorgersi dei sorrisi spenti e forzati delle persone ritratte. (David Cappuccini)

Aluk Todolo – Occult Rock (Norma Evangelium Diaboli, 2012)
La Francia è diventata, almeno dall’inizio di questo millennio, un nuovo, inaspettato rifugio per alcune delle branche di metal più estreme e avanguardistiche degli ultimi tempi: gli Aluk Todolo, trio parigino attivo dal 2004, sono solo una delle tante conferme di questo fertilissimo periodo dei cugini d’oltralpe. La manata in faccia assestata dal primo degli otto brani senza nome di Occult Rock è praticamente un manifesto dell’interpretazione del gruppo del black metal: un tremolo picking ossessivo, un blast beat che non finisce mai, un basso che sembra mixato dentro una caverna sott’acqua… Se questi elementi vi sembrano standard nel tipico calderone black metal, lo spin che gli Aluk Todolo impongono alla propria musica proviene dai vicini tedeschi: gli ingredienti di cui sopra costituiscono un frastuono infernale che viene ripetuto fino allo stremo con variazioni microscopiche per oltre dieci minuti, con echi di feedback che si aggrovigliano nel pochissimo spazio sonoro rimasto indenne. L’effetto è quello di un desolante horror cosmico, e l’abilità degli Aluk Todolo è quello di sapere quando premere sull’acceleratore o di tirare il freno a mano: il resto del primo disco si muove tra midtempo dal sentore post-punk, scheletriche linee di chitarra e ritmi sempre più rarefatti e spettrali, per giungere nella sesta traccia persino a una ossessiva figura di chiara declinazione slintiana, prima di sciogliersi nel finale squisitamente doom. Occult Rock è una boccata d’aria fresca per gli appassionati di psichedelica e per i metallari duri e puri, una bestia rara e sfuggente. (Jacopo Norcini Pala)

Richard Barrett – Dark Matter (NMC, 2012)
Dark Matter è un’opera che, per volontà esplicita del suo autore, vuole essere criptica e indecifrabile. È una celebrazione di ciò che, nonostante i tentativi dell’umanità di ampliare le proprie conoscenze, rimane caparbiamente relegato nell’ignoto, e il titolo è un aperto riferimento alla materia oscura dell’astrofisica; pertanto, la musica che si cela dietro questa composizione è tra le più dense e cerebrali che si possano ascrivere al movimento della New Complexity. Dark Matter si gioca tra l’alternarsi di sezioni per un ensemble di diciannove elementi, con voce mezzo-soprano ed elettronica, e altre pensate invece per sola chitarra ed elettronica (che compongono una sotto-composizione di sei movimenti denominata transmissions). Le prime compongono il nocciolo musicale dell’opera, dallo sviluppo inafferrabile nonostante le fitte sottotrame di simmetrie, palindromi e ripetizioni che si celano dietro la densissima mole di eventi sonori; le seconde sono invece un riuscito tentativo di reimmaginare la chitarra, sia acustica che elettrica, in un contesto contemporaneo. Quella di Dark Matter è una musica particolarmente difficile, pure considerando il solo ambito della musica colta; ma proprio questo suo carattere caparbio e incompromissorio, che non offre all’ascoltatore appigli facilmente raggiungibili, unito a una palette sonora e timbrica che rimastica liberamente oltre cinquant’anni di avanguardie (da Iannis Xenakis e Pierre Boulez ad Anthony Braxton e Derek Bailey), la rende particolarmente affascinante. Ultimata nel 2002, Dark Matter è stata comunque pubblicata per la prima volta soltanto nel 2012: questa registrazione ad opera dell’ensemble ELISION (specializzato nell’interpretazione di composizioni della New Complexity, e già uso alla musica di Richard Barrett) è, per ora, l’unica opzione possibile per poter ascoltare uno dei capolavori più sfuggenti della musica d’avanguardia del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

Cloud Nothings – Attack on Memory (Carpark / Wichita, 2012)
I Cloud Nothings di Dylan Baldi sono sempre stati un progetto da poco di buono, un’appassionata e stralunata esperienza indie-emo che ha colpito il midwest in ritardo di una quindicina d’anni. E per dare un’idea dell’aria che tira in certe calli a nessuno della redazione piacciono nemmeno gli American Football. Però…
Attack on Memory, complice ovvio una produzione che non ha bisogno di alcuna presentazione, è una pietra dura del post-hardcore che si incastra perfettamente nel canone con riflessi calcarei che spaziano dai For Carnation ai Wipers, dagli Shellac agli At the Drive-In. Il disco si trascina con una piacevole fatica in una rocking chair che alterna il suo equilibrio con riff salati e coinvolgenti in principio e brani dall’angolarità déco in finale. Tutto il disco si tinge di una scala reale di grigiori che mantengono alta l’attenzione e cuociono fino allo sfinimento incanalando tutte le sfaccettature della noia e scolpendole con un gusto e una scaltrezza fuori dal comune. Wasted Days, che copre il doppio della lunghezza delle altre tracce, è un trattato post-nevrotico delle possibilità che una normalissima garage band può ricavare da una singola idea, Fall In e No Sentiment sono degli anthem pseudo-emo che non hanno un cazzo da invidiare ad alcuni brani dei Built to Spill e tanto basterebbe. Come successo con i Fucked Up, a uno scalino inferiore, i Cloud Nothings non hanno tenuto botta e il loro lavorone rimane un granaio solitario nel panorama rustico e opprimente dell’indie rock del decennio, peraltro tenuto su da assi che, come per tutti i grandi album recenti di questa corrente, hanno imprinto a lettere cubitali sul loro legno il seriale degli anni Novanta. Attack on Memory, come da copione, inaugurò a tutti gli effetti la nuova nostalgia. Il botto ai tempi fu una sensation che creò un po’ troppo rumore inutile, ma riascoltarlo tutto nel silenzio della storia, restituisce un’impressione di segno opposto, e il vento soffia, e si torna a respirare. (Alessandro Corona)

Vijay Iyer – Accelerando (ACT, 2012)
Già in tempi non sospetti (era stato il tastierista di Steve Coleman nel capolavoro Genesis & The Opening of the Way, a cui abbiamo già accennato su queste pagine) Vijay Iyer si era fatto notare come un profilo interessante tra le nuove leve del jazz: successive collaborazioni con artisti del calibro di Steve Lehman e Tyshawn Sorey sembravano presagire un inevitabile approdo alla Pi Recordings. Invece Iyer, che oltre a essere pianista è laureato in matematica e fisica, è passato alla scuderia tedesca ACT, dove ci ha regalato quelli che sono, ad oggi, i momenti più alti della sua carriera: Historicity, del 2009, e questo Accelerando, sempre in un trio costituito da piano, contrabbasso e batteria. Iyer, accompagnato da Stephan Crump e Marcus Gilmore, si destreggia tra composizioni originali (tra cui spicca Optimism, che toglie il fiato con il suo swing proteiforme) e cover che spaziano tra semisconosciuti gruppi disco, Michael Jackson, Flying Lotus, Duke Ellington e Henry Threadgill. Le reinterpretazioni di Iyer fanno tutto meno che attenersi alla forma originaria dei pezzi: la Human Nature di Jackson, ad esempio, è trasfigurata in una esplorazione ai limiti del free tra gli strumentisti, che fanno barcollare l’impalcatura del pezzo fino a rovesciarla come un calzino. La voce del piano regna comunque sovrana all’interno di questo piccolo, giocoso ecosistema: a metà tra i cluster astrusi di monkiana memoria, una sensibilità figlia delle esperienze d’avanguardia di gioventù e un gusto per la melodia che rende i suoi assolo un’esperienza trascinante e cerebrale allo stesso tempo, Vijay Iyer è (nonostante il recente passaggio alla ECM, che sembra averne castrato alcune delle intuizioni più geniali) tuttora una presenza immancabile nel pantheon del nuovo jazz del millennio. (Jacopo Norcini Pala)

Jam City – Classical Curves (Night Slugs, 2012)
Nel 2012 ancora nessuno parla di deconstructed club, l’etichetta che a fine decennio verrà riconosciuta come il lascito principale dell’elettronica 10s; eppure quel suono è già qui, i germi sono presenti ma il big bang avviene nel disco d’esordio di Jam City. I beat che suonano come vetri infranti, le ritmiche martellanti sempre sul punto di incagliarsi, gli elementi tematici racchiusi in flash taglienti che sanno di violazione in mezzo ai sample convulsi. In The Courts e nelle due riprese di Hyatt Park Nights c’è già tutto quello che serve. Ma Classical Curves non è un disco nichilista, come poi cercheranno di esserlo tante uscite che applicheranno questa ricetta ai dettami techno, gabber o hard trance puntando all’aggressione pura; anzi tradisce la passione per l’elettronica ottantiana e novantiana nelle sue propaggini più languide e ne abbraccia il sentimentalismo, ma riesce a farla suonare sconvolta come mai prima. Le melodie ci sono eccome, ma sono messe a nudo ed esposte con oscena freddezza, poi tormentate con continui stop-and-go e ricontestualizzate in ambienti non familiari. La dance music del decennio ne esce come un corpo straziato di cui avvertiamo le palpitazioni tra le lamiere della copertina. (Roberto Perissinotto)

King Tears Bat Trip – King Tears Bat Trip (Tables & Chairs, 2012)
L’eredità di Albert Ayler è sempre stata una delle più depredate nell’ambito del free jazz più spirituale ed estatico, e le cose non sono cambiate particolarmente in questo decennio. E una costante di quasi tutti i tentativi di emulazione è quella di risultare assolutamente prescindibili se non imbarazzantemente amatoriali. Fa eccezione questo King Tears Bat Trip, esordio e unico album dell’omonima band di Washington, che con ragionevole certezza si pone come la più personale, creativa e originale variazione sul tema Albert Ayler del decennio. I lead del sassofono tenore di Neil Welch rimandano ovviamente allo stile del gigante di Cleveland, ma l’applicazione della distorsione al sax, l’utilizzo di una chitarra con sei corde uguali e accordatura triviale, le ben quattro batterie che oscillano in continuazione tra tribalità afro e poliritmi caraibici, e infine il chango (uno strumento digitale di invenzione degli stessi King Tears Bat Trip) ribaltano il tradizionale lessico free/spiritual jazz, spingendolo verso lidi rumorosi che hanno più a vedere con il noise rock e il primitivismo sciamanico di Boredoms, Shit & Shine, Crash Worship. (Emanuele Pavia)

Lil Ugly Mane – Mista Thug Isolation (Hundebiss, 2012)
Uno dei grandi trend nell’hip hop dell’ultimo decennio è stato il ritrovato interesse per l’horrorcore di Memphis, figlio ancor più sudicio di un sottogenere – il dirty south – che grazie a gruppi come gli UGK e i Geto Boys già si era contraddistinto in termini di aggressività e depravazione. Sempre negli anni novanta, un po’ separato da questo panorama troviamo DJ Screw, in un mondo a sé stante a livello di sound ed estetica ma comunque indissolubilmente legato alla scena originaria. Le basi su cui si fonda il disco oggetto di questo trafiletto sono quindi facili da delineare: la violenza primigenia degli OG viene da una parte estremizzata e sporcata ulteriormente fino a diventare horrorcore, dall’altra dissezionata e distorta fino a diventare chopped & screwed; la convergenza di queste due attitudini costituisce il cuore di Mista Thug Isolation. Il cimitero è dunque in ordine, le bare pronte ad essere scoperchiate, il terreno fertile di vermi; l’unica stranezza è che il tombarolo prescelto sia Travis Miller, un ragazzo bianco (ed è un fattore importante date le radici interamente afroamericane del genere) col nome d’arte di Lil Ugly Mane. Questo suo album di debutto è importantissimo per vari motivi: stabilisce un precedente estetico con cui chiunque voglia appropriarsi delle influenze sopracitate dovrà confrontarsi; opera creative e sostanziali variazioni su suoni e tematiche, plasmando e modernizzando le atmosfere mantenendo però un alto grado di coerenza; riesce a fare queste due cose senza risultare un patetico outsider o, peggio, una sanguisuga. A mio parere, la chiave della sua riuscita è il tipo di autoironia di cui è ricolmo Mista Thug Isolation, autoironia che nasce non dal desiderio di ridicolizzare o sembrare edgy, bensì da una grande consapevolezza della propria posizione e da una ricerca che trova sia la maniera di omaggiare e richiamare le tendenze del passato sia quella di interiorizzarle per esprimere efficacemente la propria personalità. (David Cappuccini)

Metá Metá – MetaL MetaL (Desmonta, 2012)
Non è un segreto che il Brasile sia la realtà musicale più affascinante dell’intero continente sudamericano: la nazione ha un’offerta immensamente variegata che da quasi un secolo ha conquistato il Nord globale a più riprese. Il samba divertito di Carmen Miranda, la bossa di Jobim o la saudade psichedelica dei vari Zé, Gil e Veloso avevano però contributo ad alimentare lo stereotipo del sound brasileiro come lounge music, o più in generale, come musica da non prendere troppo sul serio: tutto questo a dispetto del fatto che l’avanguardia sonora fosse una componente ben inserita nel gigantesco panorama della nazione. In ogni caso, i Metá Metá non hanno problemi ad affrontare a muso duro questo canone immaginato dall’orecchio straniero, e la musica contenuta nel loro secondo disco MetaL MetaL si presenta come una delle invenzioni più originali del decennio: un’attitudine spiccatamente punk e caciarona (che si manifesta soprattutto negli interventi della chitarra schizofrenica di Kiko Dinucci) e che tuttavia si fonde alla perfezione con il jazz di derivazione free dei fiati maneggiati da Thiago França e con il cantato tipicamente verdeoro di Juçara Marçal. Ecco quindi che ai momenti più controllati e tradizionali (São Jorge, Tristeza Não) si alternano le urla sguaiate della breve Exu, la cavalcata desertica di Man Feriman e i riff spigolosi di Oya e Logun, in un girotondo di stili che, contro qualunque predizione, suona sempre brasiliano fino al midollo. L’etica do it yourself e i testi surreali sono solo l’ennesimo sfarzoso ricamo che impreziosisce l’arazzo dei Metá Metá, e che ne fanno una delle band più interessanti da tenere d’occhio anche negli anni a venire. (Jacopo Norcini Pala)

Pop. 1280 – The Horror (Sacred Bones, 2012)
Anche se gli ultimi dischi li hanno visti reinventarsi come mediocre gruppo tra industrial rock elettronico e synth punk gotico, nei primi anni Dieci i Pop. 1280 hanno pubblicato un EP e due full-length che hanno segnato profondamente l’estetica noise rock moderna. Soprattutto in The Horror, i Pop. 1280 hanno coniato un suono asfissiante, violento e psicotico, che ha recuperato un’intera tradizione di noise rock new yorkese iniettandovi dosi ingenti di angoscia della stagione post-punk e darkwave. Il terrorismo di The Horror è dal carattere psicologico prima ancora che sonico, anche per via dell’utilizzo subliminale (e molto innovativo) dell’elettronica. Ed è probabilmente questa componente claustrofobica il maggior contributo che The Horror ha dato al genere nel nuovo millennio: per inquadrare al meglio le proposte dei maggiori campioni del noise rock moderno, dai White Suns fino a Tropical Fuck Storm, Daughters e Show Me the Body, è ormai indispensabile ripartire, tra gli altri, anche dai Pop. 1280. (Emanuele Pavia)

Roomful of Teeth – Roomful of Teeth (New Amsterdam, 2012)
Leggendo le parole “musica corale”, la mente vola immediatamente a degli scenari prevedibili: i volteggi medievali di Sant’Ildegarda, le messe mozartiane, qualche impavido azzarderà al fantasmagorico requiem di Ligeti… Eppure, ascoltando i Roomful of Teeth capitanati da Caterine Shaw, si ha l’impressione di assistere alla reinvenzione della ruota. L’ensemble gioca abilmente con le tipiche armonie del coro, introducendo di volta in volta delle derivazioni totalmente aliene anche alla classica contemporanea (si pensi all’imitazione dei giochi vocali inuit e al canto armonico tibetano adoperati a fasi alterne nella maestosa Partita for 8 Voices) e iniettando una sensibilità contemporanea figlia dei soliti Reich e Glass (A E I O U e Allemande) per cui la complessità non eccede mai il godimento della melodia e dell’armonia. Le potenti fondamenta innalzate dai bassi forniscono una base che sembra ideata apposta per permettere all’ascoltatore di muoversi con la propria voce al di sopra di essa, solamente per poi voltare immediatamente pagina e proiettare lo scenario in un contesto assolutamente differente (ne è esempio la spettacolare Amid the Minotaurs). I Roomful of Teeth sono forse quanto di più esplicitamente umano sia possibile ottenere dalla musica classica al giorno d’oggi.
(Jacopo Norcini Pala)

Shackleton – Music for the Quiet Hour / The Drawbar Organ Eps (Woe to the Septic Heart, 2012)
Questo disco è il coronamento di un percorso che ha visto Shackleton affermarsi come il più potente sciamano in grado di evocare ritmi tribali in mezzo a braci UK bass e fumi dub, accoppiando una grande prolificità ad uno standard qualitativo elevatissimo. La raccolta di EP funge da ottimo sunto di questa esplorazione, ma è in Music for the Quiet Hour che Shackleton libera gli spiriti più potenti, facendo esplodere il suo suono in così tante direzioni da renderlo distopico. Sempre potentemente ritmico ma allo stesso tempo fantasmagorico, l’ambiente creato da questa musica è un brodo primordiale in cui prendono vita continuamente nuove creature; e non sono amichevoli. Il quarto pezzo potrebbe essere un serio candidato come brano del decennio. (Roberto Perissinotto)
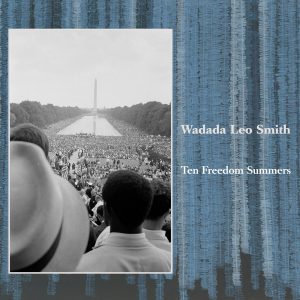
Wadada Leo Smith – Ten Freedom Summers (Cuneiform, 2012)
Scritto meticolosamente nell’arco di trentaquattro anni, dal 1977 (anno in cui fu composta Medgar Evers) al 2011 (quando fu terminata Freedom Summer), e infine registrato live nel novembre dello stesso anno, questo lavoro dalla ragguardevole durata di quattro ore e mezza racchiude la summa dell’esperienza musicale e creativa di Wadada Leo Smith. Ten Freedom Summers è un’opera monumentale, che si prefigge lo scopo di esplorare i temi dei movimenti civili sorti in America tra il 1954 e il 1964. Ogni brano di Ten Freedom Summers è infatti dedicato a un episodio o a una figura chiave per la storia di tale movimento – il che include, oltre a Malcolm X e a Martin Luther King Jr., anche eventi di molto precedenti come il caso Dred Scott del 1857, o di molto successivi come l’11 settembre, o ancora i media, i governi e le interazioni umane sullo sfondo di tali avvenimenti. Ma, cosa più importante, Ten Freedom Summers è un vero e proprio capolavoro di musica autenticamente americana: i diversi movimenti dell’opera si articolano lungo complesse suite dal minutaggio sostenuto, spesso senza nemmeno motivi ricorrenti a offrire un appiglio all’ascoltatore, che assorbono le forme della musica tardo-romantica e modernista del Novecento americano (da Charles Ives ed Henry Cowell fino a Morton Feldman), dell’avant-garde jazz, del blues. E per questo, Leo Smith sceglie di accompagnarsi, alternativamente, con il suo Golden Quartet (che comprende vecchie istituzioni dell’AACM come Anthony Davis, Pheeroan akLaff, Susie Ibarra e John Lindberg), con i nove musicisti del Southwest Chamber Music ensemble, o con entrambi allo stesso tempo. Quella di Ten Freedom Summers è una musica intensa emotivamente e profonda dal punto di vista intellettuale: non è affatto assurdo considerarla come il vertice dell’intera produzione di Leo Smith. (Emanuele Pavia)

Disclosure – Settle (PMR / Island, 2013)
È possibile realizzare un disco di musica elettronica che sia allo stesso tempo modaiolo e innovativo, di tendenza ma sensibile a tutti i fermenti dell’undeground, palatabile per le grandi masse danzanti ma forgiato nella conoscenza appassionata della tradizione? I sessanta minuti di Settle sono una grandiosa risposta affermativa. Il duo inglese riesce a far convivere stanze di specchi futuristiche tra UK bass e future funk, pezzi vocali tanto venati di neo-soul quanto inclini ad inflessioni post-dubstep, un grande gusto nell’uso dei sample vocali che evocano ora la malìa della deep house, ora la grittiness della UK garage più stradaiola. Anche nelle combinazioni che sulla carta potrebbero diventare materiale da radio (italiane, s’intende) riescono ad uscirsene con gran classe, grazie ad un senso della misura impeccabile tanto nella scelta e nella direzione delle collaborazioni quanto nel dosaggio degli elementi, unitamente ad una produzione in stato di grazia. Non poteva durare, e non durerà; ma intanto, come i Justice avevano aggiornato la posa french house alla sua versione più rumorosa e tamarra, i Disclosure portano la UK bass all’apice della coolness. (Roberto Perissinotto)

Joe Hisaishi – Kaguya-hime no Monogatari (Studio Ghibli, 2013)
Non è particolarmente elegante inserire soundtrack all’interno di una classifica di questa portata, soprattutto se la soundtrack non è d’autore ma è frutto di una collaborazione storica. Non ce ne fotte un cazzo. La storia della principessa splendente è stato uno dei film più intensi partoriti dal Ghibli e Hisaishi nella prova è al suo meglio, con livelli che toccano senza difficoltà le altezze di Mononoke Hime e di Spirited Away: la temistica della soundtrack emerge spontaneamente dalle pennellate di ambiance del film – e la chiave di lettura che sconvolge tutta l’esperienza, che rende l’onore delle armi alla composizione come regia (e che infatti viene dalla penna di Takahata), è nella nenia scenica dei bambini della terra e nella scivolante e inquietante versione della celestiale. Ogni tema è un inno minimalista sullo specchio tra natura e cultura, con la prima celebrata e incoraggiata nelle dolci lullaby di The Joy of Living, The Sprout, SpringWaltz, Flying e la seconda temuta e turbata nell’Overture, in Light, Setting Out, Despair e con un grandissimo e dolorosissimo confronto a cuore aperto nel tema di Mountain Hamlet e The Coming of Spring, che con poche note di piano lascia trasparire tutta la contraddizione incolmabile che commuove e dilania la storia di Kaguya e le versioni dei vari theme che ricompaiono cadenzatamente nel corso del disco. Il tour de force emotivo di Hisaishi si infrange rovinosamente verso la fine della soundtrack nel suo più grande tentativo di paradosso, The Procession of Celestial Beings, una marcetta allegra e reminescente addirittura di alcuni vezzi di Hirasawa, che accompagna la scena più tragica dell’intera pièce lasciando uno strato di inquietudine nervosa e smarrimento che non risolve nell’infinita tensione umana che grava su chi conosce la storia di Kaguya. Il riflesso pallido e abbagliante della luna (The Moon) che accompagna in pieno perturbante la release nella sua totalità, sfuma in un solo modo: il dualismo tra celestiale e terreno si sommerge nell’unica vera esperienza universale che, convenientemente, è affidata alla musica. Chi vive una delle due vite non potrà mai trovare la pace né nei fiati dello Spring Waltz né nei cluster di Despair, ma una cosa accomuna il ventre e le ali, e Hisaishi e Takahata hanno dato un indizio fin troppo forte. Maware maware maware yo…(Alessandro Corona)
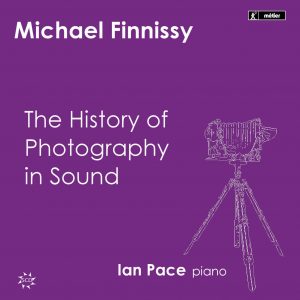
Michael Finnissy – The History of Photography in Sound (Metier, 2013)
Di primo acchito, The History of Photography in Sound sembrerebbe fuori posto in una lista dei migliori dischi degli anni Dieci: si tratta di un ciclo di undici brani per solo pianoforte, di durata variabile (dai tredici fino ai sessantasette minuti, per un totale di quasi cinque ore e mezza), composti tutti tra il 1995 e il 2001 – rientra a malapena nel nuovo millennio. Il motivo per cui ci sentiamo di inserire comunque questa registrazione ad opera del pianista inglese Ian Pace (dedicatario anche di uno degli undici pezzi, ed esecutore della premiere integrale nel 2001) è dovuto al fatto che questa è la prima, storica incisione del ciclo completo. Il tema portante di quest’opera non è tanto la fotografia come evento artistico, quanto la fotografia come oggetto per conservare il passato e come fonte di ricordi, riflessioni e considerazioni completamente soggettive su di esso. Per questo, lungo le oltre cinque ore di The History of Photography in Sound, la scrittura di Finnissy viene meno all’ostentata complicatezza del movimento New Complexity, preferendo una complessità più subliminale che si apre a un lirismo dal sapore tardo-romantico. Tra esplicite citazioni a Bach, Beethoven, Alkan, Berlioz, Busoni, Debussy e Ives, rimuginazioni su temi del folklore americano, elucubrazioni sulla problematicità dell’eredità della musica africana nell’arte occidentale, The History of Photography in Sound rappresenta uno dei più vertiginosi apici della letteratura pianistica dai tempi di Olivier Messiaen. (Emanuele Pavia)

The Haxan Cloak – Excavation (Tri Angle, 2013)
A inizio decennio, sotto il moniker The Haxan Cloak, Bobby Krlic ha scritto alcune delle pagine più profonde e terrificanti della musica sperimentale di questi ultimi anni. Excavation è il suo secondo (e, per ora, ultimo) full-length registrato sotto questo nome, ed è uno dei capolavori dell’elettronica di derivazione post-dubstep che ha imperversato nella prima metà degli anni Dieci. Concettualmente, Krlic riparte dal minimalismo e dalla musica da camera contemporanea, ma trasporta queste influenze in un contesto urbano, immergendole in una trama sonora completamente digitale fatta di melodie a malapena abbozzate nel vuoto cosmico, droni ostili, raggelanti sample di archi e registrazioni di suoni trovati, da cui emergono i profondi bassi pulsanti della musica dub e future garage. Excavation è un’opera sinceramente spaventosa, che richiama l’immaginario spettrale della dark ambient, dei dischi più oscuri del catalogo della Miasmah Records, finanche della musica industriale; ma può essere anche interpretato come uno dei testamenti definitivi di un modo di intendere l’elettronica che, prima di essere soppiantato dall’ascesa di trend quali UK bass e la musica post-club, è stato uno dei fenomeni più importanti nella musica inglese del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

James Holden – The Inheritors (Border Community, 2013)
Certi dischi possiedono una mise en abyme sonora, una sorta di riproposizione frattale del concetto principe di cui si vogliono fare portatori. La sinusoide traballante all’inizio di The Inheritors, secondo disco del producer inglese James Holden, appartiene a questa categoria: uno sviluppo apparentemente tranquillo che aspetta solamente di essere stravolto. Tutto l’album, registrato a partire da esperimenti del DJ con il suo synth modulare, si diverte infatti a sovvertire le aspettative dell’ascoltatore, spaziando tra diverse declinazioni della club music: si ascolti il pulsare in odor di Autechre di Seven Stars e lo si compari al drumming tribale condito di sax angolari su The Caterpillar’s Intervention o alle voci umane parzialmente sabotate dagli staccato di Circle of Fifths. Sembra quasi impossibile che tracce così radicalmente differenti nella propria realizzazione possano condividere nello stesso disco: il talento di Holden invece non sta solo nel riuscire a far convivere realtà diverse nello stesso spazio, ma anche nel saper distorcere la norma e adattarla alla propria visione. Basta ascoltare l’emergere delle bordate elettrostatiche in Renata o nella propriamente titolata Gone Feral per rendersi conto che le idee dell’autore non sono più così indissolubilmente legate alla trance che aveva in larga parte segnato The Idiots Are Winning: quando finalmente i clap sfasati di Blackpool Late Eighties fanno la loro comparsa, il sapore in bocca è quello di un commosso arrivederci più che di un formale ritorno all’ovile. Il successivo The Animal Spirits confermerà che James Holden è una creatura in continuo mutamento: oltre, sempre oltre. (Jacopo Norcini Pala)

Marnero – Il sopravvissuto (Dischi Bervisti / Sanguedischi / Escape From Today / Mother Ship / V4V / To Lose La Track / Fallo Dischi, 2013)
Nel 2013 una cronotempesta ha squarciato il tessuto della musica italiana, lasciando una ferita oscura e pulsante in mulinello brullo che ad oggi non si è ancora rimarginata. Il Sopravvissuto, behemoth hardcore a firma Marnero, è stato senza ombra di dubbio il disco italiano più importante di tutto il decennio e i gravissimi trenta minuti di naufragio circolare non hanno ancora cessato di sembrare trenta secondi. La black pearl di puro nichilismo rotola con una rapidità impressionante da Come se non ci fosse un domani a Zonguldak attirando su di sé tutta la carica di attenzioni, aspettative, suspence con una ritualità del reparto strumentale che affoga tanto nell’esperienza emocore italiana quanto nel metal più sporco o atmosferico: la retorica del viaggio è profondamente filosofica, ma disillusa. Nessun giro d’archi è lasciato al caso, e il tempo scorre violento e calorico – senza perdere mai il mordente, senza dimenticare mai le radici, senza smettere mai di affondare tutti i comparti nella musica abissale e morbosa che dona alla prova un respiro mozzato da diluvio universale, ancora più che da delirio all’xm. Il Sopravvissuto, va da sé, lascia una guernica infinita e costante di riflessioni e masticate, che raramente impegnano pancia e testa in giri a vuoto e sabbiature banali e la portata della storia è totale. Siamo tutti sopravvissuti, ma stanchi morti. Riascoltare i Marnero è solo un modo come un altro per sovrapporre uno a uno quello che ascoltiamo fuori con quella che di base è la soundtrack della nostra vita-morte – e probabilmente è per questo motivo che nell’incubo ci sentiamo sempre a casa. Qui una recensione completa. (Alessandro Corona)

Melt-Banana – Fetch (A-ZEP, 2013)
Certi artisti vanno elogiati per la costanza della loro visione creativa. D’altronde non serve sempre reinventare la ruota se la realizzazione di un’idea è talmente forte da meritare reiterazioni su reiterazioni: senza stare a scomodare mostri sacri dell’arte contemporanea, i Melt-Banana hanno cambiato di ben poco la formula negli oltre venticinque anni di carriera alle loro spalle, e Fetch non fa eccezione, con il solito terrorismo sonico concentrato stavolta in appena poco più di mezz’ora. Il duo si barcamena tra le classiche esplosioni chitarristiche imbevute di feedback, i pattern ritmici scavezzacollo e la voce da cartone animato di Yasuko Onuki dal primo all’ultimo minuto: Fetch si prende una pausa solo durante i due numeri Zero+ e Zero, il primo un intermezzo quasi ambient, il secondo un finale che tradisce la fascinazione di sempre del duo giapponese per il pop di casa sua; nel mezzo, la furia a metà tra grindcore e Sonic Youth di Candy Gun, The Hive, Schemes of the Tail e altre ancora non fa prigionieri. Di tanto in tanto i brani vengono sconquassati da un intervento anarchico dell’elettronica o da un pulviscolo di overdub di chitarra, ma il punk digitale dei Melt-Banana rimane sempre la stessa spericolata avventura, un giro sulle montagne russe che lascia divertiti ed esausti ogni volta che si sale a bordo. (Jacopo Norcini Pala)

Oneohtrix Point Never – R Plus Seven (Warp, 2013)
Daniel Lopatin aveva una Visione. Daniel Lopatin voleva creare la pietra filosofale. Ha cercato incessantemente di darle forma, in una quindicina di lavori partoriti febbrilmente in pochi anni, esperimenti e tentativi affacciati su nuove possibilità. Inventa la vaporwave e la plasma per sempre sul suono del Roland Juno-60; prende il polso al pop ipnagogico e lo trasferisce in forma puramente elettronica. Tappe intermedie di un percorso che ha altrove la sua meta. Settembre 2013, esce R Plus Seven: la formula è completa. Oneohtrix Point Never prende preset MIDI e marchi sonori degli anni Ottanta e riesce a convertirli nel Futuro. Giustapponendoli contro ogni logica, moltiplicandoli e ripetendoli con geniale ottusità, portandoli al limite delle loro possibilità finchè uno squarcio non si apre nella materia sconvolta e nuovi significati vengono creati e resi accessibili nello stesso momento. Brani come Americans e Zebra sono viaggi tra mondi – alcuni dei quali non esistevano ancora. Oggi possiamo guardare a questi dieci brani e soppesare quanto gli impulsi in essi contenuti siano stati determinanti nella generazione di nuovi spazi oggi intensamente popolati: i suoni sintetici taglienti nella musica ambientale, le impennate aeree a metà pezzo alla Still Life, il legame a doppio filo tra musica elettronica ed arti visuali sono tutti elementi pervasivi che qui già apparivano in nuce. Ma più che un suono, R Plus Seven ha creato una matrice espressiva della contemporaneità: una memoria collettiva costretta a riconfigurarsi per stare al passo di un domani inconoscibile. La visione del Futuro è diventata la musica del nostro tempo. (Roberto Perissinotto)

John Luther Adams – Become Ocean (Cantaloupe, 2014)
Una delle critiche più comuni (e infondate) mosse al mondo della musica classica contemporanea è quella di accusare i compositori di non saper “parlare” al proprio pubblico, di non essere urgenti e di rintanarsi nella torre d’avorio dell’intellettualismo. Fortunatamente, non è questo il caso: Become Ocean di John Luther Adams, concepita nel 2013 e presentata solamente un anno più tardi dalla Seattle Symphony Orchestra diretta da Ludovic Morlot, è una composizione che non nasconde nemmeno per un momento le proprie influenze e i propri scopi. Il brano è infatti parte di una trilogia (comprendente anche Become River e Become Desert) sugli effetti del cambiamento climatico: le similitudini tra i vari climax orchestrali che si alternano nel brano e l’innalzarsi delle maree risulterebbero tanto scontati quanto l’ostinarsi a rintracciare nel continuo incedere delle arpe un’eco a La Mer di Debussy. In realtà, il lavoro di Adams pesca a piene mani dalla lezione minimalista americana di Reich e Glass, e manipola sapientemente il materiale sonoro dell’orchestra, producendo una partitura viva e altamente cinematica. Become Ocean è il frutto di una idea essenzialmente semplice e che tuttavia garantisce ripetuti ascolti senza alcuno sforzo, dimostrando ancora una volta che anche la musica colta può essere rilevante nel mondo contemporaneo: si è continuamente rapiti dalle intersezioni degli archi, dei fiati, delle percussioni e dal loro crescendo, come se fossimo lentamente trasportati via dall’incessante movimento dell’acqua. (Jacopo Norcini Pala)

Adult Jazz – Gist Is (Spare Thought, 2014)
Un tratto caratterizzante gli anni Dieci per gli appassionati: le navigazioni su Bandcamp alla ricerca di musica da cui farsi sorprendere. In questo lasso di tempo la piattaforma ha riempito il vuoto generato dal decadimento di MySpace e si è affermata come ottimo spazio di contatto e supporto tra artisti emergenti ed ascoltatori curiosi. Esplorare questo mondo per la prima volta era l’equivalente di addentrarsi in un ecosistema grande come una foresta e amichevole come il parco pubblico sotto casa, pieno di musica che aspettava solo di essere scoperta. C’è ovviamente tanta roba amatoriale e dimenticabile su Bandcamp, ma anche veri e propri “casi” che qui per primi hanno trovato una fanbase affezionata. Gist Is è, oltre che un disco bellissimo, il prototipo del Sacro Graal a cui anelavano quelle ricerche notturne. Un album nato in un contesto piccolo, un gruppo che registra in studio con il feeling della cameretta, una musica così avvicinabile che ci sembra di poterla fare noi, dai, tu porta la chitarra che io penso alla tastiera… e allo stesso tempo un lavoro di egregia fattura, incredibilmente creativo e cervellotico nella quantità di idee e di influenze che si riversano in ogni singolo brano per rifulgere in una resa sorprendente e luminosa. Non c’è un solo pezzo in cui non compaia qualche trovata spiazzante, qualche intervento strumentale che scardini le aspettative; eppure tutto sembra avvenire così, semplicemente. Testimone di un momento in cui il pop aveva ancora una reputazione credibile come puntello per percorsi musicali alternativi, un momento che è recente e sembra lontanissimo, Gist Is vorrebbe solo essere un bel disco e finisce per essere molto di più: un canto del cigno, un’ispirazione, un innamoramento. (Roberto Perissinotto)

Black Rain – Dark Pool (Blackest Ever Black, 2014)
A un certo punto, nel 2010 è partita la Blackest Ever Black, e a un certo punto, nel 2019 ha smesso di cacciare uscite. La label, un bulimico tank di pezzi dark ambient, noise e industrial duri e puri, ha sponsorizzato artisti del calibro dei Raime, di Prurient, Vatican Shadow, Tropic of Cancer e soprattutto – appunto – dei Black Rain. Dark Pool, classe 2014, è un simposio misterico e nero che quaglia rivisitando i grandi epitomi dell’industrial e della darkwave in una chiave sintetica e marginalista, molto meno epocale ma molto più insidiosa. La scarsa densità dell’ambient del disco è mantenuta viva da una struttura particolarmente omogenea e minimale – ma allo stesso tempo tribale. L’horror di un Haxan Cloak o dei Demdike Stare lascia spesso il passo a uno space-thriller decisamente contaminato con i più disparati act EBM, prendendo decisamente le distanze dagli atteggiamenti più Intelligent che poco si confanno a certa musica atmosferica ma mantenendo le proprie radici in un roboticismo piuttosto spinto, anticipando in un certo senso svariate riflessioni transumanistiche, rovesciate ovviamente in uno scuro tappeto di ombre gigeriane più che nell’utopia. La dark ambient di Dark Pool, però, non perde per un attimo il suo afflato più techno e nelle sue brevi pretese rimane estremamente funzionale nel contesto club, proiettando la sua disperazione e il suo gusto tetro sulla comunità in movimento più che sul singolo ascoltatore: la cameretta si è allargata a ferite e fratture ed è diventata cosa di tutti, perché il ricordo di distopia che aleggia nella musica del progetto Black Rain non è personale ma ancestrale e comunitario. Nelle ultime botte infernali e dementi di Who Will Save the Tiger? si chiude il prodotto per eccellenza Blackest Ever Black, e lo sguardo si spegne per qualche minuto: trae conforto dal vivere l’angoscia a mente muta chi nel mondo nuovo è costretto a sputare costantemente pensieri. (Alessandro Corona)

cv313 – Echospace [Detroit] Presents: “Altering Illusions” [Chapter One] (echospace [detroit], 2014)
Rod Modell è probabilmente l’adepto più devoto della religione dub techno nel terzo millennio. Lo ritroviamo ad officiarne i dettami sotto vari pseudonimi che vanno dalle interpretazioni più massimaliste agli studi tenui sulle basse frequenze, ma l’espressione più suggestiva è senz’altro la produzione a nome cv313 insieme a Stephen Hitchell. Qui il suono tipico del genere diventa quasi una forza naturale – una tempesta annunciata che travolge l’udito così come i bassi profondissimi sono inondati da riverberi, echi, effetti e note distanti che lasciano un eco-suono-sistema purificato dal proprio passaggio. Brani dilatati sono necessari per contenere la portata di queste forze, capaci di tramutarsi agilmente nelle brume ambientali più nebulose così come nelle piogge techno più sferzanti. In un suono ampiamente esplorato, questo disco riesce a ricavarsi una dimensione unica. (Roberto Perissinotto)
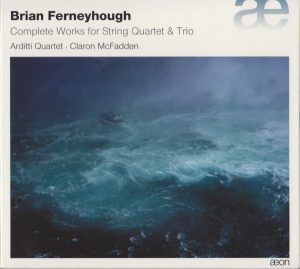
Brian Ferneyhough – Complete Works for String Quartet & Trios (æon, 2014)
Brian Ferneyhough probabilmente non dovrebbe essere in questa lista. In primo luogo perché la maggior parte delle composizioni contenute in questo box edito dall’etichetta francese æon non appartiene nemmeno a questo secolo, figurarsi a questo decennio: le brevissime Sonatas for String Quartet che aprono le danze del primo dei tre CD risalgono addirittura al 1967. In secondo luogo, perché la musica di Ferneyhough non appartiene a questo pianeta. Prendiamo, per l’appunto, le Sonatas di cui sopra: ventiquattro brevi pezzi di durata brevissima e che ribaltano completamente il concetto di “quartetto per archi” per come lo intendiamo. Oramai travalicato l’ardore per il timbro che aveva agitato la prima vulgata post-seconda guerra mondiale, il limite di Ferneyhough, araldo della cosiddetta New Complexity, si sposta sul sovraccarico del flusso di informazione: ecco quindi cascate di note matematicamente calcolate per evocare su spartito quanto di più difficile si possa pensare, tanto meno suonare. Se certi esperimenti (mi viene in mente Failing di Tom Johnson) facevano della propria difficoltà un sornione esercizio paragonabile a un saggio di Borges, qui la componente meta-autoriale è completamente rimossa: rimangono solo i sibili delle corde dei violini e gli impossibili staccati e pizzicati del violoncello e della viola, rivelazioni dell’inspiegabile orrore cosmico che è la mente di Ferneyhough. Il quarto dei sei quartetti, circa venti minuti di durata, include una parte per soprano, ma non bisogna pensare che il lavoro dell’ensemble sia per questo meno sfiancante: se le coordinate strumentali rimangono praticamente invariate, il testo è una ricostruzione frammentaria di un poema a più lingue di Ezra Pound. Eppure, nel mostruoso caos delle composizioni, l’ascoltatore riuscirà sempre a trovare un appiglio a una viscerale, oscena umanità, totalmente aliena in questo contesto. L’ultimo quartetto, l’unico lavoro ad essere composto nel 2010, rivela la forza prodigiosa di questi sparsi, brevissimi istanti: momenti in cui le consonanze sembrano risolversi in un momento di reciproca comprensione, prima di ributtarsi nel brulicante inferno a metà tra magia nera e logica pura. Il quartetto Arditti ha voluto celebrare con questo box il proprio quarantesimo anniversario di attività: e reputiamo che difficilmente avrebbero potuto farci un regalo migliore. (Jacopo Norcini Pala)

Fire! Orchestra – Enter (Rune Grammofon, 2014)
Al primo ascolto, Enter non sembra un disco rivoluzionario. La corte di quasi trenta musicisti scandinavi raggruppata sotto il moniker Fire! Orchestra dall’instancabile Mats Gustafsson, eminenza grigia del jazz europeo degli ultimi decenni, aveva d’altronde già convinto la critica con l’altrettanto valido Exit!, uscito nel 2013. Tuttavia, dall’attacco ipnotico del piano elettrico sul primo dei quattro movimenti che compongono questa lunga suite per big band, ci rendiamo immediatamente conto che le scommesse sono ancora più alte. Enter infatti è stranamente lontano dalla classica concezione e costruzione dei brani jazz per ensemble così larghi: gli echi di Charles Mingus, Sun Ra e Carla Bley sono sempre presenti, come anche la tipica impronta all-out di Gustafsson che marca con le grida del suo sax alcuni dei momenti più appassionati e soulful del disco; ma nel microcosmo pieno di vamp cantabili di Enter convivono anche nebulose di rumorismo per chitarra, allucinati motorik che fanno esplicitamente il verso ai Beatles di Tomorrow Never Knows, collassi vocali al limite del confronto con Diamanda Galás, e decine di altre schegge sonore che si frappongono tra di loro senza una precisa soluzione di continuità. Il lato migliore di Enter è, forse paradossalmente, questa mancanza di coesione: si ha la vivida impressione, mentre si procede verso la uroborica fine del disco, che la Fire! Orchestra si stia soprattutto divertendo a rimescolare caoticamente tutte le lezioni che i propri membri hanno digerito durante la militanza nelle varie scene a cui appartengono. E forse divertirsi è la cosa più importante. (Jacopo Norcini Pala)

Indian – From All Purity (Relapse, 2014)
Delle innumerevoli declinazioni del verbo sludge che gli anni Dieci ci hanno regalato, quella degli Indian di From All Purity è stata con ogni probabilità quella più interessante e particolare – anche solo per il fatto che sono stati tra i pochissimi a capire che c’è vita oltre i downtempo a tempi estenuantemente lenti su quanto sia buona la droga con gli strumenti accordati due toni sotto e i riff rubati a Tony Iommi. From All Purity è invece un disco disperato ed estremo, di base radicato nel suono misantropo dei grandi classici dello sludge metal anni Novanta, ma sabotato da continue deflagrazioni rumoristiche che provengono dal drone metal e dal noise. I veri valori aggiunti sono però le urla straziate e strazianti di Dylan O’Toole, a metà tra Steve Austin e Alan Dubin, e le sinistre aperture melodiche che si fanno spazio nella seconda metà del lavoro, in odor di certo black metal americano (non a caso, il chitarrista Will Lindsay ha lavorato anche con Wolves in the Throne Room e Nachtmystium). Proprio il suono che gli Indian hanno coniato su Rhetoric of No, Clarify e Disambiguation rappresenta una delle maggiori conquiste della musica post-sludge di questi anni, e un indiscutibile punto di riferimento per coloro che hanno provato a seguire la strada del metal più rumoroso e impervio nella seconda metà del decennio. (Emanuele Pavia)

Keir Neuringer – Ceremonies Out of the Air (Atlantis, 2014)
Capace di sorprendere orecchie ormai avvezze ad ogni arguzia della respirazione circolare, Ceremonies Out of the Air è una potentissima affermazione di perizia tecnica e allo stesso tempo una profonda celebrazione musicale in memoria di un caro estinto. In ognuna delle cinque performance registrate Neuringer riesce abilmente a produrre con il suo strumento contesti rituali che come in uno stato di trance conducono l’ascoltatore ad estendere la propria percezione alle più sparse minuzie sonore, individuando i mondi che le abitano. Passando da scorci minimalisti ad impennate liberatorie alla Ayler, il disco riesce davvero a soddisfare la prescrizione della poesia di McCarthy da cui prende il titolo: evocare le forme. (Roberto Perissinotto)

Arturo O’Farrill & The Afro-Latin Jazz Orchestra– The Offense of the Drum (Motéma, 2014)
Il pianista e organista cubano Arturo O’Farrill, classe 1960, è figlio del misconosciuto Chico, che pur è stato un personaggio chiave nella storia del jazz afro-cubano facendo da arrangiatore anche per artisti del calibro di Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Count Basie. A sessant’anni da quelle esperienze, Arturo si è imposto come una delle personalità più importanti del jazz moderno, aggiornando l’idioma del jazz latino sotto la lente della contemporaneità. Composto per un’orchestra di diciotto elementi, con un vasto assortimento di percussioni provenienti da tutto il mondo e ospiti di spessore dai background più disparati come Vijay Iyer e Donald Harrison, questo The Offense of the Drum (che ha pure vinto un Grammy come miglior album Latin jazz) è probabilmente il vertice della sua ricerca in questo senso. The Offense of the Drum è un’acuta riflessione sull’eredità culturale delle musiche messicane, caraibiche, colombiane, brasiliane e ispaniche nel nuovo jazz: gli intricati, ma sempre ballabili, schemi ritmici richiamano contemporaneamente generi come la bomba e il porro e lo swing delle migliori orchestre di Duke Ellington, ma il contrappuntarsi delle linee melodiche della front-line di ottoni tradisce i legami con il nuovo post-bop cerebrale new yorkese. They Came, con DJ Logic e lo spoken word di Christopher “Chilo” Cajigas, scomoda anche l’hip hop e il turntablism. The Offense of the Drum è uno dei lavori più belli e innovativi di tutto il filone afro-cubano del jazz di questo decennio – e trattandosi di uno degli stili che ha prodotto alcuni dei dischi più creativi degli ultimi anni, è piuttosto pacifico concludere che The Offense of the Drum vada ascritto, di conseguenza, agli album più belli e innovativi tout-court del jazz del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

Owen Pallett – In Conflict (Domino / Secret City, 2014)
Il chamber pop ha affrontato strali piuttosto strani nel decennio appena passato, rappresentato da una marea di dischi orribili che hanno scambiato le notti bianche anni Zero di Arcade Fire, Andrew Bird, Sufjan Stevens con una specie di romanzo harmony continuo e imbarazzante: non sto nemmeno ad elencare tutti gli act deludenti un po’ art e un po’ avant che sono emersi negli anni, ma a questo punto dovreste esservi fatti un’idea della quantità di sospetto con la quale la redazione si è avvicinata a In Conflict, secondo disco di peso di Owen Pallett – subito identificato come un pregiudizievole mix di Bon Iver e James Blake all’acqua di complessità. La valutazione, ovviamente, si è rivelata sbagliata. Il disco di Pallett è un florilegio maestoso ma liquido di art pop a trazione orchestrale/elettronica che conserva un’ambizione molto più grande e teatrale di un normale lavoro chamber: lo storytelling di Pallett, all’inizio di difficile digestione, viene immediatamente amato in virtù di un apparato strumentale quasi operistico che segue le digressioni del canadese con una cadenza sapida e sempre originale, dall’uncinetto di archi che abbraccia il discreto lamento di On a Path al richiamo quasi da final fantasy (!) dei fiati di Chorale, che ne innalzano il flow stanco e trascinato, dall’ossessivo warning sintetico e gommoso di The Sky Behind the Flag che lascia uno spazio incontrollato ai momenti di più alto virtuosismo vocale del disco fino al giocoso hook-fatto-brano di Soldiers Rock, che sembra uscito direttamente da una delle idee più leggere dei Battles. Non bastano poche righe per esaurire il lavoro che è stato messo nero su bianco per In Conflict, ma per completezza è necessario citare il ricordo sbiadito della prima impressione che ci ha fatto il lavoro di Pallett e che, in un certo senso, accomuna la reazione a tutte le grandi release che non si presentano smaccatamente innovative e rivoluzionarie. L’ascolto, la metabolizzazione, il dialogo, e infine la santa frase: “Ah, ma allora si può fare, ed esce anche di cristo! Perché gli altri non lo fanno?”. Tuttora non abbiamo ancora la nostra risposta, ci contentiamo, ispirati e affascinati, dal gioco di suoni estemporaneo che saltuariamente arriva in tavola da una voce lontana. In Conflict, in ultima analisi, ne è uno degli esempi più luminosi. (Alessandro Corona)

Perfect Pussy – Say Yes to Love (Shaun Sutkus, 2014)
Quanto cazzo è bella Driver! Questo pezzo di recensione l’ho scritto il giorno prima della recensione che poi finirò il giorno dopo. Eccoci, dicevamo. Qualche anno fa le Perfect Pussy, un gruppo fempunk di Syracuse, ha scosso molte delle porte dell’hardcore e della sfera musicale delle Best New Music usando la politica come grimaldello e grigliando un cattivissimo cumulo di noise rock bello raw e graffiante, nella solita piena di revival anni ’90 che ha caratterizzato il decennio. Le Perfect Pussy non si sono lasciate particolarmente accarezzare dalle classiche suggestioni del riot grrrl più slavato alla Sleater-Kinney per comunicare le loro ragioni, ma, al contrario, si sono imbizzarrite su una calanca quasi noisecore, anche affezionata agli act più puristi e brutali del genere (Melt-Banana su tutti, ma anche i Lightning Bolt, Barkmarket, perfino i Sonic Youth…). La furba vetreria strumentale di Say Yes to Love, nei suoi brensissimi ventitré minuti, si infrange in continuazione con le acute martellate psicotico-istrioniche di Meredith Graves, e la risultante espressiva è un fuzz rumorale che abbraccia con violenza la forma-canzone delle track che di per sé oscilla dall’hardcore punk schietto e arrogante di Bells, Dig o Work all’enfatico balocco di Big Stars e Interference Fits, al limite con l’indie rock dei migliori anni Ottanta. Bestia sonora in una giungla addomesticata, il lavoro delle Perfect Pussy è sfuggevole e antipatico, indigesto alla maggior parte dei sedicenti appassionati di musica ma amorevole e gentile – come sostiene il titolo nel suo sardonismo – per chi ha sempre avuto la voglia di cavalcare a pelo. L’indulgere più silenzioso e grave delle ultime due tracce (Advance Upon the Real e VII), al limite con la ghost track, rivela l’etica più riflessiva di un gruppo che al di là del rauco aveva chiaramente molta più mente di quanta vuole dimostrare. Le ragazze hanno preso strade diverse nel 2016, e non ci è dato sapere cosa sarebbe successo. Per fortuna c’è ancora Driver, che è sempre un sacco bella. (Alessandro Corona)

Pinch & Mumdance– Pinch B2B Mumdance (Tectonic, 2014)
A questo punto la spinta della UK bass sta già cercando nuove forme in cui incanalarsi, dopo l’esplosione di inizio millennio della dubstep da suono underground a fenomeno mainstream. A questo si aggiunge il pungolo del cambio di tendenza verso una musica elettronica “accelerazionista”: PC Music, musica post-umana ed elettronica hi-tech iniziano ad entrare sempre più comunemente nei discorsi. In questa transizione, Pinch e Mumdance realizzano un mix che indica con decisione la via più futuristica per quel suono. Attingendo in maniera preponderante a produzioni proprie e del sodale Logos, trasformano il contesto musicale in una laser room infernale dove i bassi sono allo stesso tempo pesantissimi ed imprendibili. Zero spazio per suggestioni dub, la componente ritmica è asfissiante e stritola ogni pretesa di ordine sotto l’assalto di pattern zigzaganti che non trovano tregua, disgregandosi e riformandosi continuamente in un vuoto scurissimo. Un’esperienza sonora massiva che fotografa il salto definitivo di questo approccio verso la contemporaneità cibernetica, diventando il pilastro sui cui poggerà il florilegio di elettronica frammentata che costellerà la seconda metà del decennio. (Roberto Perissinotto)

Pharmakon – Bestial Burden (Sacred Bones, 2014)
Delle molte artiste donne che nell’ultimo decennio si sono cimentate con una musica terrificante e implacabile, a cavallo tra noise, power electronics e death industrial (qualche nome? Puce Mary, LINGUA IGNOTA e Uboa), Margaret Chardiet (in arte Pharmakon) è stata la prima a conquistarsi l’attenzione della critica e del pubblico midstream con il sorprendente Abandon, nel 2013. Ma è questo Bestial Burden che noi consideriamo essere il suo personale capolavoro: meno sensazionalista, più calibrato, attacca la psiche dell’ascoltatore in maniera più varia rispetto a quanto non facesse il suo predecessore, adottando anche strategie più subdole (e acute) per accumulare tensione oltre alle mere esplosioni di urla e distorsioni – che comunque le varie Intent or Instinct, Body Betrays Itself e Autoimmune non mancano di offrire. Soprattutto, è l’inedita versatilità vocale della Chardiet che permette alla musica di Pharmakon di fare un enorme salto di qualità, grazie alla sua presenza scenica magnetica e luciferina che ricorda Diamanda Galás, Runhild Gammelsæter, e perfino Michael Gira degli Swans. Le allettanti promesse di Bestial Burden sono state, finora, disattese dalle più recenti uscite di Pharmakon, che non si sono rivelate all’altezza dei primi due lavori; ma a conti fatti, già questi album le hanno fatto guadagnare un posto d’onore tra le personalità più importanti della musica estrema americana degli ultimi anni. (Emanuele Pavia)

St. Vincent – St. Vincent (Loma Vista / Republic, 2014)
Annie Clark è sempre stata nell’olimpo dell’art pop dai tempi di Marry Me, il suo debutto su Long Play. St. Vincent, il suo disco più famoso e completo, arriva dopo un importantissimo wave-washing operato a diretto contatto con Byrne sul precedente Love This Giant e consacra la figura glossy e poderosa di una star che come statement si mette da sola in copertina, su un trono di plastica, con il capello perfetto e il satin dress calato direttamente dall’elysium; St. Vincent: e tanto vi basti. L’arroganza del piedistallo simbolico dove si è sempre posta con orgoglio la Clark è replicata ossessivamente nella sua carriera, e il disco è forse il suo tentativo più autocelebrativo e crasso: Rattlesnake, Birth in Reverse, Digital Witness, sono tutti quanti dei singoli massicci e aggressivi, che stratificano canali su canali di sintetizzatori, chitarre, sample nella totale venerazione del ritmo e del riff, sublimati dal secco terriccio punk-funk dei nuovi maestri della divetta (alcuni slide richiamano palesemente gli sbrodolii wave più popolari alla True Stories, mentre altri giretti in clean potrebbero essere usciti da un disco di Kurtis Blow o James Brown). Il vapore che risulta dal processo accalda un botto, e la componente solo-dance si scompone nelle idee più seducenti del disco, che da Prince Johnny, Huey Newton, I Prefer Your Love scompigliano le carte in tavola richiamandosi alla Clark più melliflua e sottile, ma il risultato è un tira e molla devastante che corteggia e mantiene sul pezzo l’ascoltatore attento per tutto il tempo della release, in un gioco delle parti perfettamente ritmato che ostenta la sicurezza della musicista di Dallas e che trova il suo apice nei brani più roboanti (Bring Me Your Loves, Regret). C’è da dire, nonostante le prove un po’ più lente di Masseduction, che il gene alfa di St. Vincent non è mai stato lontanamente molesto, e il suo self-titled non è altro che un vangelo di una divinità minore cacciato con la giusta convinzione sugli scaffali dei suoi seguaci. Nessuno di noi è mai stato davvero un credente dal fervore eleusino, ma a tutti piace giocare di ruolo, e c’è da dire che ogni volta che Annie Clark viene a bussare alla porta non è mai troppo notte per ricominciare la partita. (Alessandro Corona)

Pete Swanson – Life Under the Art Flag (autoprodotto, 2014)
Se il disco di commiato degli Yellow Swans era stato un capolavoro desolazionista, queste due performance dal vivo di Pete Swanson sono un fracassante manifesto isolazionista. Nonostante i contesti danzerecci si tratta di musica profondamente ostica e chiusa in se stessa – e se vi andate a cercare il video dell’esibizione al Boiler Room vedrete anche gli effetti su un pubblico abituato a ben altro. Proprio quella registrazione si apre in una discarica di frequenze decadute e scorie sonore, da cui emerge potente un beat che non si limita a sporcarsi di distorsione secondo gli stilemi industrial techno ma sceglie invece di esplodere in un bombardamento sempre più sfilacciato, lasciando una coltre nera di frastuono illuminata dal synth ottuso ed ipnotico. La performance in terra olandese si spinge ancora oltre, rinunciando completamente alla presenza di un beat strutturato per favorire una palude di puro rumore su cui i raggi cosmici dei sintetizzatori si stagliano ed impazziscono senza ritorno. Tutto filtrato sonicamente come se avvenisse in un’altra dimensione; e a ben guardare, è proprio questo il caso. (Roberto Perissinotto)
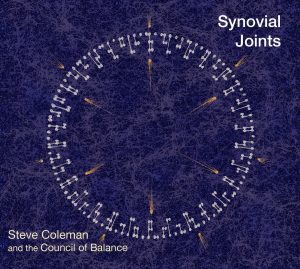
Steve Coleman and the Council of Balance – Synovial Joints (Pi, 2015)
Dopo trent’anni di esperimenti basati sui più disparati sistemi concettuali e musicali, sempre estremamente complessi quando non esoterici, Steve Coleman offre un compendio di tutte le tecniche adottate durante la sua carriera in quello che è probabilmente il suo disco più celebrato di questo decennio. Gli arrangiamenti stratificati realizzati seguendo i dettami della composizione spontanea, le invenzioni melodiche e ritmiche ispirate al movimento delle articolazioni del corpo umano, il sofisticato e cerebrale impianto ritmico delle percussioni, e l’inedito concetto di camouflage orchestration alla base della disposizione spaziale dei suoni, rendono Synovial Joints uno dei dischi più particolari e unici dell’intero catalogo di Coleman. Vi sono contatti espliciti richiami ai grandi capolavori M-base degli anni Novanta, ma anche con le musiche latine, africane, asiatiche, e finanche con l’intimismo della musica da camera contemporanea: non solo un personale vertice nella discografia di Steve Coleman, ma anche un porto indicato per approcciarsi all’opera di uno dei giganti del jazz degli ultimi decenni. (Emanuele Pavia)

Amir ElSaffar – Crisis (Pi, 2015)
Concepita nel 2013 a cavallo tra Egitto e Libano, mentre la situazione nel Medio Oriente precipitava a causa dei disordini, delle ribellioni e delle crisi scoppiate in tutta la regione durante l’inverno arabo, la suite Crisis del trombettista iraqeno-americano Amir ElSaffar è la sua opera finora più urgente e disperata. L’adozione delle forme del maqam iraqeno, di strumenti tradizionali regionali e dei sistemi armonici medio-orientali qui assume un nuovo significato più profondo di partecipazione e condivisione delle lotte intestine in Egitto, Yemen e Iraq, mentre la rocciosità della base ritmica e l’instabilità melodica delle parti dei fiati riflettono l’inquietudine in questi tempi turbolenti per l’intera comunità araba. Crisis non è l’album più innovativo di ElSaffar, ma è quello dalla poetica più singolare e dalla forza più sconvolgente; una cupa testimonianza in prima persona di una tragedia che ancora non accenna a esaurirsi. (Emanuele Pavia)

Toby Fox – UNDERTALE Soundtrack (autoprodotto, 2015)
Sono sempre stato un grande sostenitore della dignità delle soundtrack dei videogame e probabilmente approfondirò l’argomento in un articolo futuro, quando mi degnerò di tornare operativo. Per fortuna Toby Fox, quando ha tirato giù quel gioiellino di UNDERTALE, ha confermato tutte le mie ipotesi, permettendosi di diritto di entrare cum laude nella top 100 del decennio. Il girotondo di theme di Fox non è nemmeno particolarmente virtuoso nella sua composizione primigenia, ma l’accumulo di magia e scintille che macina la soundtrack brano dopo brano è tutto fuorché banale, per non parlare del mero gusto all’orecchio, che rimane sempre soddisfatto e contemporaneamente affamato, in un’esplosione di catchy che per un videogioco con un alto fattore replay è una manna dal cielo. La lunga cavalcata di UNDERTALE e della sua colonna sonora è un carosello bifronte di dolcezza e smugness, con una marea di intuizioni interessantissime calate nella valle del low-bit con una tranquillità impressionante per un compositore alla sua prima prova effettiva: tutti i frammenti sono vergognosamente iconici, con picchi di epica digitale cattivissima ormai entrati nella storia del medium (MEGALOVANIA, Heartache-ASGORE, Spider Dance, Death by Glamour) che gareggiano direttamente con le opere ben temperate di Kondo e Masuda, e vallate di pace molto più analogiche e accoglienti (Home, Undertale, Snowy, It’s Raining Somewhere Else). Alcuni dei gesti di Toby Fox fanno incazzare (Your Best Friend, Dogsong e su tutte la maledettissima One True Love che fa il verso all’Aria di mezzo carattere di Final Fantasy VI) e altri fanno commuovere con i crescendo più junkish possibili immaginabili (Don’t Give Up, His Theme, Hopes and Dreams). Con un rapido wrap-up dell’esperienza è possibile intravedere un piccolo spazio per la soundtrack di UNDERTALE nell’empireo delle colonne sonore per videogiochi, con una fedeltà ineccepibile alla sua storia e una tranquillità nella delivery fuori dal comune. UNDERTALE ai tempi fu una bella sorpresa, oggi non ci guarda con la gravità di un monolite della storia videoludica e musicale, ma ogni tanto torna a trovarci portando le paste nelle nostre playlist, e la cosa ci piace assai, perché nel quotidiano non abbiamo bisogno di un guru cosmico, ma di un vecchio amico. (Alessandro Corona)

Kill the Vultures – Carnelian (Totally Gross National Product, 2015)
Nello stesso anno in cui To Pimp a Butterfly aveva riportato all’attenzione della critica e del pubblico la commistione di musica jazz e hip hop politicamente attivo, i Kill the Vultures – che con tre full-length pubblicati tra il 2005 e il 2009 si erano già imposti tra gli esponenti più importanti del millennio in questa direzione – hanno dato alle stampe uno degli album più arditi in tutta la storia del genere. L’approccio dei Kill the Vultures su Carnelian è quello anarchico, iconoclasta, essenzialmente punk che il loro debutto aveva già fatto assaporare dieci anni prima, ma questa volta alle basi di Anatomy (che passa con naturalezza dal dipingere sinistri soundscape post-industriali come su God’s Jewelry a campionare Rejoicing with the Light di Muhal Richard Abrams su Broke) si aggiunge uno stuolo eccezionale di ospiti che forniscono alla palette sonora del duo il suono reale di sassofoni, trombe, flauti, violini, violoncelli, chitarre, contrabbassi e percussioni. La musica di Carnelian, astratta eppure urgente e spigolosa, sospesa tra avant-jazz angolare e musica contemporanea cinematica, si fonde così perfettamente con il flow di Crescent Moon, le cui rime denunciano un clima politico di iniquità sociali, abusi di potere, criminalità e paura sempre rimanendo calate in un’atmosfera irreale, criptica e fumosa. È uno dei capolavori hip hop di questo decennio che non potete permettervi di perdervi. (Emanuele Pavia)

Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (Top Dawg / AfterBlue Willa – Blue Willmath / Interscope, 2015)
Kendrick Lamar mi sta sui coglioni. In un certo senso non è neanche colpa sua: il mondo lo ha scelto come paladino dell’hip hop conscious e dell’arte afroamericana contemporanea, sperticandosi in lodi e conferendogli ogni premio possibile e immaginabile, compreso un Pulitzer piovuto abbastanza dal niente. Continuamente messo su un piedistallo dalla società, chiunque svilupperebbe un ego di dimensioni notevoli, e Kendrick non è stato neanche troppo fastidioso a riguardo; l’unica cosa che mi disturba è che non credo si meriti tutto questo apprezzamento, per cui queste righe non saranno un’eulogia. Kendrick Lamar ha fatto più di qualche danno alla scena musicale di questo decennio. I musicisti e i produttori di cui si serve (Flying Lotus e Thundercat su tutti) sono promotori di un’estetica musicale insopportabile, un misto tra jazz spirituale becero e funk grassissimo con produzioni iperlaccate, linee strumentali eccessive e tamarre, l’equivalente musicale del food porn tanto caro agli americani. In To Pimp a Butterfly è possibile riconoscere questo approccio negli arrangiamenti di varie tracce (Wesley’s Theory, King Kunta, These Walls), e la sua presenza in quello che è probabilmente l’album più incensato degli ultimi dieci anni sigla ineluttabilmente la glorificazione di ciò che per me è un modo volgare di fare musica. Ho problemi anche in come sono state incorporate le influenze R&B, in come sono stati resi vari hook e ritornelli, nella critica sociale non sempre illuminante. E allora perché To Pimp a Butterfly mi piace? Ho cercato di non farmelo piacere. Al primo ascolto non era neanche una sufficienza; ascoltando e riascoltando ho poi pensato no, il mio giudizio è ingiusto, non è un album a cui negherei il 6 in pagella. Nei mesi a seguire ho riascoltato altre volte, mi sono sorpreso a mettere in heavy rotation King Kunta e The Blacker the Berry, e piano piano tutti quelli che consideravo difetti hanno cominciato a darmi sempre meno fastidio. I danni fatti da Lamar rimangono – almeno secondo i miei gusti musicali – ma alla fine di un percorso durato più di un anno ho dovuto venire a patti con la seguente realizzazione: To Pimp a Butterfly è un disco storico, ed è un disco storico perché la musica al suo interno, nonostante tutte le scelte che ritengo essere sbagliate, è una musica dal peso non indifferente. Ha picchi espressivi potenti, ha grande coerenza interna, ha un’estetica personale, ha un valore artistico tangibile. To Pimp a Butterfly è un grande disco. (David Cappuccini)

Rudresh Mahanthappa – Bird Calls (ACT, 2015)
Rudresh Mahanthappa si è fatto un nome tra gli addetti ai lavori grazie a una lunga serie di dischi visionari che coniugavano il lessico neo-bop con la sensibilità melodica e armonica della musica indiana; eppure, a decennio chiuso, è probabilmente il suo disco più intrinsecamente tradizionalista a rappresentare anche il vertice della sua produzione. Bird Calls è un accorato tributo all’eredità dell’opera di Charlie Parker, e una delle più potenti dimostrazioni della pervasività della sua influenza su qualsiasi musicista jazz moderno – a prescindere da quanto armonicamente o ritmicamente ardite possano essere le sue improvvisazioni. I brani di Bird Calls non sono mere reinterpretazioni di standard, né posticce rivisitazioni post-moderne di qualche capolavoro del bebop: sono invece brani completamente originali che estrapolano il materiale tematico di qualche melodia o assolo di Parker per farvi scaturire infine composizioni di scintillante post-bop contemporaneo. Nonostante l’impostazione essenzialmente classica del quintetto acustico, infatti, le pulsazioni della sezione ritmica dimostrano un’evidente influenza dell’hip hop americano, mentre l’interplay di tromba e sassofono rimastica tanto il Miles Davis anni Sessanta, quanto la nuova avanguardia new yorkese, se non addirittura le stesse radici indiane di Rudresh Mahanthappa: lo stato dell’arte del jazz del XXI secolo è rappresentato anche da dischi come Bird Calls. (Emanuele Pavia)

Mastery – VALIS (The Flenser, 2015)
Mastery è la one-man band di Ephemeral Domignostika, un artista black metal americano attivo dal 2005; nonostante i demo e split pubblicati fin da allora, VALIS è il debutto di questo singolare progetto. Registrato, a dire di Domignostika, in una sola take e per la maggior parte improvvisato, VALIS è infatti un album che sfida a viso aperto i dogmi del black metal: la gargantuesca opener (oltre diciassette minuti!) V.A.L.I.S.V.E.S.S.E.L. infatti inizia con una raffica di blast beat e riff manipolati digitalmente, che si susseguono senza alcuna cognizione di causa in un tritacarne che ripudia ogni tipo di struttura. Nemmeno quando al settimo minuto il ronzio delle elettriche si spegne per lasciare posto a un fraseggio di chitarra acustica (una frenata che ricorda gli Ulver di Bergttat) possiamo dirci al sicuro: la batteria continua infatti a procedere, sottovoce, in un pattern crudele e senza tregua che poi riesplode con ancora più ferocia e che si trascina fino alla fine del pezzo. I due brevi intermezzi simil-ambient di A.S.H.V.E.S.S.E.L. e I.L.K.S.E.E.K.E.R. sono le fette di pane ai bordi dell’incomprensibile brutalità di L.O.R.E.S.E.E.K.E.R., che vive di assalti senza tregua della chitarra, ora trasfigurata in una macchina da guerra dai toni alti e irriconoscibili, la batteria implacabile e la delivery secca di Domignostika. Quando finalmente si affronta l’ultima tempesta di S.T.A.R.S.E.E.K.E.R., si è oramai completamente affascinati dalla costruzione schizoide di bordate al rumore bianco a metà tra il grind dei Discordance Axis e le avanguardie di Krallice e Orthrelm: non si può fare a meno di chiedersi in che direzione possa evolversi il black metal dopo imprese del genere. (Jacopo Norcini Pala)

Dafnis Prieto Sextet – Triangles and Circles (Dafnison, 2015)
Dafnis Prieto è un altro di quei musicisti che, in questi anni, ha maggiormente contribuito allo stato di perfetta salute del jazz di derivazione latina e afro-cubana. Ciò che distingue però la sua musica da quella di altri campioni del genere come Arturo O’Farrill è che, anziché aggiornare il suono del classico jazz latino alle asperità armoniche del linguaggio jazz moderno, procede in direzione opposta. Prieto sembra partire infatti dall’M-base di Steve Coleman e dalle arzigogolate composizioni di Henry Threadgill (entrambi musicisti con cui Prieto ha peraltro suonato in passato) per poi iniettarvi solo in un secondo tempo i ritmi contagiosi della musica afro-cubana. Triangles and Circles, registrato con un sestetto composto di due sassofoni, una tromba, un pianoforte, un contrabbasso e batteria, è un perfetto manifesto di questo modus operandi: brani come Back and Forth, Blah Blah Blah o Two for One trovano un incredibile compromesso tra l’orecchiabilità delle melodie delle musiche popolari dell’America latina e delle nuove tendenze dell’avant-jazz della East Coast. Merito non solo dell’interplay della front-line di ottoni e dell’eccellente comping del pianoforte di Manuel Valera (che spesso si inventa gli hook melodici più efficaci del disco), ma soprattutto del particolarissimo stile batteristico di Dafnis Prieto, che trasfigura con naturalezza poliritmi composti e altamente cerebrali in groove ballabili. Non solo uno dei musicisti più interessanti dello scorso decennio, ma anche uno di quelli da tenere assolutamente d’occhio in quello che sta per cominciare. (Emanuele Pavia)

Ève Risser – Des pas sur la neige (Clean Feed, 2015)
Ho identificato, in altri tempi, il picco espressivo della musica del 2015 in una spettrale e gelida uscita avant-garde, che con tre brani di piano preparato è riuscita a spazzare via tutta la concorrenza senza nemmeno avere la necessità di guardarla in faccia. Nonostante titolo e cover richiamino a uno scenario pacifico (che in molti hanno arrogato ai tempi dell’uscita della release) Des pas sur la neige ha evoluto prima di tutto come uno studio, uno studio sul timbro, sulle potenzialità di un pianoforte preparato, sulla percussività dei tasti, sulla dissonanza e sull’atonalità. Non c’è calma nei silenzi tutt’altro che teneri che venano il disco, e le mani di Ève Risser contemplano Das Unheimliche più che La Ville, il nero di seppia più che il bianco di zucchero. In che modo? Con un enorme e ininterrotto sviscerar di strumento, un disperato tentativo di strappare al piano delle potenzialità che vanno oltre, delle urla che trascendano gli ottantotto tasti. L’attacco di Des pas sur la neige è più ligetiano che debussyano, mentre le ondate di suoni che si abbattono dietro al lungo e lineare inciampo dei tasti potrebbero essere usciti da un lavoro di Horațiu Rădulescu. Percussivo fino allo stremo, complesso e inquietante, il lavoro del piano preparato della Risser trascende nei suoi silenzi e nella sua varietà la lezione di John Cage, abbandonando spesso i territori perigliosi della musica d’avanguardia per avvicinarsi ai movimenti più viscerali della free improv e -perché no- della dark ambient. In effetti, sebbene la cifra tecnica di Des pas sur la neige vada certamente trovata nei grandi pianisti del novecento, le sue coordinate stilistiche si ripresentano nel 2015 vicine a dei sommovimenti della musica che rendono il disco meno alieno e più vicino alla nostra sensibilità. Scendendo con cautela dal piedistallo dell’improvvisazione libera (che sappiamo essere spesso una posizione privilegiata giustificante di ogni genere di azione musicale), un brano come Des pas sur la neige conserva una jazzyness intrinseca e un legame genetico con il free (sto pensando all’Anthony Davis di Lady of the Mirrors, ad esempio) che è raro trovare in molti dischi odierni. D’altro canto, a far d’ancella alla complessità generale che fa da motore all’album c’è anche un diffuso senso di timore e inquietudine che non è difficile trovare nelle ultime sensazioni dark (i soliti nomi: The Haxan Cloak, Demdike Stare, andando più indietro Peter Frohmader…). Ai tempi rimanemmo allucinati in un’epifania di lusso: nei territori carnivori della musica concreta trovammo il discendente ipotetico di tutti i soundscape più malefici e turbati del secolo scorso; Ève Risser ha squarciato un quadro incollato fuori da ogni marea del tempo, nell’Altrove, unico vero luogo delle epoche che in questo decennio così disperso ha conservato – sottovuoto, cinereo, volatile – quello che ci permettiamo ancora di osservare come Geist, spirito. (Alessandro Corona)

Christian Scott – Stretch Music (Ropeadope, 2015)
Sarebbe molto facile confrontare Christian Scott e il suo Stretch Music con la ricerca sonora intrapresa da Miles Davis alla metà degli anni Sessanta. I due condividono infatti lo strumento, la tromba (sebbene Scott suoni anche il flicorno), l’impostazione nel modo di suonare (melodie e silenzi invece che infinite rincorse di note) e un’attitudine esageratamente larger-than-life. E sebbene il confronto sia accettato dallo stesso Scott (immaginiamo anche con una punta di orgoglio), come confermano le linee andaluse di Twin, la corsa a perdifiato di West of the West che odora di Bitches Brew e il titolo sornione di Of a New Cool, Stretch Music propone in realtà molto di più di un noioso passatismo: lo dimostra la voglia di innovare le strutture alla base del genere. Ecco quindi che si propongono scenari sonori cinematici ed eterei, lontani parenti di una trap ariosa di cui Scott abuserà all’inverosimile nei successivi tre dischi, coadiuvati da una strumentazione che rimette in discussione l’equilibrio tra ritmo e armonia: i due percussionisti si prendono il ruolo al centro della scena a più riprese, e il resto dell’ensemble, tra cui spiccano su tutti i contributi della flautista Elena Pinderhughes, può adagiarsi a proprio piacimento sullo sfondo per tessere un tappeto sonoro intrigantemente moderno e urbano dove i solisti sono liberi di alternarsi, senza mai strafare. Stretch Music è, in definitiva, una utilissima chiave di lettura del jazz mainstream di questo decennio, riuscendo a limitare al minimo le sue inerenti ampollosità. (Jacopo Norcini Pala)

Julia Wolfe – Anthracite Fields (Cantaloupe, 2015)
Nell’oratorio per coro ed ensemble da camera che le ha fatto conquistare anche il premio Pulitzer nel 2015, Julia Wolfe esplora in maniera innovativa la storia e la vita di coloro che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, vissero e lavorarono nelle miniere di carbone della Pennsylvania. Il libretto si basa su una raccolta capillare di fonti di prima mano (interviste, racconti, storie orali) ottenute dagli stessi protagonisti di quell’epoca: nell’arco dei primi quattro movimenti di Anthracite Fields si muovono toccanti tributi alle vittime dell’attività mineraria, ai breaker boy, a chi (come John L. Lewis) combatté per condizioni di lavoro più umane per i minatori, alle famiglie dei lavoratori. Infine, Appliances riporta brutalmente alla realtà e all’ipocrisia della società americana tramite le stesse parole che, tempo fa, pubblicizzavano dei treni che utilizzavano il carbone come primaria fonte di energia, facendo passare il sottotesto che le tragedie dei lavoratori fossero un male necessario nel nome del progresso tecnologico. Anthracite Fields è un’opera intensa e straziante: facendo collidere le forme della musica classica contemporanea di estrazione (post-)minimalista e totalista, le melodie del folk americano e l’irruenza ritmica e timbrica di certo rock new yorkese, la Wolfe lancia un’aspra condanna al sistema che ha permesso lo sfruttamento di tanti minatori, nel frattempo celebrandone dolcemente la vita e, soprattutto, la dignità. Senza dubbio, uno dei più toccanti aggiornamenti possibili della musica corale al nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

Hans Abrahamsen – Let Me Tell You (Winter & Winter, 2016)
Let Me Tell You è un ciclo di sette canzoni del danese Hans Abrahmsen, composto nel 2013 e basato sulla poesia eponima del critico musicale e saggista Paul Griffiths, dove si narrava in prima persona la triste vicenda di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare riutilizzando solo le circa cinquecento parole che il personaggio pronuncia nella tragedia. È una di quelle opere che si rivelano radicali proprio per via della elementarità degli elementi di cui si avvale: il testo, per forza di cose, è molto semplice, e anche l’accompagnamento orchestrale suona discreto e delicato, come nelle pagine più emotivamente dense dell’ultimo Mahler. Eppure, l’armonia appare completamente infranta: alcuni strumenti sono accordati secondo il temperamento equabile, altri sfruttano cambi di accordatura e armonici naturali, mentre le progressioni degli accordi sembrano rimanere sospese e non risolversi mai secondo i dettami della teoria tonale occidentale. Let Me Tell You vive così sospesa in una dimensione letargica, che dipinge scenari invernali e che fanno da correlativo oggettivo dell’inverno psicologico di Ofelia (qui interpretata meravigliosamente dalla voce eterea e fragile del soprano Barbara Hannigan, committente nonché dedicataria dell’intero ciclo). Dopo pochi anni dalla sua composizione, Let Me Tell You va già annoverata tra i massimi aggiornamenti della musica colta vocale al XXI secolo, e di conseguenza questa registrazione è una delle più importanti nell’ambito di tutto questo decennio. (Emanuele Pavia)

Alfio Antico – Antico (Origine, 2016)
Primitivismo: a quali regioni del mondo vi fa pensare? L’Africa profonda, gli Stati Uniti rurali…con buona probabilità non la Sicilia. E invece c’è una Sicilia musicale potentemente primitiva, che il percussionista Alfio Antico celebra in questo disco vestendo le panni sia del sacerdote che del cantastorie. Sfruttando le inflessioni di un dialetto che è allo stesso tempo scivoloso e crudo e scandendolo in maniera claustrofobica con le vibrazioni delle pelli, l’artista mastica brani che risultano brulli e coriacei come le Madonie bruciate dal sole. Altrove non disdegna di ricorrere a cortocircuiti con strumentazioni contemporanee per aumentare l’efficacia dei pezzi, come l’intervento dell’elettronica a sporcare Venditori Ambulanti donandole connotati sludge o lo stravolgimento di Storii di Pisci che finisce per suonare come un brano tribal techno. Ma le radici sono nella terra, ed ecco che allora c’è nuovamente spazio per la tradizione in momenti sinceramente commoventi come il folk lirico delle luminose Pirchì e La Rosa. Abbracciate l’Antico. (Roberto Perissinotto)
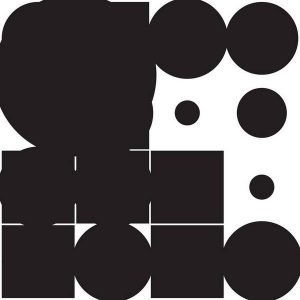
Autechre – elseq (Warp, 2016)
In questa epoca la nostra quotidianità si basa sull’azione di algoritmi di cui non sappiamo decifrare puntualmente il processo operativo. La musica degli Autechre si è evoluta (e convoluta) in senso simile, diventando ad ogni passaggio qualcosa di sensibilmente più complesso e stratificato dell’incarnazione precedente ma di volta in volta oscurando le chiavi di lettura e facendosi meno raggiungibile. Possiamo risalire alla strumentazione con cui è realizzata, certo; ma all’atto dell’ascolto la mente umana rimane sbarrata fuori dalla comprensione e si limita ad essere investita dagli stimoli che questa macchina sputa fuori dopo aver masticato suoni e dati. elseq è il punto in cui il suono si è già fatto circuito a un passo dall’autocoscienza, ma mantiene connessioni con ambiti a noi digeribili (techno, glitch, noise) permettendoci di assistere a una delle più grandi sperimentazioni sul ritmo di questo decennio. Vedremo nei prossimi anni se e come le profezie qui contenute si avvereranno. (Roberto Perissinotto)

Danny Brown – Atrocity Exhibition (Warp, 2016)
Danny Brown si è creato un posto all’interno del panorama hardcore hip hop dei 2010s come il demonietto dalla voce squillante che rappa di droga e depravazione; già dai tempi di XXX, pubblicato nel 2011, gli ascoltatori più svegli avevano però capito che dietro questo personaggio – un semplice twist sulla figura del rapper costantemente sbronzo e pieno di fica – si celava un artista poliedrico capace di incorporare le influenze più disparate all’interno della propria estetica. E se Old è stato un disco sottotono che ai tempi fece dubitare anche chi scrive, Atrocity Exhibition ha marcato un’innegabile esplosione creativa in cui le capacità di Danny Brown sono prepotentemente germogliate. A partire dal titolo (sia che si riferisca al libro di Ballard sia al pezzo dei Joy Division) l’album sembra già voler comunicare la linea d’onda sulla quale si svilupperà: le tematiche rimarranno magari costanti, ma acquisiranno un significato ben più profondo e saranno impresse su un tessuto sonoro impegnativo e particolare, per niente disposto a piegarsi incorporando elementi modaioli in arrangiamenti e produzione. Tale intento è confermato dalla scelta dei campionamenti, che contengono tra gli altri Nick Mason (Ain’t It Funny), Delia Derbishire (When It Rain), gli Embryo e prevedibilmente i Joy Division (Golddust); suoni tratti da un pool così disparato di approcci e momenti storici non solo contribuisce ad ampliare la portata musicale dei pezzi, ma li arricchisce anche di significato, chiarendo espressamente a chi ascolta che è in atto un’opera di distorsione sulle tematiche usuali della musica hip hop e sui cavalli di battaglia dello stesso Brown. Questo processo è portato avanti senza intaccare minimamente il tiro dei pezzi, senza inserire tempi morti, senza diluire o abbassare in alcun modo l’energia di beat e delivery. La depravazione in cui il rapper si è immerso per anni lo ha segnato profondamente, facendolo maturare invece di annichilirlo, e Atrocity Exhibition ha il sapore di una perentoria dichiarazione: Danny Brown è un artista completo, degno di essere annoverato tra i maestri dell’hip hop sperimentale. (David Cappuccini)

Ehnahre – Douve (Kathexis, 2016)
Nonostante gli Ehnahre di Ryan McGuire provengano direttamente da una costola dei Kayo Dot (uno dei nomi più – ingiustamente – celebrati nell’ambito del metal ‘pensante’), non sono mai riusciti a divenire qualcosa di più di una band underground di prestigio. E anche se la fama che meriterebbero è ben superiore a quella effettiva, la situazione non è poi così sorprendente o inconcepibile, vista l’indiscutibile impenetrabilità della loro musica, fin dagli esordi radicata in una forma di death doom metal d’avanguardia che però rimasticava l’improvvisazione libera e la musica da camera. Douve ha portato questo approccio alle estreme conseguenze, sviscerando nei suoi oltre ottanta minuti di durata un suono indecifrabile e radicalmente nuovo in cui il metal sembra divenire uno dei tanti elementi dell’insieme, e non più il punto di partenza della musica degli Ehnahre: il death metal dissonante dei Portal e le cadenze apocalittiche dei Neurosis convivono con gli esperimenti vocali di Nono, il serialismo, la musica elettroacustica, forme di improvvisazione non idiomatica. Douve è un disco estenuante e ben lontano dall’essere di facile ascolto, viste l’estrema complessità della proposta e l’oscura atmosfera da incubo che emanano i brani; ma, allo stesso tempo, è l’indiscutibile apice della (notevole) carriera degli Ehnahre nonché, soprattutto, uno degli album necessari per capire quale può essere una direzione particolarmente creativa e coraggiosa che la musica metal può intraprendere nel prossimo decennio. (Emanuele Pavia)

Paul Jebanasam – Continuum (Subtext, 2016)
Come nel Cern di Ginevra si accelerano le particelle, in questo disco si accelerano droni. Jebanasam non rinuncia alle strutture ieratiche della sua musica, piuttosto le porta alle estreme conseguenze con manipolazioni estreme nella velocità e nelle frequenze, caricando il suono di masse salmodianti e poi lanciandole a perdifiato per farle decollare un momento prima del collasso. Un processo che gli permette di mantenere intatta tutta la spiritualità della propria proposta aggiungendovi l’estasi della frenesia contemporanea, arrivando a raggiungere inaspettate vette emozionali. (Roberto Perissinotto)

Steve Lehman – Sélébéyone (Pi, 2016)
Probabilmente l’album jazz rap più radicale e innovativo del decennio, Sélébéyone rappresenta l’esperimento più coraggioso e visionario dell’intera carriera di Steve Lehman, nel tentativo di coniare una sintesi tra post-bop angolare, lo spirito urbano dell’hip hop, e la musica elettronica d’avanguardia.
Composto per quintetto jazz con l’aggiunta di due rapper, Sélébéyone propone una musica sinceramente globalista e inclusiva, in cui artisti dalle provenienze e formazioni più disparate si incontrano e costruiscono insieme la loro opera lavorando a partire dai punti in comune gli uni con gli altri (come la fede sufista, o la conoscenza della lingua francese). Il prodotto finale è un disco multietnico conteso tra il Senegal della lingua wolof, la New York del jazz M-base, la Francia della musica spettralista, tra musica bianca e musica nera. In un mondo come quello attuale, in cui l’inclusione di altre culture e l’accettazione del diverso sono problematiche ancora aperte per una fetta troppo vasta della popolazione, quello di Sélébéyone è un atto radicale non solo dal punto di vista musicale ma anche da quello politico. E, pertanto, va annoverato a pieno titolo tra i lavori fondamentali degli anni Dieci. (Emanuele Pavia)

Kiran Leonard – Grapefruit (Moshi Moshi, 2016)
Kiran Leonard era poco più che ventenne all’uscita di Grapefruit. Il giovane talento di Manchester era anche un nome come tanti altri, con diversi dischi all’attivo, discreti ma bellamente snobbati dai più. Grapefruit, invece, ci ha fatto alzare le orecchie: se la breve ballata iniziale di Secret Police metteva sul piatto una performance vocale a metà tra Jeff Buckley e Thom Yorke, con archi e pianoforte, certamente non lasciava prevedere cosa ne sarebbe stato dei successivi 50 minuti di musica contenuti nel disco. Pink Fruit infatti si apre con un fraseggio angolare di chitarra, si nasconde dietro a clarinetti, si lascia andare a deflagrazioni degne di Michael Gira e soci e sottofondi rumoristici, mentre la voce di Leonard si contorce tra toni rasposi e mugugnii spirituali… Quando si torna sulla terra, ci si rende conto che la maggior parte del disco è ancora davanti a noi. Ondor Gondor, prima di dissolversi in un delirio di nastri, chitarre acustiche e l’ennesima scarica math rock, tradisce una influenza del midwest emo d’oltreoceano che si ripresenta anche su Don’t Make Friends With Good People e Exeter Services. Il folk tranquillo di Half-Ruined Already serve solo come antipasto per l’altra vera perla del disco, Fireplace: qui Leonard, ora supportato di nuovo dal pianoforte, si lascia andare a un’introduzione dal sapore d’inno, prima che l’intero brano sparisca dentro una catastrofe free di percussioni, ottoni e chitarre, per poi spegnersi definitivamente nelle braci della combo piano e voce, ora supportati da un intervento femminile, che l’avevano iniziato. Nonostante gli sforzi successivi non abbiano convinto, la forza di Grapefruit è tale da lasciarci comunque sperare in un degno seguito da questo giovanissimo prodigio del mondo alternative inglese. (Jacopo Norcini Pala)

Will Long – Long Trax (Comatonse, 2016)
Cosa vi serve per rappresentare una nuvola? Basta il disegno di una linea curva. E così a Will Long bastano una drum machine, un synth e un pugno di sample vocali per rappresentare la deep house: una forma pura, perfettamente riconoscibile anche quando spogliata di tutti gli orpelli di una club music mercificata. Nuovi strumenti, nuovi effetti, nuove tendenze non sono necessariamente simbolo di sviluppo: “we’re not making progress”. Tutto quello che serve è lì, in quel nucleo catartico che ha reso il dancefloor un balsamo per generazioni di emarginati riuniti in comunità a ritmo di beat. Di fronte a tanta efficace semplicità gli interventi usciti dalle sempre ispirate mani di DJ Sprinkles, pur minimali, suonano come fasti meravigliosi. Rallentare rispetto alla frenesia imperante e riflettere sul percorso per apprezzare ciò che aggiunge davvero valore: ecco la proposta radicale di questo disco. (Roberto Perissinotto)

Prince of Denmark – 8 (Forum, 2016)
Otto, come il numero dei dodici pollici che compongono questo lavoro. Ma quello stampato sul cofanetto, a ben guardare, è il simbolo dell’infinito. “You will never have everything”, le uniche parole con cui la Giegling ha presentato questa uscita. Si sa che alcune delle tracce qui presenti hanno più versioni, non si sa quante o quali, si sa che le combinazioni non sono mai uguali e che ogni copia fisica è diversa. Non si sa nulla invece dell’artista conosciuto come Prince of Denmark (o Traumprinz, o DJ Metatron, o altri ancora), se non che è l’entità più misteriosa di questo decennio in ambito elettronico e che suscita una riverenza pari alla segretezza. La sua produzione è nota per la particolarissima trasposizione carica di nostalgia delle coloriture emozionali mutuate dalla trance; ma in questa che è la sua opera definitiva le emozioni scoloriscono di fronte alla contemplazione di un’eternità, lasciando spazio ad una techno imperturbabile che è battito costante, pulsazione cosmica di fondo. Musica ripetitiva tanto quanto l’universo è vuoto: vero, ma non del tutto, e tratto costituente della propria bellezza. Sfiorare di polveri, baluginii lontani, nebulose indifferenti e poi, nel nulla, squarci lenti e dolorosi; una costante tensione verso la pace, verso la luce. C’è un sole anche qui, in questa profondità immensa, i suoi raggi sciolgono il buio e liberano un silenzio che sa di apoteosi. Tre ore di infinito a misura di uomo. (Roberto Perissinotto)

Psychic Temple – Plays Music for Airports (Joyful Noise, 2016)
Gli Psychic Temple, super band jazz ubicata a Long Beach, hanno trovato, nell’aprile del 2016, una via privilegiata per scivolare alle altezze di questa top 100 con una delle operazioni più semplici, ma belle, che abbiano solcato gli oceani della decade. Con premura, calore, affetto, una rivisitazione per band di Music for Airports che con un gloss più analogico e jazzy si srotola in un tappeto di perle gentile e rifratto. La simbologia ambient a installazione recuperata da Eno torna quasi quarant’anni dopo la sua incisione con un’eco di fioriture quasi-post-rock e di sussurri fusion che si sfilacciano senza paura di rovinare l’interplay in una piana di pura bellezza minimale e religiosa: nonostante alcuni degli strumenti richiamino i temi dell’originale più a lungo e con più insistenza, il rito dei Psychic Temple è profondamente comunitario e comunista, il brodo sonoro in cui galleggiano gli sprazzi di chitarra, di tromba, di hammond è accogliente come un grembo materno, la spazialità del disco annulla i silenzi ambientali e si fregia di tanti piccoli lick che innalzano i livelli di astrazione di Music for Airports in un mondo totalmente nuovo, estrospettivo – che è una parola che non esiste. Plays ha un valore melodico ai massimi storici della free improvisation, forte di un blueprint alla struttura che già di per sé ci ha donato una delle nenie più riconoscibili della storia – l’operazione del primo brano, lontana dalle improvvisazioni più audaci o cerebrali del grande free jazz, ha più che altro la dolcezza sopita di scuola Moonchild. La seconda facciata è un’impresa meno telegrafica e più sarcastica, e torna in un battito fusion particolarmente ispirato e, nei suoi punti più alti, addirittura Hasselliano. La linearità dell’improv di Music for bus stops esplode verso il suo finale in una crisi percussiva jazz-funk a frombola, grazie a un prechos brutale che infine ritorna sull’armonia rustica del suo theme, topo di campagna che combatte senza troppo successo con il suo cugino stradaiolo. Gli Psychic Temple hanno lasciato la storiografia del decennio completamente immutata nel loro tributo all’ambient, e di questo siamo addolorati. La speranza è che una tale sensazione aurorale arrivi a quante più persone possibili anche grazie a noi – è uno dei modi privilegiati per rendere più fine il prossimo giro di boa, che ci rende sì curiosi, ma che sicuramente ci lascerà anche feriti e incazzati. Sol, La, Fa#, Mi, Re, Re. (Alessandro Corona)
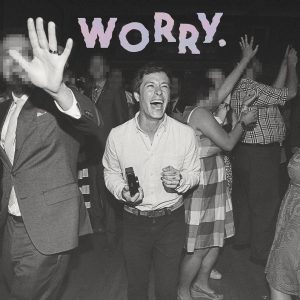
Jeff Rosenstock – WORRY. (SideOneDummy, 2016)
Quando i tempi in cui mi spaccavo coi Green Day o mettevo in rotazione continua Superman dei Goldfinger nella OST di Tony Hawk Pro Skater si accingevano alla fine, in me cresceva la triste consapevolezza che il pop punk avrebbe cominciato ad assumere un ruolo sempre più marginale nella mia vita, fino a sparire completamente. Ciò si è rivelato vero fino a quando Jeff Rosenstock – prima conosciuto come frontman dei Bomb the Music Industry! e con già un altro album solista (We Cool?) ben recensito in saccoccia – non decide di pubblicare WORRY., che si rivela essere piuttosto a sorpresa il mio disco più ascoltato del 2017. Il perché è molto semplice: è l’unica coniugazione possibile del pop punk ancora capace di colpirmi emotivamente come un autotreno. WORRY. è un disco che parla del sentirsi un ragazzino nel corpo di un adulto, che in quanto adulto comincia ad avere doveri e responsabilità che non comprende né vuole sobbarcarsi; parla di crescita, amore e trauma, di rivincite e sconfitte, della gloria nel trionfare o perdere le piccole battaglie di cui importa soltanto a te, ed è pervaso dalla nostalgia dolcissima che ti assale quando pensi a tutta la strada fatta fin’ora, mai più ripercorribile. Sotto questo aspetto, nonostante tutte le pecche tipiche di un prodotto musicale dalla fattura non proprio eccelsa, abbiamo a che fare con un disco che ha pochi eguali nel suo genere, in grado di colpire e connettere un sacco di punti presenti nell’animo di quasi ogni persona della nostra generazione. WORRY. è un lavoro genuino, forse di poche pretese ma da non sottovalutare in quanto capace di confortare quando si è tristi, di accompagnare quando si è persi nei propri pensieri, di dare la carica quando si è allegri. Il pop punk ce l’ha fatta ancora una volta. (David Cappuccini)

Esperanza Spalding – Emily’s D+Evolution (Concord, 2016)
Non ho mai capito che cosa sia successo a Esperanza Spalding. La contrabbassista di Portland ha affrontato dai primi anni Dieci una Kehre mastodontica che è giustificabile sì e no con un rapimento alieno e una sostituzione totale materica cellulare genetica di tutti gli atomi del corpo compresi i piedi. La pelle rinsecchita della jazzista da camera soul-samba lasciva e pigra si stava già increspando ai tempi di Radio Music Society (niente di speciale), ma non avevo mai visto uno strip così rapido né in rettili né in rettiliani come quello che è stato brillantemente apposto all’inizio di Emily’s D+ Evolution, uno dei dischi più strani e affascinanti del decennio, che ha il suo anthem nell’intro caustica e affannata di Good Lava: See this pretty girl? Watch this pretty girl floooOOOOOooooOoOoooooOOW!. La Spalding brulica tutte le sue idee in un bibitone ribelle e insostenibile che non ha nessun rispetto per la sanità mentale dell’ascoltatore (brava, non ci meritiamo un cazzo) e che appicca fuochi che spesse volte divampano nelle figure più spinte della fusion, del post-bop e persino dell’avant-prog d’essai. Nonostante la machine gun di poliritmi e blend allucinanti chitarristico-vocali picchi forte senza veri momenti più cauti e morbidi, la virtù più inconcepibile della Spalding concede all’Evolution di riverberare di una patina di lusso e lucidità, con un continuo saliscendi nel canto che riesce con uno studio intensissimo a sfumare tutto il reparto compositivo in una più normale – si fa per dire – rapsodia urbana di pagliette e lustrini. Se Janelle Monáe ha ristabilito la dominazione totale sull’art pop a motore femminile e Annie Clark ha ricapitolato la narrazione in un contesto bianchissimo e sterilizzato, la Spalding, anche forte del suo background jazz, è rinata come una poderosa outsider, fuori dai regolamenti del pianeta – appunto, tornata traumatizzata e soprattutto traumatica da un brutto rapimento con sondino e tutto. La più grande conquista di Emily, comunque, rimane quella di marcare la distanza irrecuperabile tra gli starmen e le starwomen – e di questo lavoro gliene dobbiamo fare atto. I primi tendono a raccontare i loro viaggi cosmici alla maniera degli umani, le seconde non si preoccupano di risultare comprensibili: la sci-fi è qui ed ora, i piedi di Esperanza sono per terra, ma quando Emily parla si materializzano nell’etere simboli che fanno venire il mal di testa. Si è evoluta lei, mica noi. (Alessandro Corona)
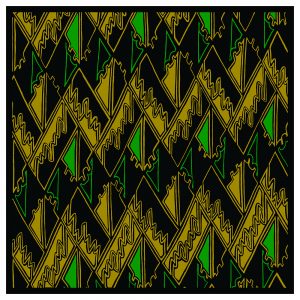
Joshua Abrams & Natural Information Society – Simultonality (Eremite, 2017)
Se con il precedente Magnetoception Joshua Abrams si era già fatto apprezzare per la capacità di costruire strutture fluide in cui suggestioni strumentali percolavano tra uno strato sonoro e l’altro, con Simultonality spariglia ulteriormente le carte. La sua musica viene innestata su una sezione ritmica di stampo kraut e sottoposta ad una abluzione acida che ne amplifica le sfumature, ora psichedeliche ora liriche; i contributi dei vari strumentisti si fondono armoniosamente a creare flussi luminosi dai dettagli minimalisti. Non è l’impianto avant-jazz ad arricchirsi, bensì viene usato esso stesso come grimaldello compositivo per raggiungere nuove combinazioni, risultando in uno dei dischi sonicamente più intriganti degli ultimi anni. (Roberto Perissinotto)

Ambrose Akinmusire – A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard (Blue Note, 2017)
Ambrose Akinmusire continua la grande tradizione del Village Vanguard con questa esibizione dal vivo che presenta pezzi originali in un classico quartetto tromba-piano-basso-batteria. Akinmusire qui si trova in pieno stato di grazia: dosando con sapienza le note del suo strumento si erge come abile demiurgo di ogni brano, infondendo verve a passaggi radiosi in cui si allaccia alla sezione ritmica oppure dilatando l’atmosfera per concedersi profonde meditazioni spirituali. Sono proprio questi i momenti migliori, in cui l’ispirazione del quartetto si erge libera di seguire i propri umori e di trascinare con sé chi rimane rapito all’ascolto. Aggiungete a ciò un’esecuzione perfetta e una pulizia sonora commovente e avrete un moderno monumento jazz. (Roberto Perissinotto)

Benjamin Clementine – I Tell a Fly (Virgin, 2017)
Se l’intrigante debut At Least for Now aveva rivelato al mondo il suo talento, I Tell a Fly è in un certo modo il disco della consacrazione di Benjamin Clementine tra i songwriters britannici più interessanti degli ultimi tempi. I Tell a Fly è un lavoro che mescola con intelligenza le carte del mazzo di Clementine: non solo per quanto riguarda il registro timbrico che ora affianca al pianoforte e alla voce del cantante una varietà di soluzioni inusuali come synth, bassi, clavicembali e batterie, ma soprattutto perché queste novità sono supportate da una costruzione dei brani ancora più eclettica (ma non per questo meno coerente) di quella a cui eravamo stati abituati nel primo disco. Il notturno intimista di Quintessence convive spalla a spalla con le gioiose esplosioni di energia art pop di Jupiter, gli stralunati cori dall’oltretomba di Phantom of Aleppoville e il barocchismo di Farewell Sonata. Questo vortice di stilemi però non intacca la raffinatezza dei testi di Clementine, sempre a metà strada tra il surrealismo, l’autobiografia e il commento politico: insomma, I Tell a Fly è un disco pop che senza tralasciare l’orecchiabilità propria del genere osa mirare più in alto, e che perciò colpisce due volte nel segno. (Jacopo Norcini Pala)
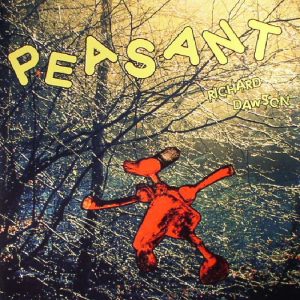
Richard Dawson – Peasant (Weird World, 2017)
Per le armonie che utilizza e il timbro molto particolare di chitarra e voce, la musica di Richard Dawson è sempre molto facile da riconoscere; ancorata al mondo del senso compiuto da una percepibile capacità tecnica, è poi libera di andare a perdersi nelle frange più sbilenche dell’avant-folk arrivando nei momenti più dissonanti a ricordare Daniel Johnston, unico artista autenticamente outsider ad aver raggiunto discreto successo di pubblico. Quando soppesiamo i vari dischi pubblicati da Dawson, perciò, è bene tenere in mente che il suo stile rimarrà una costante quasi ingombrante: le vibrazioni metalliche della chitarra, le metriche storte, i testi off-beat dallo strano sapore mondano; è solo una questione di capire quale declinazione di queste caratteristiche risulta essere la preferita di chi ascolta. Per me, la sfida è sempre stata unicamente tra Nothing Important e Peasant. Il primo è un disco dominato da due lunghissimi pezzi (Nothing Important, The Vile Stuff) con sonorità tra il folk e una sorta di alternative rock che sarebbe sciocco chiamare progressive ma che comprende comunque una complessità strutturale assente negli album precedenti, mentre il secondo è un approccio bislacco al folk inglese con influenze medievali – almeno in termini di tematiche e ambienti. Se entrambi sono comunque dischi validissimi, nell’ultimo anno sono arrivato a preferire Peasant in quanto trovo che l’attitudine un po’ fuori da tempo e stile di Dawson – non per niente ritorniamo al termine outsider – si presti molto bene a coniugare in maniera innovativa un’estetica rigida come quella dell’Inghilterra medievale, troncando alla base il rischio di dar vita a un progetto borioso. Dalla sua, Dawson ha poi il merito di aver saputo bilanciare egregiamente un disco che poteva facilmente diventare un gimmick o comunque un prodotto senza peso né potenza artistica. Peasant è invece dolce, umile, interessante ed evocativo. (David Cappuccini)

Fis & Rob Thorne – Clear Stones (Subtext, 2017)
Possiamo dire a ragion veduta che gli anni Dieci hanno dato ulteriore impulso alla musica del Quarto Mondo, ospitando esperimenti sempre più arditi nella fusione tra tribalismo e futurismo. Possiamo dire con altrettanta sicurezza che nello stesso periodo nessuna etichetta discografica come la Subtext è riuscita ad incanalare le inquietudini moderne in un percorso sonoro coerente di stupefacente sound design. Clear Stones è il punto in cui questi due universi si fondono, ed il risultato è semplicemente devastante. I multiformi sconvolgimenti elettronici di FIS si plasmano in maniera terribilmente efficace sugli strumenti della tradizione maori suonati da Thorne (corni-flauti, percussioni di pietra, fiati di conchiglia), generando una chimera che arranca pesantemente nel fango di suoni hi-tech; più questi si fanno convoluti e densi, più forti diventano i richiami primordiali emessi dalla bestia. I due contributi si compenetrano, si contaminano, diventano parte di uno stesso scenario fluido ma dalla potenza granitica. Questo disco è un computer quantico dissotterrato insieme ai resti fossili di una civiltà perduta: un cortocircuito impensabile. Ascoltare Wooden Lung per credere. (Roberto Perissinotto)

Matt Mitchell – A Pouting Grimace (Pi, 2017)
Se si dovesse scegliere un singolo artista-simbolo della eccitante scena jazz di New York di questo decennio, probabilmente Matt Mitchell sarebbe uno dei principali contendenti al titolo. Nei numerosi dischi dei principali protagonisti del jazz della East Coast cui ha partecipato come ospite illustre, e soprattutto nei suoi album da leader, Mitchell ha sfoderato una tecnica pianistica eccezionale e una scrittura visionaria, che hanno marchiato indelebilmente il suono e le forme del jazz più avant-garde degli ultimi anni. Questo A Pouting Grimace è, di tutti i suoi lavori, quello che testimonia maggiormente le sue qualità come compositore ed esecutore, e l’eclettismo della sua proposta musicale: è una raccolta di sei composizioni, pensate ed eseguite da diverse formazioni di volume variabile, che indagano sulle possibili interazioni tra strumenti a fiato e percussioni, sviluppandosi in maniera più o meno deterministica a partire da un nucleo musicale o concettuale primigenio – pur se sono obbligati a seguire precisi set di regole, agli esecutori è concesso improvvisare, rendendo i brani dinamici ed esotici nonostante la natura fissa della scrittura. A fare da introduzione, interludio e chiusura dell’album, sono posti quindi quattro brevi acquerelli elettronici per solo Prophet 6 ed elettronica. A Pouting Grimace è un disco densissimo di invenzioni melodiche, armoniche e ritmiche: i richiami sono molteplici, dal jazz dell’AACM, all’avant-prog, fino scorie e suggestioni di metal estremo, della musica modale orientale, della New Complexity, di Iannis Xenakis. È uno degli album più originali e unici di tutto il panorama jazz del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)
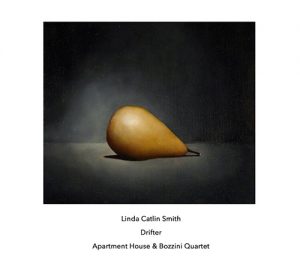
Linda Catlin Smith – Drifter (Another Timbre, 2017)
Il lavoro di Linda Catlin Smith è la dimostrazione di come la classica contemporanea possa riuscire a creare lavori realmente innovativi senza per questo perdersi nella complessità postmoderna della fine del ventesimo secolo. Così, questo Drifter propone dieci lavori per ensemble da camera composti tra il 1995 e il 2015: l’intento di Smith è quello di concentrarsi sulle invisibili relazioni armoniche tra i vari strumenti che si avvicendano all’interno dei suoi pezzi. Chiaramente influenzata dal lavoro di Morton Feldman, Drifter (più di due ore e mezza di durata) si prende il proprio tempo per esplorare le possibilità timbriche che il Quatour Bozzini e gli Apartment House sono in grado di riproporre con assoluta maestria: ecco quindi il duetto tra viola e vibrafono di Cantilena, o le linee disconnesse degli archi che si sovrappongono in Piano Quintet, in cui si rintracciano echi di jazz che farebbero pensare a un Eric Dolphy reso impotente da una massiccia dose di sedativi e al già citato Feldman. L’attacco della title-track, una esplorazione timbrica di oltre venti minuti per chitarra e pianoforte, si muove in un placido call-and-response tra i due strumenti che col passare del tempo espandono le proprie direzioni armoniche e melodiche, scambiandosi costantemente di ruolo tra accompagnatore e solista. Il lavoro della Smith è influenzato tanto dalla grande tradizione cameristica novecentesca quanto da forme tradizionali di composizione come il gagaku nipponico, o la musica rinascimentale: la conclusiva Folkestone, un quartetto per archi di oltre trenta minuti, utilizza gli incroci unisoni delle viole come farebbe un Josquin des Prez rintronato dal viaggio nello spaziotempo che l’ha trascinato nel ventunesimo secolo. La musica di Drifter è un esercizio zen di pazienza e concentrazione, in grado di ricompensare generosamente l’ascoltatore dedicato senza per questo essere minacciosa o sfiancante. (Jacopo Norcini Pala)

Stabscotch – Uncanny Valley (Visual Disturbances, 2017)
Il secondo album di questo misconosciuto trio dellʼIndiana è uno degli ultimissimi capolavori di questo decennio a muoversi in un contesto propriamente rock, per quanto sperimentale e deviata possa essere la concezione degli Stabscotch della musica rock. Uncanny Valley è infatti una aberrante mutazione genetica del rock alternativo statunitense, di cui conserva strumentazione e tecniche ma di cui modifica completamente la resa sonora iniettandovi gli estremismi (musicali e strutturali) del noise giapponese, dellʼavant-metal, delle declinazioni più assurde della nuova musica progressive, dell’elettronica più sinistra. Non si stenta infatti a riconoscere una discendenza tra numi tutelari dell’indie rock americano come Sonic Youth e Modest Mouse (la voce di Tyler Blensdorf ha un timbro inquietantemente simile a quello di Isaac Brock), ma le deflagrazioni di elettronica radioattiva, lʼincedere ritmico sghembo ed instabile, le frasi dissonanti delle chitarre, l’umore disperato convogliato da testi e musica, trasportano Uncanny Valley in una dimensione completamente nuova. Con questʼopera coraggiosissima e densa di invenzioni soniche, gli Stabscotch hanno registrato uno dei vertici indiscutibili dellʼavant-rock del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

Kyle Gann – Hyperchromatica (Other Minds, 2018)
Hyperchromatica è una raccolta di studi sulle potenzialità della musica microtonale, in questo caso declinati come composizione per “trio” di Disklavier, che agli effetti suonano come “un lungo piano da 243 tasti”. Però, stavolta, la grandezza del disco non gioca sull’esplorazione: prendendo le distanze, con i dovuti omaggi, dai suoi maestri (principalmente La Monte Young e Julius Eastman, in secondo luogo Conlon Nancarrow), Kyle Gann decide di accartocciarsi su se stesso, fare un passo indietro dall’ultima thule e godersi il maggese della semina di chi l’ha preceduto. Hyperchromatica diventa così un lavoro dichiaratamente accessibile, i rapporti che nascono al di fuori del temperamento equabile si rivelano pregni di intuizioni e concedono al pianista di spaziare dagli austeri battiti di Pulsar a brani dall’ascendente chiaramente jazz (su tutte la bellissima opening Andromeda Memories) e addirittura a sfacciati corali e pavane che vivono, a volte quasi sciogliendosi su loro stessi, dei ventagli microtonali aperti dai Disklavier. La lezione di Hyperchromatica è evidente e oggi possiamo dire che attrarre come vento il lessico dell’avant-garde, rigirarlo e imbrigliarlo sembrerebbe essere il modo migliore di attendere la fioritura del campo, mentre il resto del pianeta musicale vaga perduto nel firmamento. (Alessandro Corona)

David Garland – Verdancy (autoprodotto, 2018)
È complesso riassumere la bellezza delle quattro ore di musica di David Garland in poche righe, considerando anche quanta meraviglia e quanta comprensione in seconda – in terza, in quarta… – rinasce ad ogni riascolto del suo gioiello. Il disco è un vero e proprio oceano sonoro costellato di sonnecchianti onde di droni, di struggenti brani-pescherecce chamber folk e di piccoli e acuminati scogli elettronici-glitch-elettroacustici. La risultante è stranissima e famigliare allo stesso tempo, perché alcune delle onde nel tempo diventano anomale, e le sensazioni calde e paterne del cantautorato, quando emergono dal mare acustico si rifrangono ed esplodono con una forza esponenziale, tingendo tutto di fantasmagorico e connotando tutto di sublime. Diventa quasi d’obbligo abbandonarsi all’estasi nei picchi dell’album, reduci dal lungo e primitivo dondolare che accompagna l’ascoltatore a questi baluginii, e la parola, lo studio, la legge, cedono presto il passo allo stupore e alla contemplazione. Tra gli strumenti che tessono i minuti di Verdancy la palma del suono più bello la vince il nostro stesso sospiro. (Alessandro Corona)

Cassandra Miller – O Zomer! (Another Timbre, 2018)
Cassandra Miller è, come Linda Catlin Smith, un’altra outsider canadese della musica colta contemporanea. Allieva di Michael Finnissy, il linguaggio che ha sviluppato nelle sue composizioni è però assolutamente unico: lontana dalle asperità del suo mentore, la sua musica – spesso basata sulla trascrizione di materiale musicale pre-esistente, che viene via via modificato e infine reso irriconoscibilie – vive in un universo sospeso tra la semplicità e la ciclicità della strutture del minimalismo e i grandi spazi fuori dal tempo dell’avanguardia americana post-Feldman. Questa è la prima registrazione in assoluto della sua musica disponibile sul mercato (e fa il paio con Just So, dedicata ad alcuni suoi lavori per quartetti d’archi e uscita quasi contemporaneamente sempre per la Another Timbre), e nonostante la presenza di composizioni bellissime come la reichiana O Zomer! per ensemble o la toccante elucubrazione per solo piano di Philip the Wanderer, è il magnifico Duetto per violoncello e orchestra a proiettare questo disco tra gli eventi discografici del decennio. Presentata qui nella sua premiere del 2015 ad opera della BBC Symphony Orchestra, questa lunga composizione di oltre mezz’ora è un dialogo tra il violoncello, che introduce un tema sommesso di sole due note e lo ribadisce con minime, impercettibili variazioni per tutto il pezzo, e l’orchestra che di risposta esplode in fanfare di ottoni e in singulti d’archi, all’apparenza caotici e dissonanti ma che, alla fine, si spengono sempre su accordi consonanti con la melodia dello strumento solista, che può quindi riprendere le redini del brano. È uno dei più commoventi e innovativi rinnovamenti del formato concertistico di tutto il decennio. (Emanuele Pavia)

Niño de Elche – Antología del cante flamenco heterodoxo (Sony, 2018)
È veramente difficile e complesso riassumere in poche righe l’odissea di flamenco sperimentale che si racconta in forma bestiale e centimane nell’Antología del cante flamenco heterodoxo (nome breve), semplicemente perché ci sono dieci volte più direzioni e intuizioni diverse all’interno della mappa sonora di quante righe posso essere capace di scrivere in uno spazio limitato come questo. Niño de Elche, pseudonimo di Francisco Contreras Molina, ha recuperato con la passione di un amanuense tutta la grande tradizione del cante flamenco – in tantissime delle miriadi di salse di cui si compone il folk spagnolo – e l’ha portata alle sue forme più paradossali con la cura di un supervillain da fumetto, contorcendo e spargendo ovunque gli sviluppi di un genere musicale la cui sola origine è già abbastanza vasta da far cadere in imbarazzo la maggior parte dei sottogeneri della musica rock. Il disco non è un disco e nemmeno due dischi, è un centinaio di dischi: un trattato, una raccolta di saggi a direzione incostante e perpetua, che ragiona su tutta la storia della musica a partire dalla lente privilegiata del cante, con un impegno dispotico nel suo progresso multifattoriale e schizofrenico. Nel 2018 questo lavoro è stato un regalo totalmente inaspettato, una campagna di anni e anni condensata in meno di due ore di musica, la console di ultima generazione quando ti aspetti lo spazzolino da denti. Non posso fare un torto al parto plurigemellare di Molina condensandone ulteriormente il riassunto in un paio di paragrafi estatici, quindi vi rimando alla recensione che ho scritto a quattro mani con Emanuele e che trovate qui. Oppure eliminate qualsiasi dubbio, rimettetevi le cuffie, cessate di spizzicare ascolti a casaccio e tornate alla torre della biblioteca guardianata da Niño de Elche: passare a sfogliare uno dei grandi capolavori di questo pianeta non è qualcosa di cui ci si pente in fretta. Siate grati. (Alessandro Corona)

Prime Minister of Doom – Mudshadow Propaganda (Planet Uterus, 2018)
Nel 2018 l’artista dall’identità più misteriosa di tutta la scena elettronica ritorna con due dischi pubblicati in contemporanea, le cui copie fisiche vengono vendute in pochissimo tempo a testimonianza del largo seguito creatosi. Il più celebrato è Nothing 2 Loose, in virtù del fatto che esalta lo stile per cui è diventato riconoscibilissimo questo produttore dai molti moniker: un impianto a metà tra house e ambient con una selezione di temi melodici e sample dalla valenza fortemente emozionale – una sorta di wholesome house, se volete. Quel disco mostra però anche i limiti di questo approccio, perché quando la musica diventa troppo ripetitiva e/o poco inventiva i brani rimangono col fiato corto di fronte all’esuberanza tematica, che rischia così di diventare stucchevole. Mudhsadow Propaganda, invece, è una prova di forza in cui risalta chiaramente l’altro aspetto (meno evidente ma più decisivo) che ha permesso a quest* sconosciut* di pubblicare una miriade di lavori dallo standard qualitativo elevato per tutto il decennio; vale a dire, una conoscenza profonda delle leggi del ritmo dei più svariati ambiti della musica house dentro e fuori dal club. In questo disco c’è spazio per tutto: accenti deep, immersioni tribal, inflessioni tech, passaggi ambient, pastelli balearic, dettagli minimal. Tutto tenuto insieme da un rigore sonoro che rinsalda le fila dei vari stili e li compatta in un flusso coerente che suona come una grande lezione di estro percussivo. Rinunciando volutamente agli effetti speciali del suo “gemello” e avvolgendosi in una veste austera e senza fronzoli, Mudshadow Propaganda invita ad un ascolto attento per apprezzare la straripante creatività nascosta tra le pieghe di questi pezzi che, una volta riconosciuta, ripaga ampiamente con un fascino ipnotico. (Roberto Perissinotto)
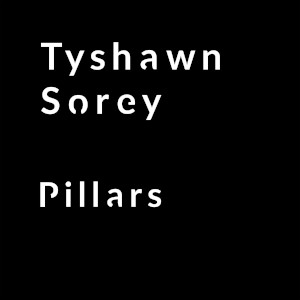
Tyshawn Sorey – Pillars (Firehouse 12, 2018)
Concepita per un ottetto comprendente tromba, trombone, due chitarre, tre contrabbassi, percussioni assortite ed elettronica, Pillars porta alle derive più estreme tutti i punti cardine dell’estetica che il batterista Tyshawn Sorey ha sviluppato nella sua carriera come compositore e band leader (e per questo, nello stilare questa lista lo abbiamo preferito ad altri grandi capolavori del suo repertorio come Verisimilitude). Pillars è un’opera che sfida il concetto di musica, silenzio, tempo: gli atomi elementari di questa composizione sono eventi sonori, soggetti continuamente a microvariazioni che ne modificano le dinamiche, il ritmo o il tempo di esecuzione, realizzati da piccoli gruppi di musicisti (in un numero variabile tra uno e quattro elementi) che si assemblano e disgregano spontaneamente. La musica sembra galleggiare su un silenzio irreale e ultraterreno, che avvolge, distorce e amplifica certi registri degli strumenti, di fatto rappresentando un altro fondamentale strumento al servizio della visione di Sorey. Pillars vive in un universo sonoro completamente suo. Non è jazz, non è classica contemporanea, non è musica elettroacustica, eppure non può prescindere da nessuno di questi mondi. È un ascolto complesso e difficile, non ultimo per il grado di attenzione che richiede fruire un lavoro del genere per quasi quattro ore filate, ma rimane uno dei massimi vertici della poetica di un compositore che, siamo sicuri, verrà ricordato come uno dei più importanti di questo inizio secolo. (Emanuele Pavia)

Ben Vince – Assimilation (Where to Now?, 2018)
Dopo alcuni tentativi, Ben Vince trova finalmente la propria voce non mettendo al centro il proprio virtuosismo da sassofonista bensì usando il proprio strumento come piattaforma su cui costruire discorsi musicali organicamente eterogenei. Così le collaborazioni che segnano i brani di questo disco sono introdotte dalle note taglienti dei suoi strilli skronkanti di sax ma aprono poi spazi per la vena esplorativa degli altri interpeti. Merlin Nova strattona la musica con interventi drammatici degni di Diamanda Galás, mentre all’opposto Mica Levi sfuma i tratteggi di Vince dipingendo tinte dream-pop dai sogni agitati; Rupert Clervaux riprogramma il panorama sonoro in una frenetica dimensione glitch-techno ossessivamente percussiva, mentre Valentina Magaletti e Cam Deas sviluppano dagli spunti di sax una sospensione tribal ambient che ricorda gli O Yuki Conjugate. Dopo aver cucito una tale amalgama di stili e direzioni, nel pezzo finale Vince può maestosamente ergersi in solo con una prova abbacinante dagli spunti minimalisti amplificati dalle manipolazioni elettroniche, chiudendo in bellezza un disco stimolante e avventuroso. (Roberto Perissinotto)

The Caretaker – Everywhere at the End of Time (History Always Favours the Winners, 2019)
Il tema del ricordo trasfigurato dalla memoria è il filo rosso di tutta l’attività di Kirby a nome Caretaker. An Empty Bliss Beyond This World era stata la rappresentazione di come nei malati di morbo di Alzheimer la musica potesse fungere da porto sicuro dei ricordi, pur danneggiata dall’erosione del tempo; una visione in fondo rassicurante, un messaggio che dice: “Non tutto è perduto”. Con Everywhere at the End of Time l’artista decide di andare più a fondo e cerca di tradurre fedelmente in musica l’esperienza di chi scivola nel baratro della demenza, una delle esperienze di malattia più disumanizzanti. La musica appare di nuovo come appiglio di un’identità, ma si confronta con una memoria che fallisce ripetutamente e deteriorando distorce il ricordo; la reazione è uno sforzo tantalico di recuperare i frammenti del proprio io ma così facendo si accentuano le mancanze e le incongruenze, arriva la confusione di fronte all’impotenza ed infine il panico della consapevolezza, che paradossalmente trova nella resa del sé una nuova calma abissale. L’esperienza dell’ascoltatore arriva (per quanto possibile) ad essere parallela a quella del malato: i sample iniziali sono perfettamente congruenti con il nostro ricordo della musica di Kirby ma procedendo con l’ascolto le dissonanze iniziano ad uscire dai solchi, le ombre dei disturbi e delle interferenze si allungano su una musica che si inceppa, si perde, muta e si disfa inesorabilmente fino ad assumere forme inafferrabili e oscure. Questa fortissima identità tra esperienza di ascolto ed esperienza rappresentata non sarebbe possibile senza la grande creatività di Kirby, finora apprezzata nella manipolazione audio ma mai così evidente nella generazione di nuovi contesti sonori. Nell’affrontare un’esperienza così dolorosa e profonda riesce a far compiere alla propria musica una evoluzione tanto poderosa quanto efficace, rendendola più che mai carica di sottigliezze e presagi fino a spingerla magistralmente in una landa di droni e rumore senza luce. La grandezza della musica di per sé e la sua contemporanea capacità di veicolare immediatamente una delle più sconvolgenti esperienze umane rende probabilmente Everywhere at the End of Time l’opera di musica elettronica più ambiziosa e riuscita di questo decennio. (Roberto Perissinotto)

Denzel Curry – ZUU (Loma Vista, 2019)
Per chi non è cresciuto insieme al genere, l’avvicinamento al mondo trap può essere doloroso. Nelle sue coniugazioni più frivole i testi sono vacui come quelli del gangsta rap più becero, i flow pietosi e tutto è improntato ad azzeccare un hook orecchiabile che riesca a portarti in cima alle classifiche. Denzel Curry è sempre stata una grande eccezione da questo punto di vista, e anche nei suoi pezzi meno brillanti ha consistentemente ricoperto il ruolo di traghettatore per chi era abituato a un altro tipo di aggressività e abilità lirica. Se il suo disco precedente (TABOO) era un progetto ambizioso che però risultava essere piuttosto disomogeneo per qualità dei pezzi, ZUU è una bomba a mano di trenta minuti che non rallenta neanche per un secondo, come sempre fermamente legata a quell’approccio rancido al southern rap tra Miami e Memphis. Le atmosfere non sono diaboliche, anche se diabolica è l’energia con cui Denzel macina i versi in brani come Birdz o P.A.T. ; il replay value è infinito in quanto ogni canzone contiene un hook irresistibile (Ricky, Shake 88) oppure una costruzione del pezzo fresca e creativa (Wish, Speedboat). ZUU è un disco votato al divertimento: tutta l’aggressività di Denzel è impiegata solo per coivolgere chi ascolta e aizzarne l’entusiasmo. Chi cerca un hip hop riflessivo o profondo può girare la testa verso altri lidi, ma chi desidera una sequela di bangers che gli faccia definitivamente digerire la trap non ha scelta migliore in questi ultimi anni. (David Cappuccini)

- Quinsin Nachoff’s Flux – Path of Totality (Whirlwind, 2019)
Path of Totality del sassofonista Quinsin Nachoff, nato in Canada ma di base a New York, si pone idealmente come riassunto di dieci anni di tendenze innovative che hanno cambiato radicalmente la scena avant-jazz della East Coast. Ispirato dall’eclissi totale di luna del 2017, che Nachoff ha ammantato di metafore estetiche e politiche, questo album è un profondo studio sull’implementazione di schemi matematici in composizioni dal respiro essenzialmente contemporaneo. Come avveniva in A Pouting Grimace di Matt Mitchell (qui in una delle sue performance più stupefacenti al pianoforte e a tastiere di vario genere), ogni brano trova il proprio nucleo di partenza da un’idea o da un concetto (che può provenire dallo studio del moto di una palla che rimbalza, o dalle orbite descritte dai pianeti nella galassia, o dall’eredità culturale di John Cage, o ancora dal turbolento clima politico americano), che determina l’umore o l’evoluzione del pezzo; è compito dei diversi musicisti e dei numerosi ospiti, quindi, sviluppare tali nuclei in maniera imprevedibile e altamente non lineare, destreggiandosi tra sezioni scritte, assoli in solitaria e lunghe improvvisazioni collettive. È un album unico, eccentrico e creativo, straripante di soluzioni, tecniche e arrangiamenti fantasiosi, con un’aura che non ha molti termini di paragone con altri dischi jazz contemporanei; per tutti questi motivi, va collocato nella stessa categoria dei migliori dischi dei vari Steve Coleman, Steve Lehman, Rudresh Mahanthappa, Matt Mitchell e Tyshawn Sorey che hanno definito il suono del jazz più sperimentale di questo squarcio di millennio. (Emanuele Pavia)
Questa lista, come ogni altra lista e classifica, è stata ovviamente frutto di compromessi tra le diverse voci di Björko Dio. Per questo, abbiamo deciso di inserire per voi anche alcune delle nostre scelte individuali che per un motivo o per un altro non sono riuscite ad apparire in chart, ma che tutti noi ci tenevamo comunque a ricordare in un post che celebra il meglio dei 2010s.
Alessandro:
- Richard Dawson – Nothing Important (Weird World, 2014)
- James Holden & The Animal Spirits – The Animal Spirits (Border Community, 2017)
- Benjamin Clementine – At Least for Now (Virgin EMI, 2015)
- Impossible Nothing – Lexemenomicon (autoprodotto, 2017)
- These New Puritans – Field of Reeds (Infectious, 2013)
- Cosmo Sheldrake – The Much Much How How and I (Transgressive, 2018)
- Roy Montgomery – R M H Q: Headquarters (Grapefruit, 2016)
- Natural Snow Buildings – The Centauri Agent (Vulpiano, 2010)
- Joanna Newsom – Divers (Drag City, 2015)
- Zoë Mc Pherson – String Figures (SVS, 2018)
- LAKE R▲DIO – Hypoxia (Endless Field, 2012)
- Joe Hisaishi – Kaze Tachinu Soundtrack (Studio Ghibli, 2013)
- Ideal Bread – Beating the Teens: Songs of Steve Lacy (Cuneiform, 2014)
- Oneohtrix Point Never – Garden of Delete (Warp, 2015)
- Tropical Fuck Storm – A Laughing Death in Meatspace (Joyful Noise, 2018)
David:
- The Brave Little Abacus – Just Got Back From the Discomfort—We’re Alright (autoprodotto, 2010)
- tUnE-yArDs – Whokill (4AD, 2011)
- The Field – Looping State of Mind (Kompakt, 2011)
- Uochi Toki – Macchina da Guerra (autoprodotto, 2013)
- Wadada Leo Smith / Jamie Saft / Joe Morris / Balázs Pándi – Red Hill (Rare Noise, 2013)
- Blue Willa – Blue Willa (Trovarobato, 2013)
- Richard Dawson – Nothing Important (Weird World, 2014)
- These New Puritans – Field of Reeds (Infectious, 2013)
- Christian Scott – Christian aTunde Adjuah (Concord, 2012)
- DVA – Botanicula (autoprodotto, 2012)
- Dos Monos – Dos City (Deathbomb Arc, 2019)
- JASSS – Weightless (iDEAL, 2017)
- Joshua Abrams – Magnetoception (Eremite, 2015)
- Johnny Mox – Obstinate Sermons (Woodworm, 2015)
- Nicolas Jaar – Space Is Only Noise (Circus Company, 2011)
Emanuele:
- Tyshawn Sorey – Verisimilitude (Pi, 2017)
- Steve Lehman Octet – Mise en Abîme (Pi, 2014)
- Matt Mitchell – Phalanx Ambassadors (Pi, 2019)
- Friedrich Cerha – Spiegel; Monumentum; Momente (KAIROS, 2010)
- Chaya Czernowin – Maim (Water) (Mode, 2010)
- Christian Scott – Yesterday You Said Tomorrow (Concord, 2010)
- Peter Evans Quintet – Genesis (More Is More, 2016)
- Murcof & Philippe Petit – First Chapter (Aagoo, 2013)
- Fred Ho and the Green Monster Big Band – The Sweet Science Suite: A Scientific Soul Music Honoring of Muhammad Ali (Big Red Media / Mutable Music, 2011)
- Wolfang Mitterer – massacre (Col Legno, 2010)
- Lumen Lab – They Are Killing Us (Aagoo, 2016)
- Dälek – Untitled (Latitudes, 2010)
- Alex Sipiagin – Destinations Unknown (Criss Cross, 2011)
- Kaija Saariaho – True Fire; Trans; Ciel d’hiver (Ondine, 2019)
- Michael Pisaro – A Mist Is a Collection of Points (New World, 2015)
Jacopo:
- Africa Express – Africa Express Presents… Terry Riley’s In C Mali (Transgressive, 2014)
- Fiona Apple – The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do (Clean Slate, 2012)
- Bill Callahan – Dream River (Drag City, 2013)
- Benjamin Clementine – At Least for Now (Behind, 2015)
- Darkside – Psychic (Matador, 2013)
- Michael Gordon – Dystopia (Cantaloupe, 2015)
- Stephan Meidell – Metrics (Hubro, 2017)
- Murmur –Murmur (Underground Activists, 2014)
- Thee Oh Sees – Carrion Crawler / The Dream EP (In the Red, 2011)
- Austin Peralta – Endless Planets (Brainfeeder, 2011)
- Cosmo Sheldrake – The Much Much How How and I (Transgressive, 2018)
- Torche – Harmonicraft (Volcom, 2012)
- Tanya Tagaq – Retribution (Six Shooter, 2016)
- Mary Halvorson –Code Girl (Firehouse 12, 2018)
- Deadbeat – Drawn and Quartered (BLKRTZ, 2011)
Roberto:
- Richard Dawson – Nothing Important (Weird World, 2014)
- Steve Lehman Octet – Mise en Abîme (Pi, 2014)
- Demdike Stare – Testpressings (Modern Love, 2016)
- Murcof x Wagner – Statea (InFiné, 2016)
- Nate Wooley – Argonautica (Firehouse 12, 2016)
- Wolf Müller & Cass. – The Sound of Glades (International Feel, 2016)
- Luzia Von Wyl Ensemble – Throwing Coins (Hat Hut, 2018)
- Mombu – Niger (Subsound, 2013)
- Ruggine – Iceberg (V4V, 2014)
- Uochi Toki + Nadja – Cystema Solari (CORPOC, 2014)
- The Body – All the Waters of the Earth Turn to Blood (Aum War, 2010)
- Cosmo Sheldrake – The Much Much How How and I (Transgressive, 2018)
- Sadaf – History of Heat (Blueberry, 2019)
- Çaykh – Amateur Exorcist 001 (Amateur Exotic, 2017)
- JPEGMAFIA – Veteran (Deathbomb Arc, 2018)





